
Si ripropone qui la recensione apparsa con lo stesso titolo nella rivista di Ennio Abate Poliscritture; v.a. 1° aprile 2024.
Lo sguardo delle donne
Nei volumi collettanei la pluralità di approcci è istituzionale, la disomogeneità dei risultati inevitabile, così il lettore sente persino più autorizzata la propria libertà di scelta. Nel libro che ha preso spunto - afferma la quarta di copertina - dal convegno della Società Italiana delle Letterate, tenutosi a Venezia nel dicembre del 2019, a mio parere il luogo fondo, quasi un fuori scena da cui meglio vedere la linfa dei percorsi plurimi si trova un po’ decentrato: Scrittrici o venditrici? Un dialogo a distanza fra Giulia Caminito e Chiara Ingrao durante il lockdown del 2019.
È, si potrebbe dire in termini teatrali, una scena perfetta. Non è certo una novità che la reclusione obbligata dall’infuriare della pestilenza sospinga, in certe aree dell’umano, alla risorsa di ultima istanza che sempre è la letteratura, condizione in qualche modo antropologica, il cui archetipo e acme nella nostra lingua è il Decameron. Ma, nel nostro caso, la mossa propria dello sguardo femminile muta il paradigma.
La sospensione, imposta dalle autorità sanitarie, provoca uno strappo, che la coazione capitalistica alla produzione di valore sente intollerabile, così chi, come la giovane Caminito, ne è stata strumento e fruitrice, è messa di fronte a se stessa: “in due mesi io ne ho fatti anche cinquanta [di presentazioni], partendo più volte a settimana e trovandomi in affanno e in confusione, a parlare dei miei libri a mitraglia, senza sosta, spesso senza ricordarmi neanche a chi. Ho visto troppo in troppo poco tempo e ho parlato troppo di me e dei miei libri nel giro di poche giornate. Ho sentito di doverlo fare, di dover essere performer della mia scrittura, di dover dare a chi mi ascoltava motivo per comprare il mio libro e comprarmi. Quindi ho sviluppato un’ossessione sulla riuscita degli incontri, dal fatto di dover sempre cambiare le cose dette, dagli approfondimenti, dalle letture, dalle domande delle persone, tanto che questa concentrazione mi ha fatta ammalare” (145).
L’obbligata immobilità costringe a vedere il silenzio del rumore e il vuoto dell’affollamento, ma lo sguardo riguadagnato trova la forza di spostarsi alle spalle dell’atto letterario, d’interrogare se stessa e di farlo trovando la voce complice di altra autrice e di una precedente generazione. È proprio il partire da sé e il suo essere inseparabile dall’altra, che a me pare gesto decisivo, fertilissimo. Naturalmente, nella dialettica sé-altra non c’è nulla di irenico, come con grande lucidità riconoscono le due scrittrici, coraggiosamente confrontandosi su invidie e frustrazioni; né potrebbe essere altrimenti, pena ridurre il tutto a pappetta ideologica.
La scena, si diceva, del silenzio si anima di nuova autoconsapevolezza, perché la solitudine è ribaltata in azione comune. È proprio questo che io, ammirato, invidio alla capacità delle donne di conservare e alimentare, lungo le nervature sociali e geografiche, gruppi, canali di relazioni, discussioni, produzioni non ossificate nell’accademia. È indubbio segno di vitalità e di speranza che la riflessione sul sé sfugga all’ossessione narcisistica della nostra epoca, che la parola sappia diventare scelta e azione condivisa.
Rientra in questa linea di condotta il considerare, come viene fatto nei vari saggi, la letteratura come documento e specola di vita, qui, in particolare, vita contemporanea sul lavoro, oggetto dichiarato dal titolo: Visibile e invisibile. Scritture e rappresentazioni del lavoro delle donne (a cura di Laura Graziano e Luisa Ricaldone, Iacobelli, Guidonia 2024). Il panorama che ne emerge è assai ricco sia per le voci resocontate, sia per il profilo inevitabilmente crudo che del lavoro delle donne e degli uomini viene restituito realisticamente. Dunque, è uno strumento da portarsi dietro per far luce su una parte dell’orrore che chiude il nostro giorno.
Tra i vari saggi, quello che più di altri mi sembra paradigmatico di un rapporto vitale e militante con la letteratura è quello di Luisa Ricaldone: Il lavoro, la vita. Un percorso nella narrativa giapponese. Con l’eleganza e la chiarezza, che diresti settecentesca, si conduce chi legge tra le pagine dei romanzi contemporanei giapponesi nei quali le forme di vita orientali si colorano delle sofferenze, delle sopraffazioni, degli spaesamenti che sono anche i nostri, a conferma della globalità dei fenomeni. In questo saggio ritrovi quella confidenza con la narrativa, quel sentirla parola viva che la studiosa ha esemplarmente messo in opera nel recente Tra le pagine della fame. Un viaggio letterario (SEB27, Torino 2023), dove l’esperienza della lettura, ovvero la sua portata affettiva, conoscitiva e illocutoria è esplicitamente ricondotta alla vissuta radice personale e familiare, dunque sociale.
Maria Vittoria De Filippis
In margine a una terzina
Io fui toscano e nacqui in mezzo al bosco
Velso Abati contadino è mio padre
non so se ’l nome suo già mai fu vosco.
È senz’altro il più breve scritto di tutta l’opera dell’autore. Ma, per quanto all’apparenza un breve scherzo, molto dice di Velio Abati e di tanto altro.
Il primo elemento notevole è l’uso dei tempi verbali: impiega per sé il passato, mentre per il padre il presente, ossia il contrario di quanto ci si sarebbe aspettati. È la presenza viva e centrale del padre che dà senso e significato anche al figlio e alla sua opera. Velio dà voce al padre, alla sua esistenza, alle sue sofferenze.
Il mondo contadino è il mondo di Velso e, di conseguenza, anche di Velio, che nasce in mezzo alla natura ("in mezzo al bosco"). Si faccia attenzione a come il tempo verbale distanzi l’evento in un passato remoto (“nacqui”). Lo stesso suo essere toscano è determinazione locale abbandonata in vista di uno sguardo universale (“fui toscano”).
Velio mette al centro di tutto il padre, si preoccupa e si chiede se il nome del padre sia presente anche per noi lettori, ricorrendo, si badi, all’antica forma di derivazione latina “vosco”, come nella terzina dantesca, di cui questa è rifacimento, con una mossa scopertamente ironica che sfocia nella reinvenzione. Ciò che è lontano è vicino, ciò che è vicino prende senso e valore da tempi più o meno lontani. Il sommo poeta Dante si dispone accanto al contadino Velso, medesima la funzione di compagno e maestro.
In tre versi il senso della Storia, del valore dell’insegnare e del mondo contadino diventato oltre che reale allegorico.
Nel farlo, Velio descrive nella propria opera le sofferenze della vita contadina fatta emblema di altro, ma mai in astratto o per ideologia, sempre rappresentando e dipingendo il proprio vissuto in maniera profonda, persino viscerale.
Una sola terzina è insieme prologo alla sua opera e vademecum, viatico civile e intellettuale al suo lettore.
7 febbraio 2024

Si ripropone qui la recensione apparsa con lo stesso titolo sul n.31 (gennaio 2024) di "Nautilus" ; v.a. 3 gennaio 2024.
Il serpe si spella dalla coda
In altre epoche, quando lo spirito del tempo – volgarmente: le idee dominanti – prescriveva alle visioni l’aspirazione al sublime dello spirito, strappo corrosivo era dire “sogno di una cosa”. Qual è la mossa oggi, quando dirci nella civiltà dell’immagine è persino volgare constatazione? Anche le aule scalcinate delle nostre scuole, luoghi preposti alla lezione, che sappiamo voler dire ‘lettura’, sono sovraccariche da tempo di monitor, schermi e altri immaginifici congegni– e i soldi comandati del PNRR non poco contribuiscono al già carico deposito dei ‘dispositivi’ fuori uso. Non solo non c’è lezione non accompagnata, quando non sostituita, da immagini, ma il prodotto stesso del discente ricalca la medesima via. In altre parole, seguiamo la strada inversa spiegata dalla scienza semiologica: non è la lingua a tradurre l’immagine, ma l’immagine che sostituisce la lingua.
In quest’epoca di visioni, la visione, nelle sue varie sfumature di desiderio, speranza, senso, progetto di ciò che ancora non c’è, si colora della concretezza apparente dell’immagine visiva, inducendo continui slittamenti su due strade opposte, che approdano al medesimo autoinganno: o, aggrappandosi alla faccia non-reale, se ne esalta insensatamente la forza contestativa quand’è in realtà semplice variante dell’esistente; oppure si scommette a vuoto sulla sua concretezza, al punto che il desiderio di un’altra realtà è già appagato dalla pura produzione del sogno.
Certo il processo non è frutto solo della dinamica dell’immaginario, perché l’umanità non ha cessato la fatica di produrre le proprie condizioni d’esistenza, anzi in questo sudore affondano le radici della comunicazione e dell’immaginario, ma sappiamo quanto rilievo ha ciò che l’uomo e la donna pensano di se stessi.
Il dominio dell’immagine nella nostra epoca globalizzata è sollecitato anche da un altro elemento: a differenza della lingua, che ha bisogno di un apprendimento faticoso, essa si presenta immediatamente comprensibile. Non solo, ha una potente capacità sintetica – un’immagine, si dice, vale più di cento parole. Lo sapevano bene già i chierici medioevali, che sopperivano all’analfabetismo dei fedeli e al loro divario linguistico con le immagini alle pareti delle chiese. Nelle nostre aule, proprio su questo fanno leva gl’ipertesti, cercando di far fronte, nello stesso tempo alimentandola, alla difficoltà di concentrazione, di analisi, di memoria.
Se la falsa concretezza dell’immagine agevola l’inganno, dando l’impressione di essere la realtà, la sua forza sintetica non allena l’analisi, la fatica delle connessioni e invece sollecita prepotentemente l’emozione. Non è forse anche in questa diseducazione profonda, la risposta alla sorpresa di chi, questi giorni, ha osservato che il nuovo presidente argentino Milei ha ricevuto il voto proprio da coloro ai quali ha francamente promesso di rendere la loro vita ancora più infernale?
Due altri costitutivi sociali segnano direttamente o indirettamente la nostra civiltà dell’immagine. A dispetto della dimensione sempre più rarefatta con cui la realtà si presenta agl’individui, la nostra rimane una civiltà materialista, anzi materialona, intesa come valore e come ovvietà. Un’urgenza di materialità che include anche campi per secoli di stretta pertinenza linguistica, come accade con la graphic novel e che, mentre è sottratta e quasi annichilita la realtà della relazione sociale e umana tra persone, viene riversata nel virtuale, fino a provocare, nei più esposti per fragilità e anni, le nuove patologie del ritiro nella stanza, del bullismo virtuale e così via.
Il fenomeno è tanto profondamente e vastamente intrinseco alla nostra civiltà globale, che il più innovativo capitalismo mondiale ha trovato modo di estrarre il profitto da tale realtà di secondo livello caotica, emotiva, istintuale, occasionale, attraverso il più astratto razionalismo matematizzante, condensato negli algoritmi e nelle sinapsi meccaniche dei calcolatori. L’abisso che separa le due dimensioni è vasto quanto quello di potere, conoscenza e ricchezza tra la moltitudine della prima e i pochissimi della seconda.
Un altro costitutivo, in questo trentennio di dominio liberista diventato ovvio fino ad annullarne la percezione per la cancellazione del suo contrario, è la dimensione esclusivamente individuale di ciascuna persona. Le conseguenze sono talmente numerose che è persino difficile darne un’esemplificazione significativa, perché amputare l’animale uomo del suo essere polìtes come dicevano nelle pòleis greche, significa amputarlo anche del legame con le generazioni precedenti, che non sia brutalmente biologico, ossia sottrarre al tempo la storia, quindi ridurre la complessità del flusso del tempo a inerte succedersi di attimi: a un eterno presente.
La strada che abbiamo davanti non è quella breve di recuperare a visione il significato di conoscenza, che ne aveva dato Platone, ma quella assi più complicata e dolorosa di principiare dalla coda: praticare insieme con gli altri il nostro non essere un individuo solo.

Si ripropone qui la recensione apparsa sul n.336 dell'Immaginazione, con titolo diverso, pp.52-3; v.a. 28 luglio 2023.
Il saggio come pratica didattica
su Il caviale e i fichi. Scritti di letteratura, di Donatello Santarone
In certi libri di critica riesci a scorgere l’autore solo di sbieco, perché si sforza d’allontanarsi il più possibile dietro la pagina: per lo più lavori di chi aspiri ai metodi delle scienze; in altri invece l’autore ti si para di fronte e sono quelli che guardano al genere che chiamiamo saggistico. L’opera di Donatello Santarone appartiene a un’area estrema di quest’ultimo genere. Insegnante di Letteratura e storia negli Istituti tecnici prima, quindi docente universitario, del saggismo enfatizza, nelle forme e nelle scelte, la funzione pedagogica e didattica, cosicché chiarezza espositiva, salvaguardia della circolazione delle opere e divulgazione sono aspetti costanti del suo lavoro critico. Dalle giovanili conversazioni radiofoniche sulla letteratura italiana con Franco Fortini per il terzo programma Rai, poi confluiti in due pubblicazioni con la Bollati Boringhieri (Dialoghi col Tasso, 1999 e Le rose dell’abisso. Dialoghi sui classici italiani, 2000), alla curatela di edizioni fuori commercio come il volume di Fortini, Asia maggiore. Viaggio nella Cina e altri scritti (prefazione di Edoarda Masi, Manifestolibri, 2007) e l’ampio lavoro di Siegbert S. Prawer. Karl Marx e la letteratura mondiale (Boreaux, 2021), fino alla curatella della raccolta della lunga attenzione fortiniana di Pier Vincenzo Mengaldo (I chiusi inchiostri. Scritti su Franco Fortini, Quodlibet, 2020). Mentre la ricca produzione in proprio è sempre pensata per un lavoro didattico, sia esso indirizzato alla scuola media, come, tanto per fare due esempi distanti, Il cittadino e il mondo, pubblicato con Mario Gay per Laterza, 1995 e il più recente Trepido seguo il vostro gioco. Antologia di sport e letteratura, per la Zanichelli, 2015, o siano i numerosi saggi destinati all’insegnamento universitario.
Nell’attuale clima della cultura e della formazione, sottoposto dal finanzcapitalismo, come già scriveva David Harvey nel 1990, al “travolgente senso di compressione dei nostri mondi spaziali e temporali”, in cui il consumo della vita è anche fagocitazione di ogni patrimonio tecnico, scientifico e culturale, non è certo merito secondario di Santarone rimanere fedele a una parte, gli sfruttati e i subalterni della Terra, e a una strumentazione, il marxismo, da cui guardare alla complessità, apparentemente caotica, dei travolgimenti violenti dell’oggi. Quella fedeltà, infatti, è già di per sé un atto e un’indicazione di controtendenza, mentre la pratica di una certa strumentazione marxista permette un confronto serio, non estemporaneo con le sue ricerche anche a chi parta da presupposti differenti.
La scelta degli otto saggi ora raccolti in Il caviale e i fichi, riproposti da un arco temporale che va dal 2005 al 2022, è paradigmatica. Già le genettiane “soglie” dei volumi sopra citati mostrano con chiarezza il maestro primo, Franco Fortini, che orienta gli assi della ricerca santaroniana. Si nota di passaggio che la passione didattica porta l’autore a un interesse particolare per il “paratesto” del volume, tanto quello oggetto del lavoro critico quanto quello in proprio: lo stesso titolo dell’attuale raccolta è desunto da Fortini. Dietro le orme del suo Virgilio, Santarone risale a Marx, a Gramsci, a certe letture della tradizione marxista degli anni del secondo dopoguerra, Lucács più che Adorno, Brecht, la Cina e poi i contemporanei e sodali Pier Vincenzo Mengaldo, Edoarda Masi, Cesare Cases. La stessa centralità dell’azione didattica trova in Fortini un ispiratore, nella presente raccolta più direttamente esemplificata dalla scelta compiuta dalla produzione zanzottiana con il saggio Poesia e Pedagogia nell’opera di Andrea Zanzotto.
Sempre da Fortini trova alimento l’attenzione a quello che, nella stagione della formazione dell’autore, si chiamava Terzo Mondo. Non a caso un libro fortiniano spesso citato è l’antologia Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia di domani (Laterza, 1965). Di qui la scoperta della goethiana Weltliteraturen e lo studio della letteratura africana e postcoloniale, esemplificata ora nei saggi su due scrittori (“Cittadina di seconda classe” di Buchi Emecheta e “Sozaboy” di Ken Sar-Wiwa). Di qui l’attenzione costante alla interculturalità, vieppiù cogente e irta di sopraffazioni, sfruttamento, conflitti in un presente tanto segnato da crescenti emigrazioni bibliche inter e transcontinentali per fame, guerre e sconvolgimenti climatici, quanto connesso, a tacer d’altro, da piattaforme informatiche che, interrogate, scrivono risposte originali assemblando lavoro semiservile dalle periferie africane, asiatiche e americane. Interculturalità qui presente nel resoconto degli studi su Dante e la cultura arabo-islamica.
La guida di Fortini è importante anche per l’adozione convinta del metodo saggistico, che lo porta a continui ricongiungimenti del testo con l’estratesto, condotti con l’energia dell’intelletto e il candore della didattica, mirando sempre a una comprensione storica e sociale a tutto tondo.

Si ripropone qui la recensione apparsa sull'Indice di luglio-agosto 2023, p. 22; v.a. 8 luglio 2023.
Sull'Amaca
a proposito di Quarantotto poesie e altri disturbi di Cristina Alziati
L’energia che spinge Alziati alla parola sorge dalla contraddizione. Due sono le parole chiave del suo ultimo libro, quelle che accertano il qui e ora da cui la voce poetante muove: “notte” e” nessuno”. Eppure, in tale condizione d’afasia, non cessa di rampollare, con la forza del bios e della ragione, la poesia. Malgrado la deriva della derealizzazione affianchi costantemente la pagina, vedi viva all’opera l’opposta necessità di concretezza e di ordine logico, che non si stanca di cercare un orizzonte di senso di cui non solo si sente la necessità vitale, ma si ha profonda convinzione che, sebbene oscurata, esista. Da qui nasce che quella di Alziati è una poesia morale, anzi, politica nel senso più profondo, dove guerre, violenza sui migranti, riscaldamento terrestre sono centrali. E notevole è la sezione L’impostore, titolo che echeggia l’ “’Imbianchino” di Brecht.
Non pensi però il lettore di trovarsi di fronte a proclami o poesie filosofiche. La parola prende avvio da un accertamento di realtà, in presa diretta, siano dati dell’ambiente: “I favolosi nuvoli e i germogli / e i rovi esistono”, ecc.; siano eventi personali: “Saliamo io e Sofia sul Monte Stivo”, ecc.; oppure fatti di cronache: “La radio annuncia che la VI flotta”, ecc. Solo dall’esposizione ordinata di fatti e circostanze scaturisce la riflessione finale che – ancora un movimento antitetico – porta la ragione a constatare, a descrivere la loro assenza di senso. La predilezione di Alziati per la brevitas in chiusura dà spesso luogo all’incisività dell’ultimo verso: “Finzione il rovescio del cielo”, “fra il Tigri e l’Eufrate, l’aria dov’è?”, “e io resterò dove sono, altrove”, ecc.
Incontriamo qui la voce più chiara e feconda della poesia di Alziati. La tendenza costante a raffreddare, a negare accesso al patetico, che notte e solitudine sempre alimentano, però quanto più si esercita la tenacia dell’adesione ordinata a fatti e circostanze, tanto più essi mostrano che il loro “ordine” è privo di senso, che solo il “disordine” che lo smantella ne è portatore: “ascolto / il suono del disordine / erompere nell’ordine un istante”. E non è affatto arbitrario leggere in quella pronuncia, “ordine”, il significato pregnante di ‘ordine costituito’. Che non si tratti di una forzatura critica, lo conferma più d’una dichiarazione di poetica di un’autrice di forte impronta razionale, cui certo non difetta consapevolezza del proprio operato e del proprio essere intellettuale. Le cose sono messe in chiaro fin dal secondo dei tre componimenti proemiali, L’amàca: “Oltre la notte dondola / fra luce e buio la mia amàca / tesa ai margini acuti di grazia”. Non v’è dubbio che “l’amàca” – strumento del piacere, del benessere e della consolazione - sia la poesia e non sfuggirà come, ancora una volta, si scelga per designarla un oggetto prossimo, quotidiano, concreto. La “grazia” non è solo bellezza, è anche l’armonia degli uomini e del mondo. È nei “margini” perché ‘sull’altra sponda’, come ricorrentemente viene detto, sono “acuti”, perché quella “grazia” non raggiungibile quanto necessaria non può che provocare dolore. Una sofferenza che si presenta variamente articolata nell’opera. La poesia è dunque, come “l’amàca”, nella sospensione, nel vuoto, che inevitabilmente la ricognizione del mondo storico-sociale e ambientale mostra.
L’istanza razionale agisce tanto nella costruzione dei singoli testi, quanto, a maggior ragione, del libro, più che raccolta. Se guardiamo ai singoli testi, siano essi privi di divisione strofica o ne presentino, vi vediamo due costanti: la struttura a cerchio del componimento, tramite ripresa semantica e rimica, in chiusura, di elementi d’apertura, che risponde a un’esigenza di ordine costruttivo e al contempo di sottolineatura argomentativa; la tendenza alla conclusione gnomica, accompagnata dalla brevità metrica e sintattica, che in ultima sede dà luogo a versi brevi o brevissimi e, più frequentemente, enfatizza la chiusa dell’’ultimo verso tramite la pausa interpuntiva seguita da un breve elemento sintattico a suggello di ritmo e senso: “”e io resterò dove sono, altrove.”, “ha le dita di giunco, cammina.”, “(L’ultimo verso non concilia, stride”), ecc.
Numerosi sono gli omaggi espliciti o impliciti ad artisti e poeti, anche con propria traduzione. Centrale il maestro Fortini, incluso con un testo. Di grande intensità affettiva e intellettuale la presenza della figlia Sofia, cui il libro e un’intera sezione sono dedicati.
Per Roberto Bongini
Velio Abati
Sulla differenza
1. Ho ascoltato Maria Luisa Boccia presentare il suo Tempi di guerra. Riflessioni di una femminista, in cui ha diversamente articolato il concetto di differenza, intesa come funzione euristica e criterio di valore, quindi regola di condotta pratica, cosicché la differenza è in vista dell’ibridazione. Oltre al più noto campo dei generi sessuali, l’applicazione del paradigma ha riguardato due ambiti critici del presente: i migranti e la guerra.
Il concetto della differenza combatte in entrambi la disumanizzazione dell’altro. Inoltre, per il postulato morale e gnoseologico della dignità della persona da cui muove, nel caso dell’accoglienza del migrante scarta anche l’argomento economicista e capitalista della necessità della forza lavoro, il suo principio oltrepassando ogni determinazione economica, una posizione in questo prossima al magistero di Francesco I; nell’altro, il rifiuto della guerra è praticato non solo contro la costante politica statunitense – e in special modo democratica – della guerra giusta, ossia dell’esportazione della democrazia a mano armata e contro l’espansionismo difensivo di Putin, ma anche contro l’indifferentismo della Cina, secondo la quale ogni Comando statale è legittimato a condurre, entro i propri confini, qualunque forma di governo fino alla riduzione in schiavitù di un sesso, di un’etnia o di una religione.
2. Se lo si situa nella storia, questo paradigma concettuale mostra una coppia antitetica, identià / differenza, che può essere utilmente confrontata con una sua antenata, fanatismo / tolleranza. Guardiamo il primo termine oppositivo.
Identità. Osservando dall’aggressività verso il migrante, risulta palese come l’identità sia giocata a partire dalla paura di arretrare, avvertendo la precarietà del proprio potere. Non a caso, tale postura è politicamente reazionaria, secondo una dinamica ben descritta in altra epoca da Pierre Bourdieu. Ma tale natura difensiva è confermata se scorriamo lo sguardo dal basso dei nazionalismi delle democrature italiana ed est-europee, all’alto della politica estera statunitense, qui con l’aggiunta paradossale di essere soprattutto condotta dal Partito democratico, sull’orlo di una guerra civile con il reazionario, ma isolazionista, Partito repubblicano.
Fanatismo. Che il fanatismo dell’ancien régime condivida con l’attuale identitarismo il furore aggressivo di chi vive la propria sconfitta non abbisogna di particolari approfondimenti ed esemplificazioni.
3. Il raffronto si fa più interessante guardando al secondo termine.
Tolleranza non è solo lo scudo difensivo contro chi, ancora, è in posizione di comando; è anche l’espressione chiara, vorrei dire l’ostentazione, della consapevolezza della propria superiorità. Il concetto, infatti, rivendica a sé la razionalità - universale per principio - contro l’irrazionalità denunciata come intransitiva, sia sul piano conoscitivo che su quello pratico, in fin dei conti legittimata solo dalla legge del più forte. Inoltre, la tolleranza nell’accettare il diverso - che, in quanto tale, è in qualche parte defettivo di universalità – gli concede sul piano pratico l’esistenza solo perché e fin che essa si sente in posizione di comando.
Nelle pratiche imperialiste, al diverso sono stati proposti due differenti destini: pensandolo, o volendolo immodificabile, lo si è lasciato vivere nella sua propria condizione inferiore (lo pseudomulticulturalismo britannico); pensandolo transitorio, gli si è imposto illuministicamente la propria ‘modernità’ (l’assimilazionismo francese); gli Usa, figli nella loro ideologia politica dell’Illuminismo, hanno seguito questa strada utilmente congiunta, con le vicende storiche del secolo scorso, al dominio imperialista.
Differenza. Paradigma concettuale affermatosi sul declino della modernità novecentesca, offre notevoli vantaggi politici – di manovra e di critica culturale - ai tollerati e dominati, proprio perché mette a nudo le aporie di un universalismo bastone di comando: tra i sessi, tra le etnie, tra le culture, tra le religioni, tra le civiltà, tra gli stati, tra le classi.
In ambito concernente la forza armata, guadagna il non piccolo merito di mettere a nudo non solo l’antica verità che tra vinti e vincitori solo la povera gente fa la fame, ma soprattutto il fatto nuovo che la guerra moderna sia è sempre distruzione civile, sia cammina sull’orlo dello sterminio nucleare. Senza considerare una critica ulteriore, specificamente prodotta dal pensiero femminista della differenza, forse persino di maggior peso sul piano dei principi: la non conciliabilità tra conflitto (sessuale, sociale, culturale, politico) in vista di una ricomposizione più avanzata dei rapporti sociali e uso delle armi.
La costellazione che in questo modo viene configurandosi non è priva di fascino intellettuale. Il capitalismo, come sappiamo, è una formazione economico-sociale intimamente rivoluzionaria e conflittuale quant’altre mai, che unifica ma non eguaglia, vivendo di continue nuove polarizzazioni geografiche, culturali, politiche, di settore produttivo, ecc., in un moto continuo di vincitori oggi e vinti domani mattina. Muovendo dal polo euro-americano, con l’ausilio del pensiero universalista ha spalancato, manu militari, le reti mondiali del genere umano e ora, avendo vinto troppo, si trova a fare i conti con le energie capitalistiche altrove suscitate.
4. Sul versante anticapitalista, non v’è dubbio che lo sguardo potentemente unificante del marxismo, vero erede del pensiero classico tedesco, condivida la fiducia universalistica: dall’esortazione originaria “proletari di tutto il mondo unitevi”, alla trockijana rivoluzione permanente, fino allo Stato guida staliniano, protrattosi, in forme sempre più dure in proporzione inversa alla propria capacità egemonica, per buon tratto del Novecento. Già la Cina di Mao, sorta in tutt’altro contesto storico e sociale, aveva dagl’inizi impresso una curvatura particolare all’universalismo sovietico europeo. Poi, con la sconfitta del maoismo, pur nella continuità dell’assetto del potere statale e dei nomi, divenuta la seconda potenza mondiale in ascesa rispetto agli Usa in declino, imposta la propria politica di potenza in modo esplicitamente, polemicamente antitetico all’universalismo: la sua rivendicazione del multipolarismo, cui l’invasione russa dell’Ucraina ha impresso una forte accelerazione, è palesemente consonante con il paradigma concettuale della differenza, pensiero che, anche per questa via, mostra fertilità critica e di manovra tattica.
5. Un movimento analogo lo scorgiamo, sorprendentemente, anche in un ambito che per sua natura e storia è estraneo, anzi avverso al pensiero della differenza, intendo il monoteismo religioso. L’emblema di questo passaggio sono le dimissioni di Benedetto XVI: l’inflessibile teologo dell’universalismo cattolico, connaturalmente eurocentrico ha dovuto riconoscere la propria impotenza nel governo della chiesa mondiale, cedendo il passo al pragmatico Francesco I, aperto all’ecumenismo e all’ascolto dei non credenti, proprio per questo imputato da certi settori di eresia.
Conferme per opposizione vengono dai settori dell’integralismo islamico e dal nazionalismo del patriarca di Mosca, Kirill I.
Il pensiero della differenza, coltivato dal femminismo in opposizione a uguaglianza mostrando nell’universalismo di questo il dominio maschilista - gesto in cui palesa la natura e il segno originari del proprio antiuniversalismo - ha dunque la forza di dispiegare la propria critica su ambiti assai diversi della realtà sociale, politica e culturale contemporanea. Il suo pregio maggiore è mettere a nudo come la verità, in senso hegeliano, dell’universalismo sia l’identitarismo. Sul piano storico, l’identitarismo è l’universalismo transitato dall’egemonia al dominio.
6. Tuttavia, suscita sorpresa e non poche domande vedere che, se al fanatismo tardonobiliare si era opposto vittoriosamente un pensiero forte che si voleva razionale e universale, ora, contro questo ridotto alla brutalità di terra, sterco e sangue, si contrappone un pensiero che rifiuta l’idea stessa di una lingua comune, limitandosi a proporre una massima debole, quale “dignità della persona”, e norme puramente procedurali in vista di un’ibridazione. Non si può non notare di trovarvi una postura teorica che consuona con la ricerca filosofica del “pensiero debole” proposta nel secondo Novecento da Gianno Vattimo e altri.
Le domande forse più importanti riguardano due aspetti. Se la ragione non consente principi conoscitivi e pratici universali, ma costituisce solo la veste ideologica della sopraffazione (di genere, etnica, culturale, di classe, ecc.), le differenze di cui si prendono ora le parti sono tra loro equivalenti? E da dove nascerebbe allora il desiderio e il bisogno di ibridarsi?
Inoltre, pur ammesso questo, il principio della dignità della persona è concetto sufficientemente definito e forte da garantire che il confronto con l’altro rimanga aperto nelle due direzioni per consentire l’ibridazione e non si trasformi, anch’esso, in sopraffazione o esclusione?
Rimane insomma il bisogno di approfondire e avanza il sospetto che la forza nella pars destruens e la debolezza nella construens siano indizio dell’attuale fase in cui accanto al vecchio che declina non ha ancora preso corpo il nuovo e, in particolare, dello smarrimento del pensiero anticapitalista.
Lelio La Porta
Piero e Antonio
Piero: “Stavo rileggendo quel tuo articolo di qualche anno fa dove scrivevi di indifferenza”
Antonio: “Lo trovi ancora attuale?”
P.: “Tutto ciò che riguarda la nostra natura resta attuale per sempre”
A.: “Non è che mi vuoi rubare le citazioni? Per sempre è roba mia!”
P.: “Per carità! Ma voglio aggiungere qualcosa a quello che intendi per indifferenza. Poi, adesso che stanno per andare al potere questi cornacchioni vestiti di nero…”
A.: “Dimmi! Magari da buon liberale, anche se non sei proprio come don Benedetto, potresti tirare fuori qualcosa di interessante”
P.: “Penso che non possa essere morale chi è indifferente!”
A.: “Pensiero sottile che diventa un macigno per la coscienza di chi sappia intenderlo!”
P.: “Sai Antonio! È da tempo che volevo dirtelo e oggi me ne dai l’opportunità: seppure liberale mi sento molto più vicino a te e ai comunisti come te che a quelli che si definiscono liberali”
A.: “D’altronde tu parli e scrivi di rivoluzione, la rivoluzione delle coscienze. E ce ne sarà bisogno ora che andranno al potere questi uccellacci del malaugurio! E poi, caro amico mio, dobbiamo lasciare un messaggio ai giovani che, insieme a noi, dovranno sopportare questa dittatura dell’ignoranza e dell’indifferenza! Dovremo liberarcene tutti insieme!”
P.: “Speriamo che diano anche a noi la possibilità di partecipare a questa liberazione! Sai, questi uccellacci usano i bastoni come se fossero parole!!!”
A.: “E potrebbero usare anche altri mezzi: pensa al carcere, ad esempio!”
P.: “Che chiari di luna, caro Antonio!”
A.: “Vedi, se riuscissimo a fare intendere che la morale batte l’indifferenza e, con una spruzzatina di cultura e un poco di politica, può diventare esplosiva miscela rivoluzionaria, cioè libertà, non credi che avremmo assolto ad un nostro compito preciso?”
P.: “Guarda, non devi neanche convincermi! Sono sicuro che è come dici!”
A.: “Allora, sotto con carta, penna e calamaio. Scriviamo e incontriamo quante più persone crediamo siano interessate alla battaglia contro l’indifferenza.”
P.: “Forse un domani non ci sarà più bisogno di carta, penna e calamaio per comunicare. Inventeranno chissà quale diavoleria!”
A.: “Non ci voglio pensare, mio caro amico. Voglio pensare soltanto al fatto che a noi spetta il compito di vederlo il domani; da questo punto di vista, il primo obiettivo è chiudere questi uccellacci in gabbia! Ce la facciamo?”
P.: “Ce la dobbiamo fare. Cominciamo noi e, vedrai, riusciremo a trovare un grande seguito, soprattutto fra i giovani. D’altronde, noi siamo giovani e a loro ci dobbiamo rivolgere!”
A.: “Certamente i giovani sono i più sensibili ad un appello contro l’indifferenza!”
P.: “Sono d’accordo con te! Mettiamoci al lavoro!”
A.: “Forza Piero! Che ne dici di uno slogan del genere? Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza!”
P.: “Il messaggio mi sembra forte e chiaro!”
A.: “Bene! Qua la mano! Per salutarti con il pungo chiuso è meglio aspettare! O no?”
P.: “Per me non c’è problema, caro amico e un poco compagno. D’altronde, compagno significa mangiare il pane insieme…”
A.: “Già!”
P.: “E allora siamo compagni!!!”
28 aprile 2023

INNO DEL MATTINO
Da una delle guerre in corso perenne
Gazzettieri tacete che la sola vergogna ch’avete
è dei cani lasciati fuori dell’uscio senza una rete
fuggite che più lieve è il nostro lezzo di vostra sete
dei più cari ci è negato anche il pianto
qui restiamo a marcire il corpo franto
Andate via anche voi onesti umani giornalisti
che del fatto scrivete scrupolosi dati al lutto misti
ma d’altro non guardate uguali per voi i morti e già visti
il nostro non è un nome straniero
per i morti ammazzati del mondo intero
Da una delle catastrofi presenti e future
Ah tacete autorevoli che compunti ci spiegate come
morti siamo del fato e sol da piangere i senza nome
poi mentre in voi ridete natura dite nessun la dome
chi potrà raccontare i nostri strazi
sbrani di corpi di case e ragazzi
Via di qui oh bui corvi che già tra le macerie il guadagno
rapidi misurate di voi l’oro non l’uomo è compagno
e là dove passate tutto succhiate fino al rigagno
la nostra carne non ha più dolore
urla la rabbia verità e onore
Tutti
Non perché morti noi siamo fratelli
ma per non aver vivi voce avuto
fuori di quella ch’altri hanno voluto
e mentre guardiamo nei giorni belli
non c’è fibra in noi che non si ribelli
24 febbraio 2023

Si ripropone qui l'articolo apparso, con titolo modificato, sul "Manifesto", 16-2-23, p. 11, v.a., 20 febbraio 2023.
Pensare l’indicibile dello sterminio nazifascista
su Silvio Guarnieri, Cronache di guerra e di pacea, cura di Adriana Guarnieri Corazzol con la collaborazione di Giacomo Corazzol, introduzione di Pietro De Marchi, con uno scritto di Andrea Zanzotto, Manni, 2022.
Di Silvio Guarnieri, intellettuale comunista, critico letterario, scrittore, esce a vent’anni dalla scomparsa un volume curato dalla figlia Adriana. Le prose che lo compongono, scritte nell’arco di cinquant’anni, erano apparse, smembrate, in epoche diverse. L’autore lavorava alla revisione per la pubblicazione organica in volume quando, per un incidente con la sua bicicletta, le carte rimasero sulla scrivania della sua Feltre. Sono pagine di un’energia intatta e sorprendente. La loro odierna fecondità appare fin dal titolo, non solo perché di guerra sono tornati a oscurarsi i cieli del mondo e della stessa Europa, ma anche per una loro ambivalenza di genere. Cronache l’ha volute, con evidente sprezzatura, l’autore; “racconti” scrivono curatori e critici. Ma ci si accorge presto dell’inadeguatezza di entrambi, non riscontrando né l’invenzione propria del racconto, né la secchezza referenziale della cronaca. Saggi, piuttosto, e di una condizione assolutamente moderna, se è vero che oggi il soggetto si accampa in ogni discorso pubblico, mentre l’incombenza ossessiva del qui e del presente si ribalta in fame di realtà, cercata così nella storia individuale.
Le Cronache di guerra e di pace si snodano intorno all’indicibilità del campo di sterminio nazista. I cinque capitoli sono il rendiconto, in ordine temporale, della partecipazione di Guarnieri alla Resistenza jugoslava, allorché era direttore dell’Istituto italiano di cultura in Romania, a Timisoara; dell’incontro con l’ingegner Luigi Rozzi, liberato dai sovietici dal campo di Buna, che reca la prima notizia e ampio resoconto del lager; della visita al campo di Dachau, a guerra finita; dei suoi incontri con Monaco, Parigi, Bruxelles.
Se l’apertura di pagina allestisce un’aria familiare, presto sottopone il lettore a bruschi spiazzamenti. Lo scarto salutare che costringe a ripensare la propria abitudine, la propria sicurezza assume dapprima la forma della sorpresa per un periodare abnorme, tanto che non raramente il periodo coincide con il capoverso e talvolta giunge ad occupare l’intera pagina. Una caratteristica che colpì il gusto dei coetanei. “Scrive lento e opaco come un bovino”, scrive addirittura Pavese. Il fatto è che Guarnieri, come dice acutamente di sé, è dominato da una “continua e anche ansiosa volontà di conoscenza, di comprensione dei fatti umani”, dalla sua “quasi avidità di non lasciar cadere nessuno dei temi offertimi una volta e rimastimi presenti per una loro forza intrinseca”. Così un personaggio, una circostanza, una caratteristica sono solo la sporgenza che impone una domanda di senso su di sé e sul soggetto che rievoca. L’unità sintattica è in questo modo costretta ad aprirsi a una sinuosa ricerca delle caratteristiche, delle cause, dei particolari, a soffermarsi a soppesare le diverse possibili valutazioni, non potendosi chiudere prima di non aver lasciato “cadere nessuno dei temi”. Questa è la ragione per cui nel periodo guarnieriano la catena di subordinate, di coordinate, di riprese si sviluppa sempre in un ampio giro avvolgente.
Alcuni ritratti, come quello dell’ingegner Rozzi nel resoconto di grande potenza della vita nel lager, hanno la finezza di celebri pagine manzoniane. Agisce una cura penetrante che si esercita anche nella descrizione sociale e culturale delle città, prendendo le mosse da un gesto, un carattere colto al volo, un costume osservato nell’accompagnare gli studenti o in una consumazione al bar.
Ma la vera forza di queste pagine è nella loro grammatica concettuale, esercitata sulla mostruosità del campo di sterminio, di cui i capitoli perseguono una sorta di continuo approfondimento e allargamento, anche per il loro mettere a fuoco tempi differenti. A questo riguardo, la critica ha parlato di atteggiamento morale, qui a chiusura del volume ben esemplificata dal conterraneo Andrea Zanzotto. Però, sebbene l’ultimo capitolo, La gazzella e il leone, approdi a una sponda antropologica del male, tutto il percorso è sorretto da una risentita necessità politica. Guarnieri risale le ragioni economiche, politiche e culturali diventate vita quotidiana, senso comune, per comprendere la realtà dell’orrore del lager, le responsabilità da attribuire e il perdurare dei suoi effetti. Splendida è l’analisi dell’atteggiamento sminuente della guida tedesca che negli anni Cinquanta accompagnò a malincuore la visita a Dachau. Ma lo scrutinio non ammette indulgenze neppure verso coloro che non hanno avuto il coraggio di ammettere “quella che era stata, anche inconsciamente, una propria sia pur minima partecipazione a quella lunga catena di conseguenze”. Uno scrutinio serrato che approda a una critica radicale di tutta la società capitalistica: “un certo modello di civiltà e di costume, impostato sulla discriminazione da uomo a uomo, del dominio dell’uomo sull’uomo come propria ragione di fondo, ha in sé impliciti ogni violenza, ogni prevaricazione ed abuso”, del quale il lager è la manifestazione più terribile e più chiara, “l’ultimo termine di una civiltà, il suo esito estremo”.

Grosseto. Libreria Palomar
Giovedì 24 novembre 2022
Presentazione di Note per un trittico. Metafisica, Tempo, Storia, Asterios, 2022
Velio Abati e Roberto Bongini con Pietro Accolla


Si ripropone qui l'articolo apparso sul numero 16 della rivista on line "Nautilus", v.a., 6 novembre 2022.
La libertà di generare
I Colloqui del Tonale
Generazione. Ottimo memento, in questo tempo di creazioni posticce che, se appena le graffi, mostrano la coazione angosciosa dell’identico, un eterno presente cui sembra contrapporsi solo la nostalgia del passato più luttuoso.
La radice, dal greco ‘ghennao’, ha un unico significato su due diversi ambiti del reale: biologico (‘faccio nascere’) e antropologico (‘creo’), sia questo in senso fisico o spirituale. In entrambi i versanti indica un movimento particolare che nella sua forma più generale le Confessioni di Agostino d’Ippona definiscono così: “il mondo non era, dove sarebbe stato creato, prima che fosse creato, affinché fosse”. Ora, l’interessante in tale formulazione radicale del concetto è che palesa come l’atto di generare, la generazione appunto, sia determinazione essenziale della libertà (ognuno può vedere quanto la libertà di creare sia superiore alla libertà di scegliere tra ciò che già c’è) e, insieme, in quanto movimento, determinazione del tempo. In altre parole, il generare, la libertà umana e il tempo storico (non quello biologico, dal momento che nessuna volontà o nolontà umana può opporsi al mutamento che conduce alla morte) sono tre determinazioni prese in una circolarità causale non unidirezionale.
D’altra parte, il linguaggio comune parla di ‘generazioni’ per designare classi d’età differenti, concetto ben chiaro se ci si riferisce alla dimensione biologica; assai più complicato e storicamente molto variabile diventa invece quando s’intenda la differenziazione storica, per il fatto che la complicazione e la variazione dipendono dalla reale creazione del nuovo.
La costatazione ovvia che l’uomo non è Dio comporta che nella storia la libertà di generare non è mai separata dalla libertà dalle condizioni in cui è immessa e con la quale intrattiene un complesso rapporto dialettico: è questa la posta del conflitto sociale e delle speranze individuali. Posta che può essere davvero contesa solo se teniamo a mente che la meta è la libertà di generare. Per chi, come me, ha i piedi nel lavoro contadino e la testa nel mestiere d’insegnante, ha ben chiaro che possiamo non dimenticare il futuro solo se sappiamo scegliere dal passato per comprendere l’oggi. La frammentazione indotta dall’iperspecializzazione, la paranoia narcisistica dell’isolamento ben coltivato dal dominio neoliberista (“non esiste la società”, predicava la Thatcher negli anni Ottanta), la slogatura tra generazioni alimentata dall’accelerazione consumistica del finanzcapitalismo e da esso fomentata con lo scontro tra classi d’età sono tutti strumenti con cui si riduce la scena del mondo alla videata del computer, che ogni volta si rinnova rimanendo se stessa.
Per questo, per paradosso, io, maturo docente, mi sono trovato a insegnare ai giovani la speranza. E sempre per questo, quando il mio anziano padre contadino è scomparso, ho sentito il bisogno di saldare il mio legame scegliendo, dal suo patrimonio, la fiducia tenace di costruire legami, la voglia di conoscere il mondo per costruire un futuro meno diseguale, l’amore consapevole della bellezza della terra e di quanto sia bassa, il piacere mai perso per la partecipazione dell’altro alla propria esperienza.
Da questa passione del ragionare insieme e dalla consapevolezza del vincolo profondo tra l’ambiente e chi vi vive spunta il nome e la pratica oramai decennale dei Colloqui del Tonale. ‘Colloquio’ (‘parlare insieme’) è quanto più si avvicina al concetto meglio espresso dall’accezione antica di ‘ragionare’, ancora presente in bocca toscana, la cui radice è quella di ‘ragione’, che comprende sia ratio che ‘causa’. L’idea che li muove è che la conoscenza è molto di più che informazione, unidirezionale e verticale: è invece cooperazione, è rottura della paratia che impedisce il ritorno, è piacere del gratuito. Inoltre, come si diceva, l’individuo non è, se non per costrizione e mutilazione, una monade, quindi il ragionare si accompagna al piacere di condividere (il tempo, un piatto alla buona, un bicchiere) e insieme godere dell’ambiente del Parco naturale della Maremma, dove il podere di famiglia, il Tonale, si trova. Cosicché, più compiutamente, potremmo definirli ‘convivio’, dove l’interesse alla partecipazione è simmetrico alla gratuità assoluta di chiunque vi prenda parte, in qualunque forma.
Gli argomenti sono via via suggeriti dalle emergenze del presente, con uno sguardo di volta in volta locale o globale, ma sempre nella convinzione che nessun’isola è oramai presente o auspicabile. Argomenti tratti dalle differenti discipline in cui si è organizzato il sapere, cercando ogni volta di ottenere contributi di alta competenza, avendo però di mira un complessivo orizzonte di senso.
Dapprima i Colloqui del Tonale sono nati soprattutto per offrire agli studenti che lo volessero uno spazio culturale alternativo alle valutazioni, ai crediti, agli obblighi, poi la partecipazione è andata ampliandosi, così si è consolidata una “compagnia pìcciola” di amici, colleghi, giovani, studiosi, animati dall’interesse e dal piacere comune.

Si ripropone qui l'articolo apparso, con titolo diverso, sul "Manifesto" il 10 settembre 2022, p. 12, v.a., 15 settembre 2022.
Ironie notturne
su Forme della notte di Giorgio Luzzi
A due anni dall’ultimo lavoro, Non tutto è dei corpi, Giorgio Luzzi torna con una nuova raccolta, Forme della notte, (Carabba, 2022, pp. 121, euro 14,00), dove, se “forme” include sia i temi che la forma poetica, il secondo termine rende ora esplicita la meditazione sull’appressamento della morte. La genesi ispirativa si concentra ancor più sulla spina esistenziale dell’io poetante, cui per più di un componimento fa da specchio la recente scomparsa di Bruno, amico conterraneo, già direttore del museo di Tirano, mentre qua e là la pagina torna sul torpore delle sette serali come a oscura vigilia.
La contiguità con la precedente raccolta si fa forse più evidente nel tessuto ritmico. Qui, come lì, pur sottoposti alla consueta morsura di infrazioni, sbreghi, echi citazionali – tipici di una sensibilità novecentesca –, assiepano il dettato classiche alternanze di endecasillabi e settenari, ottocenteschi settenari doppi, ottonari, novenari, fino al sonetto mimetizzato dall’assenza di rime regolari in Che scrivo? Assai frequenti poi sono le rime ravvicinate, regolari e interne, per quanto anch’esse, come la misura ritmica, ostacolate alla percezione facile. La poesia di Luzzi vive da sempre in questo conflitto tra la tentazione della sensualità della rima e dell’allitterazione, la confidenza rasserenante propria dei versi regolari della tradizione e invece la necessità tutta razionale e, aggiungerei, morale del suo rifiuto, da cui un’ampia fenomenologia che va dalla vasta presenza metalinguistica, alla predilezione dell’analogia, all’impiego frequente del neologismo e del plurilinguismo, fino al gusto delle giunzioni inusitate, alla parodia e all’ironia. Tale largo ricorso è l’incarnazione di uno scarto oppositivo rispetto all’energia dell’altra spinta. C’è, insomma, nell’amore intellettualistico – piuttosto che sensuale – per la lingua, una mossa difensiva verso il concedersi alla vita, che in queste ultime due raccolte fa qua e là filtrare la pressione della nostalgia, il dolore della fine, l’amarezza del rimpianto e della delusione. Per questo, ora, l’invenzione poetica sembra inclinare maggiormente alla dicibilità, al cantabile. La novità delle Forme della notte, quasi in contrappeso alla maggiore concentrazione entro lo spazio esistenziale, si trova nell’attivazione più insistita di un’altra potenzialità della cadenza di misure tradizionali: il gioco divertito, la coloritura ironica, modo, anche questo, di piegare la resa alla sensualità del cantabile verso una funzione difensiva.
Così non mancano guizzi scherzosi e sorprendenti come “ammodato / di camicie emblematiche”, o parodie sentenziose di proverbi, “Chi morirà vedrà”, oppure acutezze derivate da frasi codificate dalla cronaca, come quella tragica del volontario italiano ucciso in Palestina, Vittorio Arrigoni, ben conosciuta dai lettori del “Manifesto”, “restiamo umani”, esposta addirittura nel titolo: Restiamo quieti.
Contigua a questa casistica è la diffusa ricerca, anch’essa sentenziosa, della clausola rimica in chiusura di componimento, ora baciata come nel doppio settenario “un luogo che si accenda con trepido rigore / nel rispetto oscillante dei riti delle ore”, ora a breve distanza: “Dici le sette e non hai torto Vai / stai per scadere in un égout di noia / Tanto il tuo mondo non rincasa mai”. Nell’ultima occorrenza compare l’omissione, grammaticalizzata nelle ultime raccolte, di ogni segno interpuntivo, frutto evidente della controspinta di spiazzamento e presa di distanza. Inoltre la chiusa, ove s’addensano analogie, plurilinguismo, allitterazioni aspre, fa cadere in enjambement un’altra modalità della stessa funzione, ossia il nesso paronomastico, “Vai / stai”, abbastanza diffuso: “Tra flutti e frutti”, “virò la sua vera”, “esile ed esule”, ecc.
Non mancano, infine, i ricordati omaggi agli autori, come nel caso di Zanzotto, “Poi comparve l’Andrea de La Beltà”, e i consueti echi, espliciti o frutto di memoria involontaria, dal celebre Xenion montaliano (“Tutto con l’innocenza di chi crede /…/ la via del non si vede”), alla celeberrima conclusione di Francesca nel quinto dell’Inferno: “Verrà un giorno che più /non scriveremo avanti”.

Si ripropone qui l'articolo apparso su "Nazione Indiana" il 18 maggio 2022, con medesimo titolo, v.a., 19 maggio 2022.
L’intellettuale marxista Franco Fortini
su L’integrità dell’intellettuale di Giuseppe Muraca
In nessun altro tempo, come nell’attuale di drammatica accelerazione, è più difficile prendere pubblicamente parola, se lo fai nel registro del letterato. Infatti di fronte all’odierno scarto storico che, come accade negli eventi tellurici, è di colpo fatto esplodere dalla tensione accumulatasi sotto l’euforia della globalizzazione seguita all’implosione sovietica, tutto modificando per un’intera epoca dell’umanità, misuri davvero, sulla tua carne, la pluralità e l’asincronia, anzi l’attrito insolubile dei tempi che attraversano l’individuo come la collettività. In che modo, ti chiedi, parlare - per dirlo alla Fortini – dell’aggressione russa all’Ucraina, dello scontro con la Nato della seconda potenza militare mondiale - un presente solfureo che brucia ogni altra dimensione - mentre scrivi di letteratura? Sai solo che il tuo dovere è cercare la verità e che essa è sempre dalla parte di chi ne è espropriato.
In questa occasione mi aiuta il volumetto di Giuseppe Muraca (L’integrità dell’intellettuale. Scritti su Franco Fortini, Ombre corte, Verona 2022, p.122, euro 12,00). Consta, ci spiega la Breve premessa, di articoli e note scritti nell’ultimo trentennio, i più vecchi dei quali sono stati “rivisti e in parte modificati”. Il tutto è fatto precedere da una lettera di Muraca a Fortini datata 15 gennaio 1991 con la risposta del 18 febbraio. Già i titoli dei cinque capitoli (Dieci inverni; Fortini e Pasolini; Attilio Mangano, Franco Fortini e la nuova sinistra; Note di lettura) e le coordinate temporali portano nelle novità editoriali sull’intellettuale marxista un piccolo spaesamento. La fortuna di Fortini, dopo la sua scomparsa avvenuta il 28 novembre del 1994, ha conosciuto da tempo, prima lentamente, poi in modo più accentuato una discreta intensità e vastità di studi, grazie prima di tutto alle carte raccolte e all’attività del Centro Studi Franco Fortini dell’Università di Siena, dov’egli è stato docente. Ulteriore spinta è stata impressa dal centenario della sua nascita, come oramai avviene per le ricorrenze memoriali, con le quali l’ipertrofia dell’odierna comunicazione sociale divorata dal presente trova utili incentivi a riprodursi.
Tali lavori critici hanno prima di tutto restituito al poeta Fortini il posto che in vita da più parti gli è stato negato, fatto sopportato in silenziosa sofferenza: “se uno mi contesta un articolo, un saggio, allora sono prontissimo a battermi ma non so dire una parola in difesa di una mia poesia e questo è un modo ingenuo, una trasposizione, cioè scateni l’aggressività in quello che in un certo seno tu consideri per te meno prezioso e l’altro non riesci a difenderlo”, dice in un’intervista del 1981 con Mirella Serri, intitolata, niente meno, Dialogo col profeta di classe. Solo nella forma mediata dal cerimoniale dell’epigramma è riuscito a farlo: “Uno solo forse vale dei miei versi, dici. Ma / bada. Può farti male. Prendine la metà”.
Eppure, le parole pacate di Muraca generano attrito; irrompono da un altro tempo. In effetti la critica intervenuta ci ha via via consegnato approfondimenti filologici, meritori studi accademici che mentre valorizzavano e precisavano la figura di poeta e di letterato fino alla posizione di classico, sfuocavano la funzione intellettuale e segnatamente militante, politica di Fortini. Ecco perché le riflessioni e le cronache restituite con garbo da Muraca rischiano d’essere ignorate o, peggio, letteralmente fraintese. Il critico, che proviene da una stagione e una militanza politico-intellettuale formatasi nella temperie degli anni Sessanta-Settanta, non se ne è pentito e riporta il suo sguardo sulla battaglia intellettuale di Fortini.
Certo, con Muraca sappiamo che anche la critica più penetrante prende vita dal suo contesto e dunque il salto d’epoca intervenuto per il lettore di oggi può ingannarlo: l’autore dell’Integrità dell’intellettuale si astiene dall’indicare quel salto, lasciando al suo lettore la responsabilità di mettere in conto la scomparsa non delle persone evocate dalla ricostruzione – i Vittorini, i Togliatti, i Nenni, i Bo, ecc - ma della ben più determinante realtà sociale, politica, sindacale, culturale di cui essi erano espressione. Tuttavia, se ci carichiamo della fatica di attraversare la superficie della cronaca e dei protagonisti del tempo oramai trascorso, per andare alla sostanza troviamo tutta la vitalità e la forza dei temi, delle scelte, dei compiti con cui l’intellettuale Fortini si è misurato.
L’attività intellettuale di Fortini che Muraca mette a fuoco è quella tra il dopoguerra e l’esplosione dei movimenti del Sessantotto, lasciando alle finali Note di lettura brevi annotazioni sulla saggistica successiva. La prima importante acquisizione consegnata al lettore è anche la più implicita: l’attenzione, persino assillante, di Fortini al mutare dei tempi brevi della storia. Segno questo di una fedeltà a un metodo: “i presupposti da cui muoviamo non sono arbitrari”, direbbe Marx. Da qui la particolare diffrattività di fronte a cui si trova il lettore di Fortini: il suo continuo ri-considerarsi in una ferma coerenza, tanto che nell’anno della sua morte dice: “un giorno incontro Adriano Sofri, che mi dice: ‘Non sei cambiato. Sei una pietra’”.
Nei quattro periodi scanditi da Muraca – la stagione del “Politecnico” di Vittorini, il decennio fino al 1956, la stagione delle riviste preparatorie del Sessantotto, il Sessantotto – una rimane l’ispirazione fortiniana: l’affermazione teorica e la ricerca pratica dell’unità tra letteratura, critica, produzione culturale, politica, in una prospettiva esplicitamente di classe. Questa aspirazione alla totalità, per quanto sempre inseguita a partire dal suo ‘spirito di scissione’, lo porta anche a sottolineare precocemente l’avvenuta interconnessione di tutte le società umane.
Così, al mutare delle dominanze e dei soggetti nelle differenti fasi storiche, mutano anche le difese e le critiche. Sul lato politico, prima e per un lungo tempo verso il Pci e il Psi, sul piano pratico, ha rifiutato “la mediazione politica, la direzione burocratica e verticistica dell’attività culturale per instaurare un rapporto diretto tra gli intellettuali e la classe, fra i produttori e i consumatori di cultura”, sulla scorta “del Gramsci dei consigli e del pensiero luxemburghiano e maoista”, perseguendo l’affermazione di un “socialismo basato sull’autogoverno delle masse e della democrazia diretta”; sul piano ideologico ha combattuto il loro “storicismo crocio-gramsciano”, ossia “un marxismo nazional-popolare e una visione della cultura ristretta e provinciale”. Mentre da ultimo ha difeso le ragioni della letteratura contro la pretesa del suo annullamento nella politica, avanzata dai movimenti del Sessantotto.
Sul lato letterario ha via via combattuto contro la linea “di ascendenza ermetica e idealista”, che coltivava una concezione “religiosa e pura della letteratura, l’autonomia dell’opera letteraria e artistica”; poi la pretesa opposta della neoavanguardia d’identificare la politica nella letteratura; infine contro la deriva osservata in Pasolini di estetizzazione della vita, che alla fine finisce per annullare la differenza tra arte e vita.
Come non vedervi - in questo tempo dell’immediatezza, della frantumazione narcisista, dell’urlo ossequiente - la necessità contraddittoria di un’organizzazione politica, la ricerca indispensabile di un orizzonte complessivo di senso, il rifiuto di delegare ad altri la ricerca del vero, che può avvenire solo come pratica comune di trasformazione a partire da chi e da quanto è espropriato, gettato da parte, in vista di riappropriazione del nostro futuro. Come non vedere che è tutto questo che ‘spiega’ la poesia di Fortini e che ci offre qualche cartello per attraversare l’orrore del presente?
Ripropongo qui il "commento" di Andrea Inglese postato in "Nazione Indiana", v.a. 24 maggio 2022
“la necessità contraddittoria di un’organizzazione politica, la ricerca indispensabile di un orizzonte complessivo di senso, il rifiuto di delegare ad altri la ricerca del vero”.
La posizione di Fortini era già difficilmente riconoscibile quando ancora esisteva il PCI, esisteva una cultura borghese elitaria, esistevano dei movimenti extraparlamentari di contestazione. Oggi questa posizione si puo’ celebrare retrospettivamente, a secolo chiuso, ma è quasi intraducibile ai giorni nostri. Pero’ ognuna di quelle istanze è ancora presente, ancora attuale, e questo non puo’ essere negato. Quanto si nega è l’idea che ognuna di esse (organizzazione politica, orizzonte di senso, ricerca del vero) non possa essere trattata in maniera isolata, in quanto tutte sono solidali e dipendenti tra di loro. L’amore odierno per l’immediatezza e il frammento sembrano, su questo, avere vinto.
Bel pezzo Velio Abati.

Si ripropone qui l'articolo apparso sul "Manifesto" dell'8 aprile 2022, a p. 11, con il titolo, La violenza che quotidianamente permea il vivere, e leggere modifiche, v.a., 9 aprile 2022.
Fra bronchi e apparenze ingannevoli
su Ossa e cielo di Marina Massenz
Ci sono, nella vita individuale e ancor più in quella collettiva, tempi così oscuri, quando tutto sembrano travolgere, che la scelta dell’essenziale diventa difficile quanto decisiva. La guerra è uno di questi. Il Novecento ne sa qualcosa, da “è impossibile scrivere una poesia dopo Auschwitz” di Adorno, al “come potevamo noi cantare” di Quasimodo. Eppure rimane lì un dovere di resistenza, contro l’abbrutimento al servaggio proprio di ogni guerra, l’obbligo etico a non recedere dal proprio lavoro, alla coltivazione dell’umano. La poesia, nel suo aristocraticismo scostante e vicinissimo ne è parte, per cui, nell’inverno della nostra angoscia, apro una pagina: “Scappare / inseguiti da eserciti / sgomenti per deserti / con acqua di cactus / rintanarsi in anfratti / sotto ponti ferrovie /strade il cemento / per bloccare e acqua / sempre l’acqua del mare, / ignotissimo e solo”. Ma non è odierna cronaca di guerra. Le metafore inviano a una profondità corporea, vera sorgente ispirativa: “Nel profondo sommerso / intimo più intimo / dove non è parola / né pensiero, là corpo / là anima là seppi / tutto della battaglia”. Il valore della raccolta di Marina Massenz mi sembra nel portare alla luce la violenza che silenziosamente impregna il vivere quotidiano della nostra vita la quale, in certi anfratti della storia, esplode nelle superfetazioni degli stati maggiori.
Massenz non è certo digiuna della poesia del Novecento, a principiare dal primo Montale, cui discretamente rinvia lo stesso titolo Ossa e cielo (prefazione di Alessandra Paganardi, Puntoacapo edizioni, Pasturana, Al, 2021), o, più scopertamente, la poesia inaugurale, con il riuso della celebre doppia negazione (“ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”) qui esibita proprio in avvio: “Noi che lievi non siamo / che lievi non sappiamo”. Tuttavia gli echi, certe movenze e asprezze sonore sono piegate a un sentire che, come certa scrittura di donne, sa portare la parola in zone fonde dell’esistenza e delle relazioni. Al centro della meditazione, quasi un canto notturno, è la rievocazione del padre scomparso, cui la raccolta è espressamente dedicata, avvicinamento che è insieme messa a confronto con il sé bambina e adolescente. Ma la meta è raggiunta solo nella seconda parte della raccolta, dopo l’attraversamento di un paesaggio interiore e collettivo scheggiato, dove irrompono gru “in cerca di ali” come relitti di un profilo urbano stranito, migranti affogati “nel glaciale liquido nero”, la devastazione “che falciando procede” fino allo scempio dei preziosi abeti rossi già materia dei liutai, grottesche figure femminili di bagnanti che “si truccano da pesci”, le “creature mostruose” degli uomini del potere.
La voce prende forma in un paesaggio opaco e oscuramente minaccioso, snodandosi in versi brevi che, salvo rari momenti di felicità come nel finale dedicato a Biagio Marin, nulla concedono al cantabile, in questo assecondati dalla dominante consonantica del lessico. Ma forse ciò che più caratterizza la tessitura linguistica è il ricorso a una sintassi sbrecciata, deprivata in ampie zone di ogni segno interpuntivo, tanto più che le lunghe sequenze sintattiche, già di per sé non immediatamente riconoscibili, sono indipendenti – e vorrei dire estranee – al ritmo del verso. Così gli enjambement, pur assai frequenti, perdono la tradizionale funzione melodico-emotiva e s’istallano nel verso come bronchi, oppure apparenze ingannevoli che solo la rilettura svela. A contraltare di questa asprezza, qua e là il testo si concede il cantabile di giunture etimologiche come “fili filati”, o rimiche come “portoni e vagoni”. È il modo per restituire la fatica e il limite di portare alla consapevolezza della parola l’irragionevole distruzione di uomini e natura, il senso oppressivo di morte, il bisogno insopprimibile e vitale ora della tenerezza dell’abbraccio, ora dell’intesa gioiosa e complice: “come dei resti di te / mi arrivano in gola / ed escono in discorso / comune e semplice / come avessi detto io / sempre le stesse parole tue / e mi inclinano al riso”.

Si ripropone qui l'articolo apparso sul "Manifesto" del 2 marzo 2022, con il titolo Passaggi, appartenenze e sguardi si rinfrangono sullo specchio del sé, v.a., 30 marzo 2022.
La ferita e il falso farmaco
su Niente dirà dove sei di Stefano Calafiore
Nella splendida eredità della lirica occidentale è implicita una posta paradossale: la massima concentrazione narcisistica sull’autore, sul suo qui e ora che espunge l’altro, è anche la denuncia muta di quella amputazione e insieme la scommessa, per certi versi paranoica e mai verificabile, di approdo a una verità universale. Ogni lettore riconosce nel suo fascino, provato subito o dopo secoli, la strana euforia di vedere insieme il poeta e se stesso, quel tempo e il proprio.
Spetta alla successiva responsabilità del lettore giungere alle distinzioni, dar voce a quanto rimane indicibile, farsene carico e arma. Il titolo della raccolta dell’esordiente Stefano Calafiore, Niente dirà dove sei (Manni, 2021, introduzione di Corrado Benigni, pp. 64, € 12) proclama fin troppo scopertamente la ferita in questione. I ventuno testi della prima sezione, Passaggi, ci conducono in una dimensione rarefatta con labili apparizioni femminili, spesso per fugace accenno metonimico: “bei volti”, “le curve”, “nuda e vera”, “seria e fiera”, “guance rosee”. Solo due anonime tracce maschili compaiono: “amici intellettuali” e “marinai”. D’altra parte, la brevità addotta dal versicolo e dal componimento non permette veri sviluppi narrativi. Ma oltre il portato, per dir così, materiale colpisce l’immobilità irreale in cui si dispongono le siluette umane, tanto che l’unico movimento esperibile, quasi un affannarsi, è quello del soggetto poetante. Tutto però si fa chiaro quando si osservi che il sottotitolo della poesia d’apertura, Il corpo (visto da J.S. Sargent), è in realtà la chiave dell’intera sezione, dal momento che gli unici nomi femminili, esposti tra l’altro nel titolo (Virginie Amelie Avegno, Agnew, Flora) sono di dame borghesi ritratte dal pittore statunitense John Singer Sargent vissuto tra Ottocento e Novecento. Tutta la sezione è costruita sull’identificazione della voce poetante con il pittore, cosicché la scrittura viene a configurarsi come il doppio della pittura.
Si chiarisce allora che il ricorso alla maniera della brevitas ritmico-lessicale, ivi compresa l’assenza dei segni interpuntivi, di certa poesia primonovecentesca oramai grammaticalizzata è vissuta come equivalente del manierismo del fortunato ritrattista del gran mondo. Medesima funzione, sul versante metrico, è assolta dall’attenta simmetria delle partizioni strofiche dei componimenti: alla prevalenza di testi costituiti da una o due quartine, si uniscono altri di una o due terzine, fino a una poesia costruita sulla triplice alternanza di terzina seguita da monostico. Il titolo Passaggi dunque rinvia non, come potrebbe apparire, a un qualche trascorrere temporale, bensì al proprio costituirsi come doppio della pittura e del pittore. In tale ordito sin troppo levigato, in questa postura svagata non sempre davvero necessaria, avverti comunque qualcosa che contraddice. Da certe pose femminili, da certi incarnati e impasti di colore, da improvvisi abbandoni senti affiorare la scena da dove tutto il piccolo rituale di movenze, finzioni, etichette ha preso il via per cercare di aggirarla. È un dolore autentico, è il bruciare dell’assenza: “Ho dato le spalle / a me stesso / in un gioco di specchi / incessante”.
Il titolo della seconda sezione, Appartenenze, indica invece movimenti di uscita dallo schermo: “Mi osservo / le mattine / per scoprirmi / isolato e lontano”. Nei venti componimenti, le stesse simmetrie strofiche del versicolo si fanno appena più mosse. Il farmaco rivela la sua inefficacia e così, dallo strappo apertosi, filtra ora la nostalgia di paesaggi (“quelle strade / portavano /la domenica // negli occhi”), di presenze d’infanzia “dentro quei pomeriggi d’oratorio”, del “passaggio di folle”. L’affannato “così fermo il tempo” della prima sezione, rivelatosi velleitario, cede alla presa d’atto della sua inarrestabilità, depositata in dolorosi segni sul corpo: “Si noterebbe la pelle / deviata negli anni”. Movimento che trova forse il suo punto culminante nel testo che s’intitola Mi guardo: “Decado / preoccupato / mi guardo // pensieroso / Chissà quale parte / di me // tradirà”.
Mattinale
La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell'ultima
c'erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente egualmente.
25 febbraio 2022
Ah, smarrita nell’immensa silenziosa pianura
d’una gnu m’ha svegliata stanotte la creatura
e tremando mi chiamava nell’ora che si scura.
A qual lutto, padre Saggio, la Terra mi prepara?
Sento, donna, nel tuo cuore paura e grande affanno
io non voglio con parole accrescere il tuo danno
ché non sempre vedo il vero né i sogni ragion hanno.
Ma tritura il dolce miglio che vedi già rischiara.
Ah, il vero mi nascondi, ma l’occhio non mi mente.
Dov’è il figlio mio fiorito? Ah, da quanto non si sente?
Chi t’ha preso dolce palma? Tu sperso tra la gente.
Chi ti scalda nella notte, te vita mia più cara?
25 gennaio 2022
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sulla rivista on line Nazione Indiana, il 7 luglio 2021, v.a., 11 luglio 2021.
Rossana Rossanda e gli altri rabdomanti
La poesia di Tommaso Di Francesco nasce e vive in una controscena. Uomo pubblico dalla sua militanza nella “nuova sinistra” del Sessantotto, politico-giornalista di quella particolare forma della politica, che il quotidiano “Il Manifesto” è, nel quale ricopre la carica di codirettore e di responsabile della pagina degli esteri, ha da sempre derivato da quella passione intellettuale e morale una non minore necessità poetica. I “foglietti in tasca” che il poeta si porta dietro registrano sì i fatti con i quali è alle prese il politico, ma costretti alle fratture, allo scarto delle vite proprie e altrui, che l’azione politica non riesce, ancora o mai, a ricomporre.
Invece la nuova raccolta I rabdomanti. Quattro poemetti, quattro poesie colloquiali e una favola (Manifestolibri, 2021, pp.83, €.8,00), dedicato ai fondatori del “quotidiano comunista”, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, incrina e forza la separazione tra le due scene. Non che Di Francesco non avesse già scritto sui suoi compagni di redazione, ma con il distanziamento dello scherzo epigrammatico, in consonanza con i ben noti titoli del “Manifesto”.
Otto sono i fondatori “rabdomanti” alla cui scomparsa il poeta volge la pietas della pagina: Aldo Natoli, Luigi Pintor, Lucio Magri, Eliseo Milani, K.S. Karol, Rossana Rossanda, Valentino Parlato e Lidia Menapace; un componimento ciascuno, eccetto Rossanda cui è dedicata anche la prosa della favola in chiusura del prosimetro. Il cortocircuito tra le due scene produce sommovimenti, tensioni divergenti e persino eterogenee, già palesati dal sottotitolo composito. L’andamento lieve della favola Mefis è tornata – registro da Di Francesco già sperimentato in un libretto per bambini illustrato, come questa volta la copertina, da Mauro Biani – è solo il fenomeno più vistoso: le divaricazioni operano in profondità nel tessuto stesso dei testi poetici, sottoposti a una doppia polarizzazione. Ora, le alchimie oscure della germinazione poetica, che attengono, credo, al differente vissuto nella redazione e nella militanza, sbocciano in testi brevi di una lingua sorprendentemente piana, ricca persino di rime baciate, non aliena da tenerezze: “Sopra il destino dell’uomo soffiava / il vento Eliseo, né zefiro né burrasca / ma tramontana irriducibile, costante” (La forza in disparte, per Eliseo Milani), “Sei l’unico impermeabile di Bogart / rimasto, che dentro protegga / l’infanzia d’una guardia rossa” (K.S. Karol, il leggendario Solik); aperta addirittura alla giocosità in Il zunzuncito, dedicata a Lidia Menapace.
Ora, invece, e sono i testi più lunghi, le tensioni intellettuali e politiche, le ambivalenze esasperano i caratteri propri della poesia di Di Francesco, mai di facile lettura, perché il dolore delle sconfitte, gli smarrimenti esistenziali della mente e dell’animo di cui essa si fa carico (e tutti i rabdomanti cantati ne sono stati segnati con l’autore, testimone e parte vivente) hanno accesso alla pagina solo fortemente mentalizzati, mentre gli eventi, le circostanze che ne sono stati cauterizzati vengono drammaticamente sfrondati, quasi divelti dal tessuto della cronaca e restituiti come bronconi irriconoscibili eppure sanguinanti, una forza dislocatrice e abrasiva che deforma lo stesso andamento ritmico-sintattico. La poesia che ne sorge non è, com’è stato detto, allegorica, ma violentemente sineddotica e, in modo più intermittente, analogica. Da questa controscena e dalle sue dinamiche nascono la difficoltà, le asperità, il rifiuto della confidenza e insieme l’affidamento costante alla poesia.

Propongo anche qui l'intervista filmata curata da Lorenzo Pallini, da lui parzialmente impiegata per il suo film Franco Fortini, memorie per dopodomani. Anche il titolo del suo ricco sito, cui si rimanda qui sotto è Memorie per dopodomani.
La presente intervista compare anche nella rivista on line "L'ospiete ingrato", e precisamente nel numero 9: Scuola, la posta in gioco, curato da Valeria Cavalloro, Gabriele Fichera, Damiano Frasca, Francesca Ippoliti, Alessandra Reccia, Maria Vittoria Tirinato, cui volentieri rinvio. 18 maggio 2021, v.a.
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul n.322 (marzo-aprile 2021) dell'"Immaginazione" , a p.52, , v.a., 14 maggio 2021.
Il senso del vuoto nelle Variazioni di Nisivoccia
Se il nostro è il tempo dell’uso immediato, della babele gridata, che consuma il pensiero e i corpi stessi, se l’asfissia prende le forme, come in certi degradi ambientali per eutrofia, dell’affluenza, se la vertigine delle solitudini può traboccare proprio nel fitto della presenza umana, una mossa possibile di autoconservazione e di promessa di salute è la ricerca del margine o, come dice Nisivoccia, del “vuoto”. Infatti la sua ultima opera, Variazioni sul vuoto, si presenta come meditazione sapienziale e insieme sollecitazione etica. Ogni “variazione” è una diversa strada della conoscenza e accesso alla salute del “vuoto”.
La plaquette è di brevi, spesso brevissimi aforismi, disposti tre per pagina, a comporre nel piccolo specchio del foglio una sorta di battito ritmico delle sessantatré variazioni. Piano è anche il registro linguistico, attento a evitare non dico gli urti, ma le medesime increspature di lessico, secondo lo stesso precetto d’autore: “Costruire un lessico necessario: scarno, essenziale, perfino poco vario”. La sintassi si modula sulla misura della frase-periodo, tutt’al più ricorrendo alla paratassi, assai rara l’ipotassi. Altrettanto scarna è la sua ossatura, incardinata nelle due modalità elementari della costruzione nominale priva di verbo e dell’infinito, naturalmente esortativo.
Vasti spazi bianchi della pagina, asciuttezza lessicale, minimalità sintattica sono il risultato iconico e linguistico della strada ascetica voluta dalle Variazioni. L’energia, addensata per via di privazione, si produce però in fittissima trama di figure di parola e di pensiero, dove prevalgono gli artifici della ripetizione ora anaforica, ora epiforica, ora in parallelismi lessicali e sintattici magari con variatio, ora in anadiplosi, ora variata nei polittoti, ora castigata dall’asindeto o, più raramente, esibita nel polisindeto. Ma la figura davvero centrale, costitutiva intorno a cui le altre si dispiegano, a ornamento e amplificazione, è l’opposizione, come in un esempio emblematico: “Il gioco del vuoto e del pieno: volersi bene, volersi male; volere di più, volere di meno”. Il lavorio dell’antitesi non si limita alle giunzioni sintattiche locali, ma si espande anche nelle più vaste aree dei campi semantici, come /buio/ - /luce/, fatti cozzare dalla comune riduzione a un’unica referenzialità, quella appunto costitutiva, dichiarata fin dal titolo: il “vuoto”.
A questa profondità del testo, ci troviamo di fronte a una domanda decisiva. Di che natura è l’opposizione? Ossia, di che natura è il nesso logico che tiene le due forze? Mantiene ciascuna la propria energia repulsiva, esacerbando così l’attrito del conflitto? Oppure, al contrario, ciascuno dei due opposti vive come dolorosa parzialità, palpita nel desiderio e nella nostalgia, di modo che nella riunione dell’antitesi raggiunge la completezza e la quiete? Il lettore di Variazioni sul vuoto non ha dubbi che la cellula nutritiva sia proprio questa seconda. Il “vuoto” è appunto il grado neutro dove la tensione s’acqueta, il bianco dove tutti i colori riposano e si fondono, dunque è il massimo ‘pieno’, è la luce che include in sé anche il buio e viceversa: “La stasi, la quiete, l'estasi”. La mossa mistica, qui balzata alla superficie delle Variazioni, estranea a una qualche religione positiva, è anche priva di fervori entusiastici, sempre trattenuta verso una postura ascetica. Altrettanto ovvie sono le inclusioni del sacro: “L'ubiquità del sacro, il suo rivelarsi ovunque – non solo nel silenzio, nelle cose riposte e segrete, nei luoghi deputati, ma in ogni angolo di via, nei momenti inaspettati”. E, come ogni sguardo mistico, s’intride dell’elemento vitalistico, anzi francamente sensuale, certo nelle forme concesse dal registro minimale dell’insieme, di modo che esso non raggiunge né l’euforismo barocco, né lo strazio espressionistico di un pur citato Francis Bacon. Diffusa è la presenza della corporeità, a principiare dall’originaria immagine platonica: “Non bastano le parole a colmare la distanza dei corpi, alla loro unità indivisa”. Giunti a questo punto, rimane una domanda, non al testo, ma al ‘tu lettore’ insistentemente evocato dalla meditazione intorno al vuoto: è davvero la quiete ascetica la postazione più feconda di nuovo senso, il crogiolo di energia contro la babele che ci soffoca?
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul "Manifesto" del 30 aprile 2021, a p.13, con il titolo redazionale Come uscire dalla palude di Münchhausen, v.a., 3 maggio 2021.
L’Io nella palude di Münchhausen
Aspetti esteriori del romanzo di Massimo Parizzi, Io, (Manni, pp.206, € 19,00), a principiare dal titolo così esposto, potrebbero farlo leggere come tardo epigono della grande sperimentazione primonovecentesca europea o collegarlo ai tecnicismi neoavanguardisti di metà Novecento. L’autore ha invece le proprie radici ben impiantate negli slanci cattolici della contestazione milanese, poi confluiti in Lotta continua. È in risposta alla successiva dispersione di vite prodotta dalla restaurazione neoliberista, che Parizzi fonda nel 1999 una rivista, “Qui. Appunti dal presente”, la quale, scavalcando le ossificazioni, i nascondimenti di collocazione sociale, istituzionale, ideologica, si proponeva di recuperare la concretezza di un “qui” vitale capace di riattivare la spinta utopica. Era un modo di collocarsi nell’onda del “narcisismo di massa”, com’è stato chiamato, tentando di curvarlo a una postura che oltrepassasse il dominio neoliberista. Il contesto va ricordato non solo per comprendere certi refrain ricorrenti in Io, come “la società è indietro rispetto all’uomo”, ma per avvicinare il significato profondo del romanzo.
L’opera si dispiega su tre piani, distinti anche graficamente. Il corpo centrale è costituito dalla narrazione in terza persona di frammenti di un “lui”; accanto ad esso frequenti fuori-campo in corsivo, in prima persona, che la nota d’autore dice “tratti per la maggior parte da miei diari e scritti, in molti casi pubblicati in Qui”; sopra di essi insistono brevissimi inserti di una riga, talvolta allineati a destra, sovente ripetuti a distanza, in funzione esplicitamente metanarrativa. La pagina si presenta dunque sempre composita, distinta in brevi sequenze. Lo stesso sviluppo narrativo solo approssimativamente si snoda lungo la biografia di “lui”, tanto vistosamente è affollato da familiari, amici, passanti, personaggi puramente ipotetici, come nell’abnorme elenco di un periodo protratto per ben otto pagine. Eppure, di nuovo, il titolo Io non è provocatorio, così come il frastagliamento narrativo non è puro gusto sperimentalista o volontà di épater le bourgeois. La stessa sostituzione dell’andamento orizzontale del tempo narrato con quello verticale – i progressi anagrafici di “lui” sono continuamente interrotti da un rifarsi da capo all’infanzia – non risponde a logiche di tipo psicoanalitico, né i frequenti ripensamenti interpretativi della voce narrante adombrano qualche intromissione pulsionale, senza increspature è il registro linguistico. Tutto è e avviene alla luce del sole, tutto, ivi compresa l’esplicita segnalazione al lettore dei salti narrativi, è condotto da una piana volontà argomentativa e razionale, in risposta al bisogno profondo di adesione diretta e ‘autentica’ al “qui” della vita di ogni individuo. Per questo sulla pagina si convocano i documenti di realtà dei corsivi, si ricorre al distanziamento oggettivante della terza persona, ci si affida al continuo raccordo dei brevi inserti metanarrativi, così frequentemente interrogativi, non di rado didascalici, talvolta a refrain anticipanti o disseminati sull’intero corpo narrativo – “Qual è la verità?”; “Chi parla?”; “Perché?”; “Che cosa c’è, in alto?”; ecc. Ma le risposte non giungono o non sono univoche, così come il tentativo ogni volta rinnovato di principiare dall’infanzia non riesce mai a raggiungere un maturo punto di vista unificante. Il mitico sguardo dall’alto sempre invocato non diventa mai reale: “Che cosa c’è, in alto? In alto ci sono le nuvole, che corrono nel cielo. C’è il cielo senza nuvole, azzurro. C’è il cielo senza stelle. E poi? E poi c’è il cielo e ancora cielo”. Così come il ‘verso dove’, da cui si attende un orizzonte di senso, attraversa il romanzo senza risposta fino all’ultima pagina: “che cosa ci sarà, dopo quei campi, fra le colline, al mare, da entusiasmarsi tanto?”.
L’io degl’innumeri personaggi-comparse, le cui brevi vicende sono assommate per associazioni analogiche alla lieve trama di “lui”, si rivela poco più che una maschera. Il vero protagonista non sono né loro, né “lui”, di cui, come si diceva, non si ha vera evoluzione, ma è la voce narrante dell’autore. Tutto il romanzo è esattamente la sua messa in scena, che indica, si domanda e risponde, interpella il lettore, interroga il personaggio, gli cede la prima persona con incrollabile costanza, con energia sempre rinnovata. La verità del romanzo di Parizzi è nello sforzo strenuo di mettere alla prova il programma del 1999: cercare nel “qui” vitale di ciascuno il comune Io. Il suo valore è nel mostrarne l’impossibilità. Che la rappresentazione di questa sorta di tentativo alla Münchhausen, di tirarsi fuori dalla palude tirandosi per i capelli, avvenga nel mezzo della sconvolgente crisi pandemica e ambientale, vera messa a nudo della feroce debolezza del dominio neoliberista che il narcisismo di massa ha coltivato, è ulteriore prova del valore e dell’onestà dell’opera di Parizzi.

Ripropongo qui l'articolo parzialmente già uscito a pagina 5 nell'inserto del "Manifesto" su Dante, uscito il giorno 24 marzo 2021, v.a., 25 marzo 2021.
Insegnare la Divina commedia
Da dove leggiamo la Divina Commedia? È una buona domanda per rispondere all’altra, fondamentale, di senso: perché leggerla? Ogni evento traumatico, nella vita privata come in quella collettiva, rompe l’equilibrio, porta allo scoperto ferite, apre nuove possibilità. A maggior ragione lo è l’avvento davvero epocale della pandemia, tanto più catastrofico perché esploso nel sonno scientista che dalla rivoluzione industriale cullava le nostre società e che sembrava garantirci per sempre. Se far vivere le potenzialità è faticoso, le ferite sanguinano subito e con esse la paura, aggravando diseguaglianze e ingiustizie preesistenti. Anche nella scuola se ne colgono i vasti segnali nelle aree biografiche e sociali più svantaggiate. E puntuali arrivano i tentativi di aggravare la tendenza a ridurre l’insegnamento ad addestramento, robustamente all’opera dagl’interventi legislativi degli anni Novanta e da noi culminata con la cosiddetta Buona scuola renziana.
La Divina Commedia permette invece di fare esperienza di due o tre competenze alternative: lo sguardo lungo contro l’idea dell’utile immediato propria dell’uomo ridotto a capitale umano; una visione universale contro il comunitarismo delle piccole patrie; la politica come presa in carico del destino comune contro la pratica di comando di ceti ristretti; l’esperienza ricchissima della lingua contro la deprivazione di quella d’uso e l’inaridimento tecnicistico dei linguaggi culturali per di più mortificati dall’impidocchiamento di anglismi che sempre più assolvono alla funzione del latinorum di don Abbondio e all’ammiccamento tra compari.
Il succedersi di generazioni di studenti mi ha mostrato ad un certo punto la necessità sempre più urgente dell’educazione linguistica per arricchire la comprensione del sé e del mondo, la consapevolezza dei doveri e dei diritti per farli valere. La particolare condizione italiana, con la sua lunghissima frammentarietà politica, ci regala la possibilità di leggere ancora senza ‘traduzioni’ la Commedia. Niente è più deleterio dell’affiancare il testo di Dante con una parafrasi parola per parola già prodotta, che i ragazzi non a caso chiamano ‘traduzione’. Sarebbe come pretendere d’imparare una lingua straniera con il vocabolario in mano. È proprio invece il recupero della profondità storica dei legami linguistici, la loro interiorizzazione che smuove l’illusione d’immobilità, da eterno presente, della lingua d’uso e insieme permette l’accesso alla ricchezza sincronica dei registri linguistici, delle sfumature sinonimiche e dei nessi oppositivi. Questo, certo, è vero per ogni testo letterario di valore, ma nessuno al grado della Divina commedia, non solo per il suo alto profilo estetico, ma anche per la posizione storica e la funzione emblematica avuta nella letteratura italiana e nella nostra lingua, tanto che solo per il suo autore possiamo usare le sue stesse ammirate parole: “Or se' tu quel Virgilio e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume?”.
In tempi che la studiosa Monica Longobardi chiama ironicamente di “medievismi”, il lavoro sulla Commedia offre agli studenti una straordinaria controesperienza in cui l’altissima fantasia di in un mondo mai visto è costantemente ricondotta al realismo quotidiano dalle innumerevoli similitudini che si disseminano nei canti, mentre il fervido slancio mistico non è mai disgiunto da una ferma sorveglianza razionale nella costruzione del poema, nella scelta linguistica e nel tessuto ritmico-sintattico, al punto che mai senti la parola forzare o sfuggire. Fatto che agevola l’esperienza della recitazione espressiva quale avvio e compimento della comprensione interiorizzata.
Sappiamo che la Commedia, ben più del romanzo manzoniano che pure lo è intenzionalmente, è sempre politica, non solo nei canonici sesti canti. Tuttavia nel traguardare con gli studenti lo studio del testo con i vuoti e i pieni dell’oggi, a un certo punto balza in primo piano una risonanza fortissima con la “selva oscura” da cui il poema nasce. Il viaggio è collocato alla vigilia della catastrofe umana - cioè politica, etica, estetica, filosofica ed esistenziale – dell’esilio, ad ogni passo ravvivato da profezie ora stizzose, ora neutre, ora intenzionalmente consolatorie. L’emersione del rimosso, il vis à vis con il carico paralizzante d’angoscia è la costanza di ogni scena espiativa, offerta al pellegrino sotto la mediazione vigile del maestro. È dalla volontà di fare i conti con quegli abbagli, con quegli errori insieme personali e collettivi che nasce il pervasivo assillo politico che accompagna il viaggio. E “volontà” è di nuovo da intendersi in senso forte, perché per il cattolico Dante non si dà grazia senza domanda: “misericordia chiesi e ch'el m'aprisse”. Fatto rilevante è la caratteristica fondamentale di questa condizione, che in Dante, si ricorda, è sempre inscindibilmente etica, estetica e conoscitiva, dunque in senso alto politico: nella tomistica classificazione dei peccati, fantasiosamente puniti nei modi più diversi, una è la colpa, differente solo nelle forme e nel grado, che emerge dalle innumeri anime, guardate con l’“occhio definitivo di Dio”, com’è stato detto: è il fissarsi del “peccatore” alla contingenza. Se nel Purgatorio tale “peccato” è già in qualche modo allontanato dalla certezza di liberarsene, solo nell’Inferno ne scorgiamo le forme più pure e violente. Ogni dannato ha la propria fissità e ognuno diversamente rifrange la biografia del pellegrino. Mille sono i modi con cui ciascuno, per dirla con Pirandello, rimane agganciato al proprio assillo.
Può, tra le mille, assumere la postura nobile quanto marmorea dell’assillo pubblico di un Farinata degli Uberti, oppure il patetismo trepido e cieco della passione familiare di un Cavalcante. O risuona nel silenzio glaciale della palude, incrinato per la breve durata di qualche terzina a descrivere con furente realismo il conte Ugolino, scena che squaderna l’orrore indicibile di un esserci eterno, incardinato qui nell’incubo della posa definitivamente animalesca della vittima-carnefice, «occhi torti», e nella fissità d’una coazione senza fine: «riprese ’l teschio». Ma ciò che inficia alla radice, quindi scaraventa nella discarica infernale energie e sforzi vitali della miriade di dannati, è stata l’incapacità di ciascuno di trascendere l’immediato, di allungare lo sguardo verso il futuro: dilettoso monte, da cui solo si può decifrare il passato e vedere il presente. Ogni immediatezza è appunto, come dice una ragione antica, reazionaria.
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul "Manifesto" del 4 marzo 2021, a p.11, con il titolo redazionale La consapevolezza dell'agire e del decidere e qualche taglio, v.a., 5 marzo 2021.
Velio Abati
Il soggetto della libertà
“La sobrietà della riflessione filosofica può giovare alla riscoperta di noi stessi come parte della natura a partire dal modo con cui oggi la natura si manifesta”, così Lelio La Porta apre il suo Libertà. Dalla prassi della filosofia alla filosofia della prassi (Asterios Abiblio, Trieste 2021, pp.62, €5,90), parte di una collana, Lessico pandemico, di cui è direttore editoriale Aldo Meccariello. Sono usciti ad ora nove volumetti, concepiti appunto come voci di lessico, da Angoscia (G. D’Acunto e A. Maccariello) a Virus (G. Chimirri), tutte pubblicazioni stimolanti e spiace che tra esse non sia ancora presente una voce di donna.
Tra i segni di quanto profonde siano le ferite della crisi pandemica, che sommuove consuetudini di vita, condizioni materiali, quadri mentali, rendendo più opaco lo sguardo sul futuro, sono da annoverare anche iniziative editoriali di singoli studiosi o collettanee che da quel vuoto di pensiero partono per tentare una risposta, come avviene, tra le altre, con il volume in via di pubblicazione Contronarrazioni. Per una critica sociale delle narrazioni tossiche curato da Tiziana Drago e Enzo Scandurra. Il tratto comune, tipico delle contingenze storiche di rapida trasformazione, è la scommessa di mettere, diciamo così, in attrito le intimazioni e le afasie del presente con il pensiero. Si tratta, dunque, non di opere organiche, né generalmente di ampia trattazione, di provenienza disciplinare varia, a indicare insomma l’urgenza della militanza intellettuale.
La Porta affronta il tema di una possibile costruzione di senso senza nascondersi il dato divenuto centrale nel nuovo secolo: lo smarrimento del soggetto, sia in senso individuale che collettivo. Un tema che l’evento disvelante, ma nient’affatto unico, della pandemia in corso ha complicato e approfondito, mettendo sotto gli occhi la questione del rapporto tra società umana e ambiente naturale. Un nodo decisivo, che comporta un ri-pensamento contemporaneo su due versanti: quale nuova società umana consapevole delle proprie ingiustizie interne e dei propri limiti esterni nella sfera del vivente; quale soggetto individuale e quale blocco sociale capaci di farsi protagonisti di tanta e drammatica trasformazione.
Lelio La Porta concentra il suo sguardo sul problema della libertà, che è appunto la possibilità dell’agire e del decidere, prendendo avvio da Hanna Arendt, sviluppando poi il suo ragionamento fino a Marx, Gramsci, Che Guevara, senza trascurare pensatori antichi e liberali. Dalla riflessione arendtiana, contro lo smarrimento odierno l’autore prima deriva il nesso inscindibile tra nascita e libertà – del primo essere umano e di ogni individuo – dunque la capacità inalienabile, propriamente umana di creare qualcosa non esistente prima, ovvero il nuovo che è la Storia; poi rischiara l’espressione “il potere è del popolo” tramite la nozione centrale di “potere”. “Potere” è lo spazio della libertà, il luogo della comunità di azioni e di parole, dove, per usare la celebre formula marxiana “il libero sviluppo di ciascuno è la condizione del libero sviluppo di tutti”, concetto radicalmente opposto, dunque, alla coercizione di chi governa che invece lo nega. Da qui l’autore, constatato che “i partiti politici organizzati nel senso della democrazia che si organizza non esistono più”, vede aprirsi la possibilità per i subalterni di “organizzarsi spontaneamente, partendo da piccole comunità che resistono, al fine di creare un movimento che parli”.
Un’operazione possibile e necessaria a condizione, dice La Porta sulla scorta di Gramsci, che i subalterni, presa consapevolezza della loro sottomissione all’immediato interesse economico-corporativo, accedano alla superiore dimensione etico-politica: “che cosa è messo in discussione dal controllo digitale verso cui si sta andando, soprattutto nel mondo della scuola, per non parlar d’altro? È tempo di scelte. Tertium non datur: o le tecnologie sono mezzo e non fine, oppure il dominio della necessità, sotto forma di invasività di tutte le aziende che proporranno programmi sempre più nuovi per i pc, imporrà progressivamente la sua estensione. Di nuovo globalizzazione, di nuovo il mercato. La vita dell’umanità non può essere legata alla coercizione del mercato. Libertà vuol dire demercificare la vita!”.
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul "Manifesto" del 3 febbraio 2021, a p.10, con il titolo redazionale La sorveglianza del mondo, v.a., 4 febbraio 2021.
Velio Abati
Da ripide balze
Su Non tutto è dei corpi di Giorgio Luzzi
L’ultimo lavoro di Giorgio Luzzi, Non tutto è dei corpi (Marcos y Marcos, Milano 2020) è bersaglio perfetto di quel sentimento che ebbe a confessare Fortini: “la mia invidia è per quei poeti che scrivono un vero e proprio «libro» di versi”. Infatti la fertile vena dell’autore, che si è sempre mossa lungo questa direttiva, raggiunge forse qui la sua forma più compiuta di opera organica in versi. Per Luzzi la poesia è insieme la chiave di accesso al mondo e risultato, resoconto dell’esperienza, “biogramma”, appunto. Per questo la tensione con cui guarda alle ferite del presente e della storia è incessantemente intrecciata con la biografia personale: l’opera è una meditazione morale sul mondo e sul sé, mentre l’amore e la diffidenza – che possiamo dire etica - per la lingua, cifra costante della produzione luzziana, intessono l’ordito poetico di frequenti rinvii metariflessivi sulla poesia come opera e come attività. La meditazione, qua e là sollecitata dalla cronaca, sempre in reazione ai precipizi e agli urti del presente, è condotta da un petrarchesco interno, già dichiarato nel componimento introduttivo: “valutare il mondo da un fermo davanzale / fin che la vita […] si nutre del tempo che ci è dato”. L’autore ci si presenta nella sua vecchiaia: “è la nebbiosa che irrompe / tua nostalgia senile”, scrive in Parlare dell’Io nell’ora d’aria. La notazione anagrafica è da tenere a mente anche per il titolo, meglio chiarito dai rinvii tra un libro e l’altro, autorizzati dalla poetica accennata: Non tutto è dei corpi non indica, come a prima vista potrebbe apparire, una protesta genericamente spiritualista, ma il colpo di reni contro l’oscuro, irrimediabile intorpidirsi del corpo nella vecchiaia, già affacciatasi in forma più chiara e leggera nel titolo dell’ultimo lavoro poetico, Troppo tardi per Santiago.
Proprio da “queste scoscese / temutissime soglie” il poeta è indotto a forzare sul pedale, costitutivo della sua vena creativa, del controllo intellettuale in funzione distanziante e certamente difensiva, “non tutto è dei corpi”. È un gesto di resistenza strenua, a costo d’incorrere in qualche rischio per eccesso di estenuazione. Ed è da questo dissidio che nascono le novità più importanti del libro. La sorveglianza costruttiva qui giunge, per esempio, a rimarcare le sei parti in cui l’opera è divisa, preceduta com’è da componimenti in funzione di proemio, né si tralascia di sottolineare l’unità dell’opera, ponendone in rilievo i punti estremi con l’introduttiva Carte d’entrée e con i tre componimenti conclusivi: In versi e in rima E grato a chi sia qui, Fischiettando dopo lo spettacolo e Rogolo in mente di cui rimarchevole è il verso che suggella testo e opera: “la inquietante unità tra morte e vita”. Le sei parti polarizzano ciascuna i temi costantemente cari al poeta. Nella prima campeggia l’opera pittorica alla quale, per altro, spesso Luzzi ha dedicato scritti saggistici. L’attenzione va dal quattrocentesco Niccolò dell’Arca, fino all’amico Marco Seveso, cui è indirizzata la tenera commemorazione funebre conclusiva della sezione: La terra ti sia lieve. I solitari luoghi alpini predominano nella seconda, i cui nomi sono evocati con la misteriosa confidenza dovuta agli affetti segreti. C’è, in Luzzi, una fiducia nella forza dei toponimi e poi estesa ai nomi propri che potremmo dire onomatopeica, la quale non piega alla giocosità di uno Scialoja, ma dissemina all’opposto premonizioni di morte. Drammatica la chiusura di questa parte, che crudamente contrappone l’incidente mortale di un giovane alla grottesca finzione idilliaca dell’uso turistico della montagna: “pace a voi brava gente E per di più / vi allestiremo spettacoli dal prato / Garantiremo sia chiaro / lo spettacolo assicurato”. La terza sezione si divide tra un romanzo d’infanzia-adolescenza e i temi collettivi, come l’ecologia e il dramma dei migranti rievocato tra l’altro da un testo alla Whitman, Mia capitana, esplicitamente dedicato a Carola Rackete. Va detto di passaggio che, dopo i pittori, gli omaggi a poeti si disseminano per l’intero libro. Nelle due ultime parti la polarità della riflessione torna sul sé vecchio alle prese ora con i migranti sperduti nel paesaggio urbano, ora con un più marcato trasporto nostalgico.
Ma la pressione forse maggiore della presa di distanza dall’angoscia e dal disfacimento si verifica più intimamente e più diffusamente sullo stesso tessuto linguistico. Non parlo del materiale lessicale, che il ripudio della trita lingua comune e l’amore per l’acume intellettuale spingono, come di consueto, a un registro alto di termini colti, di inserti francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, di usi etimologici, di neologismi, sperimentalismo che in questa opera si spinge per un verso fino all’abolizione completa della punteggiatura, affidando il segnale della partitura sintattica al solo impiego della maiuscola, per l’altro saltuariamente abbassando la funzione emblematica del titolo che, pur conservando graficamente la sua posizione, è in realtà riassorbito sintatticamente nel corpo del testo. La novità più significativa avviene invece nella strutturazione ritmica. Se altre volte mi è capitato di mettere in evidenza della produzione luzziana la rilevanza della densità semantica ottenuta per il convergente lavoro sul registro linguistico, sulla strutturazione sintattica, sull’oscuramento del valore musicale del ritmo e dove ininfluente era il gioco delle rime, qui il criterio costruttivo è energicamente ribaltato. Per quanto Luzzi non si sottragga alla sensibilità novecentesca che vuole il ricorso alle misure della tradizione poetica solo come echi, suggestioni, riprese mai troppo protratte senza infrazioni e sbreghi, in tutta quest’ultima opera fortissima è l’impronta tanto della classica alternanza di endecasillabi e settenari quanto, nei versi lunghi, dell’ottocentesco settenario doppio. Ma non mancano ottonari, novenari, decasillabi. Non rara, addirittura, è la rima baciata. Una varietà ritmica, insomma, la cui percussività fa qua e là affiorare ora echi di settecentesche ariette d’opera: “o inetti forse giova per finire / lasciarsi vezzeggiare / dall’onda lagunare di legni veneziani?”, ora esce in citazioni discretamente indicate dal solo corsivo, come in questa dal libretto di Da Ponte per il mozartiano Don Giovanni: “e son certo che l’ama” o quest’altra dall’eponima quartina di Michelangelo Buonarroti: “però non mi destar deh parla basso”, ora, piegando a una vaga suggestione dei canti popolari del maggio, Maggiolata, affida ai distici di settenari doppi con rima baciata il compito di tenere sotto morsa l’assalto dell’angoscia: “per questo cantiamo amore e libertà / cantando ai vivi giuggiole e ai morti eternità”. Il gioco giunge fino allo scherzoso anagramma del titolo Nove nari, preposto a una composizione di strofette di novenari con rime baciate variamente distribuite e addirittura, contraddicendosi – ma l’esperienza è presente nella sua produzione ‘privata’, come ho ascoltato dall’autore nella sola forma orale -, a un impiego alla Scialoja: “si sa sono orsi di riso rosi a San Siro!”.
Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul "Manifesto" del 16 gennaio 2021, a p.11, con il titolo redazionale La riserva dello Zingaro nel cuore poetico e linguistico della Sicilia, v.a., 17 gennaio 2021.
Velio Abati
Dialetto e lingua in Giuseppe Cinà
L’agile volumetto presenta una nota ampia in cui l’autore, architetto e urbanista, si premura di documentarci la geografia dell’anima tramite cartografia storica: la trapanese Riserva dello Zingaro, presso Castellammare del Golfo, ove si trova “un ristretto territorio rurale denominato Sparauli” (p.103), nido dell’opera. Un’esigenza documentale che dalla storia del territorio si allarga a quella della sua microcomunità e giunge allo scrupolo d’indicare le coordinate della miscidanza linguistica dei componimenti, non dimenticando di concludere con un breve regesto di notazioni tecniche sull’ortografia. Medesimo atteggiamento l’autore tiene con il corpo del testo poetico, informandoci che nella prima parte (Cuntu ri Sparauli- Racconto di Sparauli) la voce poetante è quella dell’autore medesimo, nella seconda (Za Rosa) di “una vecchia contadina […] cresciuta all’interno di Sparauli” (p.103), mentre dei testi in lingua a fronte se ne indica sì la funzione di servizio, ma anche l’intento “di pervenire a un costrutto dotato di una pur semplificata impalcatura poetica” (p.127).
In altre parole, Cinà si colloca in un’area culturale e, vorrei dire, morale d’importanza primaria oggi la quale, segnalando i danni ambientali e culturali della grande trasformazione della modernità, intende indicare l’urgenza di un ripensamento e anche di un recupero. Per rimarcarlo, l’autore si pone in modo esplicito tra la propria voce poetica e il suo lettore. Situazione davvero interessante, questa, perché la pressione documentale e persino pedagogica apre una frattura tra Cinà poeta – privato e ignaro per dir così del grande mondo – e Cinà adulto, che sa “di greco e di latino”, accanto appunto al proprio lettore. Il rischio è di confermare nel suo conforto il lettore medesimo. L’opposto di quanto accade, mettiamo, a quello verghiano, gettato in un tour de force di sopravvivenza, non alleviato dalle fate morgane di luoghi falso-noti.
La prima parte, di ventidue componimenti, è costituita da altrettante brevi descrizioni di microeventi in presa diretta del paesaggio naturale, rarissime le presenze umane, più insistite nella conclusione. Il dialetto agevola e forse indirizza, come accade in una vasta area della poesia dialettale, la rimemorazione. Lingua materna per eccellenza, tanto più forte quanto più essa è distante dall’italiano e quanto maggiore è stato l’apprendistato all’età adulta della cultura, linguistica e sociale, essa rende possibili confidenze altrimenti impensabili e addirittura rimosse. Cinà giunge per questa strada a esiti suggestivi dove, scomparso il tempo storico, un’alba, uno scroscio di vento, l’ondeggiare d’un campo d’avena appaiono sgorgare dall’origine innocente del mondo. La vena nutritiva è dunque un trasporto vitalistico, che a volte accede alla nostalgia, più evidente quando affiorano figure umane, come nella toccante e rattenuta rievocazione paterna:
Ah, patri miu, si putissi virìriti na vota…
comu antica luci ca trimulìa
ntra i fitti fugghiami
ri sti àrbuli ancora vivi,
pensu ca t’attruvassi a taliàrimi
cu na sprissioni sirena,
p’unn ammustari i to granni pinseri.
Sensibile è il cambio nella seconda parte, che si vuole voce di una vecchia contadina cresciuta, appunto, a Sparauli. La parola, non più in presa diretta, accampa in primo piano l’io narrante. La lirica dei minimi eventi naturali cede alla cantata autobiografica della vita di Za Rosa, di cui i gli undici componimenti sono altrettante tappe. Le necessità pratiche e materiali, il rapporto tra sé e il padre – protagonisti incontrastati della seconda parte – occupano ora l’intero quadro, coerentemente con il mutato punto di vista. E tuttavia si avverte, a mio parere, sotterraneamente uno iato tra quei fatti e la voce che ce li riferisce. Le vicende rurali del lavoro, dell’accudimento di cose, piante e animali che saturano il giorno corrono il pericolo del calligrafico, dell’eccesso di levità, anche se il racconto riesce ad asciugare la tentazione non piccola della nostalgia.
Ringrazio Lorenzo Pallini del permesso di caricare anche qui il filmato della sua intervista con me del 22 ottobre 2017 su Franco Fortini, v.a. 13 gennaio 2021.

Ripopropongo qui il testo apparso sull'"Ospite ingrato" on line, v.a., 17 dicembre 2020.
Velio Abati
Ogni scuola è politica
Sulla “Scuola 725” di don Roberto Sardelli
Roberto Sardelli e Massimiliano Fiorucci, Dalla parte degli ultimi. Una scuola popolare tra le baracche di Roma, prefazione di Alessandro Portelli, Donzelli, Roma 2020.
Frequenta la scuola, senzatetto!
Procurati sapere, tu che hai freddo!
Affamato, impugna il libro: è come un'arma.
Devi esser tu la guida!
Non aver timore di chiedere, compagno!
Non far credito a nulla,
guarda tu stesso!
Quello che non sai di tua scienza
in realtà non lo sai.
Verifica il conto:
sei tu che lo paghi.
Poni il tuo dito su ogni voce
e chiedi: perché questa, qui?
Devi esser tu la guida
(Bertolt Brecht, Elogio dell’imparare)
Non fa dunque meraviglia che un giovane ribelle amiatino, processato appena compiuti i diciott’anni, arrivato al carcere di Ponza guardasse con gioia la bibliotechina lì disponibile. E certo non sorprendono le parole con cui quel giovane, divenuto in seguito comandante Viro della brigata garibaldina “Spartaco Lavagnini” e poi dirigente del Pci, stretto collaboratore di Pietro Secchia, ricorda con fierezza i sotterfugi rischiosi per far circolare i libri: “esisteva una biblioteca clandestina, i cui libri venivano nascosti in buche scavate nei pavimenti e nei muri” (Fortunato Avanzati, Il seme sotto la terra, La Pietra, Milano 1996, p.46).
Ma il fenomeno ha un’estensione sociale e cronologica ben più ampia dell’ambito intellettuale e politico appena indicato. Di mio nonno paterno, Lorenzo, nato nel 1901, rammento con precisione i racconti della sua autoalfabetizzazione, perché, “garzone” già in età scolare, non aveva mai frequentato un giorno di scuola. È grazie a quei racconti, alle parole di mio padre “se non sai parlare, non ti difendi”, che vedevo maneggiare con fatica la penna, se ho stretto i denti e sono andato al liceo.
“La scuola è meglio della merda”, scrivevano i ragazzi di don Milani a Barbiana; “la penna è più leggera della zappa” (p.137) ripete don Sardelli. Il primo merito della ricca intervista di Massimiliano Fiorucci è proprio nell’evidenziare questo punto politicosociale e, vorrei dire, umano di un’intera epoca storica. Ferita che l’opera dei due preti, con altri, mostra in tutta la sua portata drammatica, in tutta la sua urgenza, ben evidenziata dalla severa postura anticotestamentaria dei due religiosi.
Come si è detto, il legame tra subalternità sociale e necessità dello studio non è certo chiaro solo a uno sguardo cristiano, ma sarebbe interessante interrogarci perché in quei decenni di accesso alla modernità, in pieno boom economico, siano stati alcuni austeri preti a coltivare con più intensità questo terreno. Credo che qui conti il primato dell’esempio, di lunghissima tradizione cristiana, anche in esplicito disprezzo del teorizzare. Ma penso che si debba cercare anche nel come e nel perché di modificazioni intervenute nel campo politico della sinistra.
Le discrete sollecitazioni di Fiorucci fanno riemergere, insieme con la passione e l’impazienza che sentiamo vibrare nelle parole, le situazioni, le persone, le scelte, le penurie materiali, le conquiste e le sconfitte che intensamente hanno stretto emarginazione sociale e apprendimento, studio. Una necessità così lacerante che chiamava a niente di meno che a una scelta totale. Davvero dobbiamo dire che verbum caro factum est, che la parola lì si è fatta carne fisica e sociale, affinché questa potesse accedere alla parola. La libertà della ripetizione, che l’intervista in qualche modo mantiene dall’oralità, asseconda l’urgenza ancora viva nel vecchio don Sardelli, che così regala al suo lettore numerosi esempi e prove assolutamente convincenti del legame inscindibile tra sfruttamento sociale e studio, affinché il bisogno diventi diritto consapevole e agito. C’è, nella vicenda ripercorsa da don Sardelli, un momento topico. Il vescovo vicario, saputo della lettera che gli scolari della “Scuola 725” stanno scrivendo al sindaco di Roma, chiede al prete di essere lui ad andare a parlare con il sindaco. Il rifiuto energico, al limite della disubbidienza ecclesiastica nasce dalla lucida consapevolezza che il gesto avrebbe vanificato l’azione pedagogica la quale, prima che nelle parole scritte, è nell’atto stesso del parlare, garanzia, questa, che il bisogno si faccia diritto e non retroceda a favore. Lettera, appunto, ora al sindaco, così come pochissimi anni prima era stata con don Milani Lettera a una professoressa. È per eccellenza il genere del discorso agito in prima persona, in cui il soggetto prende corpo e parola senza intermediazioni. Il genere ha lunga e prestigiosa tradizione cristiana, sia neotestamentaria che patristica, ma certo travalica tanto verso la letteratura latina quanto verso la tradizione moderna.
A più riprese, anche per impulso di Fiorucci, don Sardelli, in sede di sguardo retrospettivo, esprime il rammarico che la propria esperienza didattica non sia diventata sistema. Adduce ora la mancanza di tempo, ora l’impellenza delle domande dei ragazzi, ma una lettura appena accorta non tarda ad accorgersi che l’impedimento era più profondo, originario direi. L’insofferenza e anche la rudezza con cui allontanava gli studenti universitari o coloro che cercavano di unirsi a lui nell’opera educativa e di “coscientizzazione” indica che quel contributo veniva sentito come una corruzione del rapporto esclusivo tra lui e i discenti. Credo che una radice della mancata capacità egemonica di quelle esperienze vada cercata proprio nell’assolutezza del primato dell’esempio. Come indica il più volte ricordato insegnamento ricevuto da don Milani – “stai zitto!” - quell’assolutezza dell’esempio è la risposta obbligata del divieto insuperabile imposto dalla gerarchia. Al contempo è stata la condizione che ha permesso la dedizione totale, la sua mirabile radicalità. Ma il prezzo è la sua amputazione: il fiero proclama del manuale scritto dai ragazzi della “Scuola 725”, Non tacere, ha la sua possibilità nell’accettazione dello “stai zitto!”. Sarebbe interessante, su un piano di documentazione storica più piena, conoscere i risultati di medio, lungo periodo di quella e di altre esperienze analoghe, attraverso la raccolta sistematica dei dati sui percorsi successivi degli allievi.
Non c’è dubbio, tuttavia, che al di là dei singoli esiti e della medesima particolarità storica non facilmente riproducibile, se non in contesti socio-culturali di analoga emarginazione e deprivazione, l’esperienza didattica della “Scuola 725” dell’Acquedotto Felice mette bene a fuoco una questione generale, decisiva dell’azione pedagogica, ben sottolineata anche da Fiorucci: l’inscindibilità tra condizione concreta di vita e progetto didattico. Tale legame comporta conseguenze su due diversi aspetti. Uno è interno alla pratica didattica. Non si attiva l’interesse a sopportare la fatica dello studio, non si fa affiorare alla consapevolezza il bisogno, se non si parte dalle concrete condizioni materiali, affettive e spirituali del discente; questo mancando, la pura imposizione istituzionale e d’autorità, ove sia presente, può tutt’al più costringere a un addestramento esteriore, che non diviene patrimonio posseduto: è la situazione che nel gergo didattico viene detta apprendimento meccanico. Condizione ben illustrata dall’esempio, testimoniato da un mio vecchio compagno, di un ragazzo che studiava a scuola la nascita e la propagazione di certi parassiti delle piante, mentre nella pratica della sua vita di contadino continuava ad aderire alla convinzione tradizionale della nascita spontanea.
Un altro aspetto riguarda invece la natura profonda, intima e ineliminabile di qualsiasi progetto educativo e didattico. Ogni apprendimento, anche quello più tecnico, sia è esso stesso trasformazione del soggetto, riorientandone capacità d’interazione nel mondo e visione di esso, sia è in vista di un’azione sul mondo, ossia prefigura una certa trasformazione materiale e sociale. Dunque, come con tutta l’energia e lo scandalo possibile grida più volte don Sardelli, ogni azione didattica è azione politica. Anzi tanto più è politica, nel senso peggiore di nascondimento e passivizzazione, quanto più essa si pretende distante dalla politica e dall’ideologia. Qui tocchiamo uno dei punti più fertili dell’ampio ragionamento dell’intervistato e dell’intervistatore, perché quel grido torna oggi attualissimo, non solo contro i nuovi e crescenti reietti della migrazione dai sud del mondo, ma direttamente contro la violenta restaurazione compiuta dal quarantennale dominio neoliberista verso la scolarizzazione di massa e le sue aperture metodologiche, di cui la “Scuola 725” è parte. Misure politiche, direttive europee, pratiche sindacali, letteratura di settore, pensiero dominante, gettato con disprezzo nel fango ogni domanda su quale cittadino e cittadina, per quale società, hanno proclamato l’arretratezza della scuola rispetto alla società e i suoi costi e i suoi sprechi, gridando che è la società, quella esistente ben inteso, a essere nel giusto, a essere il metro, a dover dettare alla scuola temi, metodi e fini, perpetuando così, anche in via teorica, rendendolo naturale, anzi accentuando il dominio e lo sfruttamento, lo sfregio dell’umano.
Se guardiamo più nel dettaglio alla scuola di don Sardelli, ai suoi contenuti, salta agli occhi il valore anticonformista e la forza contestativa della cronaca – con la lettura del giornale – e della storia contemporanea, con la lettura di saggi, che aprivano ai ragazzi la realtà nazionale e internazionale di cui erano parte eppure sottratta al loro sguardo quotidiano. È la rivendicazione contro il conformismo antideologico e passatista della scuola, che la “Scuola 725” condivideva con l’assai più ampio movimento contestativo degli studenti del cosiddetto Sessantotto. Per la verità, anche per altri aspetti la didattica di don Sardelli confluiva nella più generale pressione che giovani, studenti, donne, immigrati, lavoratori portavano nella scuola, nella famiglia, nei consumi culturali, nelle istituzioni con spirito di rivolta antiautoritaria, antirepressiva e antiqualunquista. La rivendicazione del presente sul passato veniva sentita ed era un disvelamento. Credo che un giovane lettore odierno faccia fatica a comprendere. Abbiamo anzi quotidiana esperienza della saturazione del presente e della “globalizzazione” come oggi si dice, al punto che lo smarrimento del sé e il soffocamento di chi non sa vedere vie d’uscita non nascono dall’oppressione del passato, ma dalla nausea del presente. Oggi il presente, il globale non è la soluzione, ma il problema, non lo sguardo di Athena, ma la testa di Medusa. Oggi si deve educare alla disciplina di forare la crosta del presente per dissotterrarne le vene che lo nutrono dal passato e portare alla luce il futuro che solo gli dà senso. Allo stesso modo, la falsa contemporaneità della globalizzazione sottrae allo sguardo sfruttamenti, differenze di classe, di orizzonti mentali e insieme i legami che invece li nutrono, producendo il doppio accecamento di chi, non vedendo le differenze, la esalta come il migliore dei mondi e di chi, non vedendo i legami, rivendica come diritto il razzismo e la violenza di sangue e terra.
Si trattava, dice don Sardelli, di “rompere questo muro di silenzio che circondava” (137) i ragazzi, parimenti celebre è la pagina della Lettera a una professoressa dove viene affermato che la timidezza dei ragazzi di Barbiana non è del carattere, ma della loro condizione di classe subalterna. Anche per questo aspetto si fa fatica a riconoscervisi oggi, quando la difficoltà a parlare è mascherata dall’urlo facile sulla tastiera. Il pregio dell’intervista di Fiorucci, avvenendo dopo tanti anni, costituendo anzi un testamento, è anche nel permettere al protagonista una distanza che dà modo d’indicare il mutamento. “Quando qualche grande – dice don Sardelli – osava dirmi «Ma stasera c’è Mina alla televisione». «Stasera faccio la riunione! Io sono superiore a Mina, perbacco! Che me ne frega a me! Stasera faccio la riunione!». Oggi non avrei più questa forza, mi manderebbe a quel paese. Allora io lo facevo e mi obbedivano” (p.137). Portato dall’intervistatore a confrontare quella stagione con il presente, il prete sembra chiudere il suo testamento su una nota disperata: “L’esperienza nostra è stata una fase non digerita […] Perché ha vinto un modo di vedere i rapporti scolastici opposto. Quando mi chiamano dico: «Che mi chiamate a fare? Devo fare il pezzo da museo?»” (p.148).
Ma l’esperienza didattica di don Sardelli, come quella di don Milani o di altri del medesimo periodo storico non è oggetto museale, è brace viva nella trama del presente a mostrare, a chi non sia cieco per interesse, che sempre la scuola è politica e ad additare un’urgenza insopprimibile: nessun discorso, nessun movimento per una scuola diversa può principiare, se non prende corpo una politica che pensi e voglia diversa la società, cosa questa possibile solo se essa chiede protagoniste le classi subalterne.
Ragioni di fuga
Non è facile parlare di ciò che sono, piuttosto che di ciò che vorrei. Ciò che vorrei è l’affiorare della ferita profonda di quanto il ciò che sono amputa e soffoca, getta nello scarto, nella vergogna di dire; è il ‘no’, la leva della rivolta e la promessa degli strumenti perché sia reale. È dunque il coraggio necessario, la negazione vitale. Ma proprio l’energia che la mossa ha convocato, il godimento risarcitorio procurato dalla sua conquista spingono a fissarsi, gettando in un’irrealtà vagamente paranoica, scambiata per soda conquista.
Occorre sopportare le repliche della realtà, la forza d’ascoltarle per avvicinare il taglio che sloga ciò che vorrei da ciò che sono. Quest’ultimo, lasciata cadere l’evidenza immediata che ti appariva, mostra il suo essere nella storia, intanto che la severa lezione della realtà ti squaderna quanto parola dura sia “storia”: il suo tempo non è un flusso omogeneo né unidirezionale, ma una stratificazione complessa e contradditoria sempre aperta alla possibilità della retroazione; il suo spazio si frange in innumeri differenze e contrasti individuali, sociali, geografici. Per converso, il ciò che vorrei, proprio in conseguenza della dispersione in cui è preso ciò a cui si oppone, non è più la negazione meccanica del ‘no’, ma la propria funzione critico-negativa si carica della totalità che alle determinatezze storiche del ciò che sono contrappone il proprio tenersi nella distanza del possibile.
Doloroso è allora sostare di fronte alla ferita che più viva e profonda ti si mostra, perché nella veglia devi accogliere proprio quanto di te è mutilato, sconfitto, umiliato. Più invitante allora appare la rimozione. Chi è dentro la morsa di questa dialettica conosce il peso di scrivere di ciò che si sa. Io certo difetto di fantasia e forse ne diffido.
Un lungo apprendistato ho dovuto sostenere per comprendere che le due lacerazioni del mio giorno non erano mia fantasia, né che, contro tutte le apparenze e tutti gl’interessi, esse possano essere separate. Se m’aggrappo a ciò che vorrei mi appago della conquistata certezza di un orizzonte di senso della cui mancanza freme ogni istante, ogni fibra di ciò che sono, ma mi chiudo fuori della temporalità, postura che conduce al dogmatismo e, sul piano pratico, alla conservazione, quando non alla reazione e al settario.
Se mi lego a ciò che sono, so aprirmi alla consapevolezza del limite, alla disponibilità della tolleranza, ma mi acceco sulla gerarchia delle verità, cancello la diseguaglianza con la diversità: lo sfruttamento dell’essere umano sull’altro essere umano diventa impronunciabile. Lo stesso flusso storico, ridotto a somma puntiforme, proclama un presente sempre ritornante.
La prima è la voce della classe sociale dominante sconfitta o che è nell’agonia del proprio dominio, che per paradosso può vestire le forme della rivolta settaria; la seconda è invece il canto apologetico di quella al potere, che sempre proclama se stessa termine della storia.
Per quanto scandaloso invece possa essere, per quanto difficile a sostenerne lo sguardo, devi tenere insieme la verità storica del ciò che sono e la Verità di ciò che vorrei, ossia la totalità che fonda la prima nel mentre che le si sottrae. La totalità, proprio perché si tiene nella sua distanza, è l’orizzonte della conoscenza e della pratica. Storicamente è stato chiamato “comunismo”, il quale senza il movimento di conquista di quell’orizzonte rimane parola priva di senso.
Il rapporto tra i due lati è storicamente determinato. Il processo di avvicinamento pratico della verità alla Verità, generato dalla complessità dei conflitti sociali, conosce accelerazioni e regressi. Una semplice descrizione sociologica dell’ultimo trentennio, sufficientemente onesta da evitarsi il servilismo al becerume ossessivo, registra come tra gli uomini le ereditate diseguaglianze, di genere, familiari, di reddito, di luogo geografico non dico che diano speranza di essere attenuate, ma si aggravano sanguinosamente sino a essere questione di vita o di morte. Per questo il nostro è il tempo della migrazione. E certo nella parola clandestino scagliata contro il migrante, l’autodenuncia del dominio non è inferiore alla proclamazione della paura. Solo la cieca presunzione illude per un attimo o per sempre che clandestini siano solo gli altri. Ma quando nell’immanere è la morte del tempo, la speranza rigermoglia nella fuga.
Non si vuol sostenere che la fuga sia condizione permanente, così come che a essa sia intimamente, cioè sempre negata la misura della ragione e persino il godimento della bellezza. È uno strappo del tessuto esistenziale, del flusso storico dove l’energia dell’appello fondativo a un orizzonte di senso s’impenna a far cozzare passato e futuro, disperazione e speranza, linguaggi differenti, codici concettuali gravi di storie incomunicanti, cosicché opposizioni, analogie, conflitti precipitano congiuntamente a tutto chiedere ragione.
Negli ultimi trent’anni lo scrivere ridotto a vizio privato, la scrittura critica ristretta alla pagina di diario s’installano a emblemi, non appena si consideri l’aggressione agli alti studi, in particolare umanistici, la colonizzazione non dico dell’industria culturale, ma della stessa comunicazione sociale, la regressione della scolarizzazione di massa, la negazione esplicita della necessità di un orizzonte di senso, in sintesi, com’è stato autorevolmente dichiarato: la vittoria del capitale nel conflitto di classe. Vi vedo non solo l’inevitabilità, ma persino la verità del mio parlare di me.
Per quanto la totalità sia solo un orizzonte possibile, la sua necessità è immanente, non può essere senza danno messa tra parentesi, rinviata a momenti migliori: la scrittura, benché pura scommessa, deve farsene carico, perché unica uscita dall’afasia, dall’insensatezza. Nell’operare concreto s’impone il montaggio plurimo, mentre proprio l’accidentalità, l’azzardo persino della scommessa dialettica condanna la scrittura a un procedere sincopato, a sobbalzi nel vuoto, a impennature, che implorano la collaborazione del lettore, scegliendolo non tra i distratti, gl’ipocriti, i frivoli, i cinici. Le difficoltà, quando ci sono, non sono mai godute: o, raramente, hanno il valore che i linguisti chiamano “fàtico” del tipo “pronto?, mi senti?” verso il lettore; oppure sono subite in quanto portato diretto rei ipsae, dato, insomma, non fine.
Da ultimo, la convinzione che le ragioni da difendere travalichino di gran lunga le povere cose e forze di chi scrive o, se si vuole, il sano senso di colpa, il sapere che scrivere ti colloca – voglia o non voglia – in una discendenza che in Occidente sale agli albori omerici, il sentire la responsabilità e il godimento di una lingua in cui fermentano il sentore della terra lavorata, il sudore e i canti di mille anni di mia gente contadina, le vette della Commedia, l’ira di Didone, il ritmo aspro del Principe, il canto di Saffo, per tacer di mille altri, non possono che costringermi a una lingua appena, appena degna di quel fervore.
3 dicembre 2020
Nella notte, forse un bramito
È necessaria l’analisi della realtà, scrivete, amiche, “dell’attuale situazione del sistema formativo – anche a partire dalla lettura di dati statistici, ad esempio sulla dispersione scolastica e sul calo di iscrizioni all’università – con riflessioni di carattere storico-teorico e pedagogico”.
Niente di più giusto, niente è necessario di più.
Ma il primo problema, giunto oramai a supporazione, è proprio il “con” che connette raccolta dei dati e riflessione teorica. Non parlo di epistemologia, ma di materiali aspetti pratici e politici. Nel lungo crepuscolo che da un trentennio inghiotte speranze e generazioni intere, giungendo a crollare i confini umani dei continenti e persino a scuotere le profondità glaciali, intatte da milioni d’anni, non sono mancati regesti, scrupolose raccolte di dati e severe militanze, capaci d’intransigenza e durata.
Perché, allora, quelle voci sono ricadute sulle medesime teste, perché quei gesti e opere non hanno attraversato il primo cerchio della loro onda? Perché quei mille fuochi non hanno illuminato la notte? Da quando il trionfo della rivoluzione passiva compiuta dall’iperborghesia internazionale ha ricondotto la libertà nel recinto dell’individuo proprietario, ogni rapporto, ogni legame con l’altro è diventato un contratto. Tra individui proprietari non è escluso certo l’accordo, il riconoscimento di un vantaggio reciproco, ma include l’accettazione ferrea del “godimento esclusivo”, come recita il codice. L’accordo è il riconoscimento formale della reciproca (pacifica?) riduzione dell’altro a strumento: il titolare del “godimento esclusivo”, come il rex absolutus, non tollera di riconoscersi parte di una terzietà che con l’altro forma e trasforma. L’aspetto forse più drammatico, che la distruzione della natura e dell’umano di questa notte ci pone sotto gli occhi è il fatto che la riduzione a strumento di ogni rapporto con l’altro finisce per capovolgersi sul soggetto: ognuno, senza saperlo, rende il proprio corpo, i propri pensieri, la propria vita strumento. Il godimento non solo è consumo della terra, è anche distruzione di sé: l’energia del principio di piacere travasa nell’istinto di morte.
In così fatta rarefazione d’ossigeno, lo stesso mettersi insieme o assume la forma esplicita e rivendicata di somma delle parti, non di collettivo parziale che si senta con orgoglio appartenenza a una totalità da costruire; oppure soffre dell’isolamento, delle cadute di tensione inevitabili in ogni movimento, per essere alla fine risucchiato dal vuoto, o invece incistito nell’assenza di risonanza. Gli ultimi trent’anni sono pieni di siffatti esempi, spesso splendidi, non infrequentemente lucidi e lungimiranti, quasi sempre generosi. Ma la notte è alta nel cielo.
Qual è, mi chiedo di fronte alla vostra affettuosa domanda, l’olio del mio scarso lume? Da pochi giorni sono “fuori ruolo”, non ho più la mia scuoletta, non sono più nella trama che regge il tessuto sociale, non sono più “indispensabile allo sforzo produttivo”, scrive graziosamente un tale che si distingue per aderire in modo tanto spontaneo al sistema che ci comanda, da non aver mai veduto la propria cupidigia di servilismo, mentre crede in buona fede di comandare. Né ho da offrire numeri, statistiche che assai opportunamente chiedete e io chiedo. Ma una voce corale, giovane e fraterna mi ammonisce da una copertina sul mio tavolo: non tacere.
Da anni vado osservando e ho ripetuto nei pochi scritti, nelle numerose mie classi il programmatico smantellamento della scolarizzazione di massa, ottenuto con la via breve della chiusura della borsa, rinforzata dai barocchismi burocratici tinteggiati con oro falso di scienza e tecnica. Così a lungo andare abbiamo raggiunto il doppio obbiettivo sia dell’abbandono scolastico e universitario, sia del mostruoso analfabetismo funzionale (saper leggere un articolo di giornale senza riuscire a capirne il significato, ci dicono gli studiosi) che le indagini più serie attestano oltre il sessanta per cento della popolazione italiana dai quindici anni in su. Ma c’è una logica, in tanta follia. Chi, sapendo leggere, ha conservato qualche pazienza di memoria o più semplicemente la “flemma de studià”, si accorge che non siamo lontani dalle riflessioni del piccolo gigante sardo: la frattura in quel modo creata e crescente tra il popolo – mi si passi il termine ottocentesco – e i pochi studiosi, al punto che, come dice il Cuoco, hanno “diverse idee, diversi costumi e finanche due lingue diverse”. Ciò ha creato un doppio, drammatico danno. Il popolo è diventato plebe, o, come si dice oggi, gente, gl’intellettuali, perduta non dico la competenza, ma persino la speranza, il sospetto di una loro valenza politica, si sono acconciati al ruolo di esperti, anche raffinatissimi in altezze rarefatte.
Chi andasse a studiare il dibattito che ha presieduto negli anni Novanta (ne ho personalmente memoria per certe attività in quel tempo condotte) la trasformazione qui sommariamente indicata, vedrebbe la discussione improntata solo sulle dicotomie economico-sistemiche: pesantezza burocratica dell’istituzione / efficientamento e risparmi; accentramento ministeriale / decentramento e autonomia responsabilizzante, ecc. Niente sul che cosa insegnare e perché, sulla funzione emancipativa dello studio e dell’istruzione, ossia sui compiti della Repubblica nella ‘formazione dell’uomo e del cittadino’ come era stato detto nelle riforme dei primi anni Sessanta. Agl’inizi dell’attuale sviluppo ho sentito, più allibito che scandalizzato, irridere da certa filosofa di sinistra, davvero mancina, il concetto di pubblica istruzione, perché, diceva, è scuola di stato giacobina. Anche questa follia ha una logica. Di passaggio va notato che tale regola di condotta è stata scrupolosamente seguita anche per altre articolazioni dello stato sociale.
Se, com’è accaduto negli ultimi trent’anni, il capitale ha giudicato che il compromesso keynesiano era diventato troppo stretto e comunque non più inevitabile, se redistribuire la ricchezza non era più necessario perché la speculazione finanziaria diventava più fruttuosa, gettare nella fame gli ultimi, impoverire i penultimi e far regredire persino gl’intermedi diventava strada naturale. Per alcuni, come Jason W. Moore, la restaurazione neoliberista è frutto anche di una necessità più profonda: la costante pratica di rispondere alla caduta tendenziale del saggio di profitto con il ricorso allargato alla pratica delle enclosures, ovvero alla gratuita espropriazione progressiva delle ricchezze naturali sarebbe oggi incorsa in un limite fisico, spingendo il capitale a disinvestire dall’attività manifatturiera, per passare all’appropriazione delle ricchezze immateriali (il capitale delle piattaforme) e infine trasformarsi in capitale finanziario.
Perché allora lasciare che le istituzioni pubbliche sostengano scuola, sanità, pensioni e tutto ciò che si chiama stato sociale? Tanto più in un Paese come il nostro, le cui classi dominanti tradizionalmente hanno prosperato succhiando lo Stato e ponendosi al servizio del capitale internazionale. Perché, insomma, privarsi di un po’ di ricchezza per un’istruzione e una ricerca di qualità, se per un verso si tratta di speculare negl’interstizi del mercato internazionale e per l’altro, nel manifatturiero, di far concorrenza alla produzione del terzo mondo?
Ma i fatti hanno la testa dura, nessuna forza, per quanto grande, alla lunga può impunemente disconoscerli. Non è vero che la specie umana sia una somma d’individui più o meno liberi, esattamente come l’ecosistema terrestre non è una somma di elementi. Tant’è vero che nessuna persona d’intelletto onesto può oggi ignorare l’enorme trasformazione degli equilibri sul nostro pianeta, prodotta da poco più di due secoli di capitalismo industriale. Trasformazione immensa non per mettere in pericolo la natura – che, come c’insegna Leopardi, ha ben altre risorse del misero genere umano – ma la vita di alcune specie in essa, ivi compresa quella umana. Il dramma pandemico che ci sovrasta ne è solo l’ultimo, né il più catastrofico sintomo e simbolo; altri di natura diversa sono avvenuti e sono in corso, altri ne verranno.
L’espropriazione economica, l’appropriazione sotterranea dei pensieri, dei gusti, dei dati personali sono solo l’elemento visibile o più facilmente visibile di una più violenta espropriazione che Benjamin tra i primi già individuò palesandone l’orrore, dal momento che tutto ciò di cui gode di arte e di scienza colui che sa, lo deve “non soltanto alla fatica dei grandi geni che l’hanno creato, ma anche, in maggior o minor misura, all’anonima servitù dei loro contemporanei”. Più d’uno ci ha mostrato, con argomenti convincenti, che il sapere, come la ricchezza materiale, è prodotto sociale di misura di volta in volta determinata, per cui se qualcuno se ne appropria in grande quantità, può farlo solo sottraendolo agli altri. Se un numero minimo di élite può dedicare interamente le proprie energie fisiche e mentali ad appropriarsi di saperi ad altissima specializzazione per produrne di nuovi, moltissime altre donne e uomini consumano la loro vita a rendere possibili e confortevoli quegli ozi operosi, quegli strumenti sofisticati, quelle relazioni reciproche e con i comandi del mondo, quei modi di vita quotidiana davvero parallela, tutti intimamente necessari alla riuscita.
Solo di recente, per venire all’ambito nostrano, qualche voce isolata è tornata a posare lo sguardo sul disastro sociale e di lungo periodo provocato dalla distruzione da tempo in atto nella formazione e nella ricerca. Il politologo Ardeni, per esempio, le cui ricerche sui flussi elettorali mostrano nell’impoverimento la radice dell’adesione al populismo regressivo, si è spinto fino a osservare il legame stretto di entrambi con il doppio aspetto della descolarizzazione: l’abbandono scolastico e l’analfabetismo funzionale.
Non so dire se la vittoria del capitale nella lotta di classe è davvero piena come appare. Credo anzi che nessun attore possa sul serio dirlo, semplicemente perché l’esito non è scritto, ma determinato anche dalle scelte di chi guarda. Credo però di sapere quanto basta, per asserire che laddove la classe dominante si riduca, per conservare il potere, alla sola scelta del sovversivismo, in questo risultando vincente, tutta la civiltà che essa avrà nutrito e da cui sarà stata nutrita passerà rapidamente al declino, se non allo sfacelo. Questa allora diventa la domanda più urgente: quid noctis?
Nella vasta disamina di Gramsci della società nazionale, che partiva e faceva capo ai nodi del presente da cui il fascismo l’aveva precluso ma non sradicato, l’intellettuale indicava che solo un soggetto sociale – il proletariato - e politico – il partito comunista - terzo tra intellettuali cosmopoliti e popolo, tra contadini meridionali e classi dominanti poteva riprendere in mano le fila di una contraddizione irrisolta, arrestare l’imbarbarimento, riprendere la strada dell’emancipazione e della civiltà. Sarebbe rovinoso, prima ancora che sciocco pensare di riprendere oggi quei termini, ma è cruciale riprendere invece quel vitale paradigma problematico e politico. La domanda è rivolta a ciascuno di noi: custos, quid noctis? So, per esperienza, di tempi più opachi delle notti di novembre, quando la parola ferisce prima di tutto chi la impugna, ma sul tavolo la voce insiste, non tacere.
Vedo nella pandemia che ci sovrasta il segnale più perentorio degli ultimi trent’anni, perché la questione di vita o di morte la sottopone ora e a tutti contemporaneamente, costringendo intere civiltà a ripensare le cadenze minime del giorno – che cosa faccio la mattina quando mi alzo, chi incontro, che cos’è quello che chiamo tempo libero, qual è il suo legame con il mio lavoro, che rapporto ho con gli amici, i figli, i genitori, la persona con cui passo la vita – a riconsiderare il rapporto con le istituzioni – la scuola, il ruolo dello Stato nella difesa e nel sostegno al mio lavoro, alla mia libertà. È questo il momento dello spiazzamento, della rete che si smaglia. Non è un caso che le risposte più funeree, quelle che gridano ‘è tutto un inganno’, cioè quelle che si convincono che nulla è cambiato siano le più reazionarie, al comando o no degli Stati. Non mi nascondo la presenza di radicalismi, per lo più intellettuali, di sinistra: è appunto la radicalità cresciuta nel trentennio neoliberista, incapace di pensare libertà diversa da quella proprietaria. Personalmente sono impressionato dal ritorno massivo del pensiero magico nelle società secolarizzate da due secoli di capitalismo; parlo non dello spazio dell’esperienza religiosa, che ha tutt’altra necessità e ragione, ma delle molteplici forme di negazionismo, sia esso la sfericità della Terra o l’impiego del vaccino salva vita. Alla radice vi scorgo il misconoscimento dell’autorità mascherato da antiautoritarismo, ossia l’autoelogio dell’ignoranza che, non sapendo di esserlo, si ostenta come vanto. Tale disprezzo della conoscenza non è solo una conseguenza strumentale, ossia frutto della descolarizzazione, ma, più in profondità, della frattura vasta e crescente tra i pochi che sanno e la moltitudine, per questo il negazionismo è gemello, anche nell’ideologia esplicita, del populismo reazionario. Preciso meglio: è figlio non solamente della disparità di conoscenze e di potere, ma del modo di gestire quella disparità, ossia dell’incapacità egemonica delle élite culturali e politiche.
È vero, la notte è alta, ma l’ascolto si fa maggiore per altre voci. A tratti, affiorano.
Scritto sotto elezioni statunitensi
12 novembre 2020
Il pezzo che segue è stato pubblicato su Poliscritture di Ennio Abate, v.a., 29 giugno 2020
Buono l'argomento, difficile il posto dell'autore
su La disciplina dell'attenzione di Roberto Bugliani
Buono l’argomento della Disciplina dell’attenzione, difficile la posizione dell’autore. Come sappiamo l’argomento, in ispecie per la narrazione, non è elemento secondario per il valore dell’opera. Naturalmente l’argomento non è dato in assoluto, lo si misura nel suo contesto. E che cosa è più urgente, oggi, parlando degli uomini, della spaventosa spoliazione - crescente eppure nascosta, riversata nei nostri mari e terre eppure invisibile - del mondo che conta di cui portiamo bandiera ai danni della rimanente umanità? Invisibile, dicevo, ma non muta, tanto che anche nella nostra lingua hanno preso da tempo parola altri sguardi e linfe e colori che hanno finalmente attraversato i confini dell’orto letterario fecondandolo di nuovi semi, per chi vuol vedere. A questa urgenza, esplicitamente didattico, rinvia il titolo: l’attenzione è una necessità che richiede disciplina.
Ma, con questo, l’autore si è messo in una postazione ad alto rischio. Un principio elementare della quotidiana pratica ermeneutica, allo stesso tempo norma d’igiene mentale, è chiederci, di fronte a una qualunque comunicazione, ivi compresa quella del ciao mattutino: chi ci sta parlando? Chiunque si sia trovato alle prese con un testo scritto, tanto più se letterario, sa quanto maggiormente complicata sia quell’operazione, ugualmente costitutiva del senso di ciò che legge. Quando io mi chiedo “chi parla nella Disciplina dell’attenzione” non intendo riferirmi alla persona storica, in carne e ossa che risponde al nome di Roberto Bugliani, quella che in questo momento che leggo il romanzo già pensa ad altro e forse in altro modo, sebbene certo averne notizia aiuta, come già sapevano i copisti provenzali quando nei loro canzonieri accludevano le vidas ai commentari delle razos. Il ‘chi parla’ non è neppure esclusivamente costituito da chi nella narrazione dica “io” o “noi”, come nella stessa Disciplina si pretende, ordinariamente definita voce narrante. È invece, con immagine geometrica, un punto focale oltre il piano del testo, dove si raccolgono le linee di forza della voce narrante e dello sguardo sotto cui vengono rappresentati, in modo esplicito e soprattutto implicito, fatti, pensieri, azioni, personaggi, paesaggi, ambienti, flusso temporale, nonché le linee di forza tracciate dalle scelte rispetto ai generi, al registro linguistico, all’apparato retorico.
La difficoltà dell’autore della Disciplina dell’attenzione origina dall’essere egli parte di quel campo – per ricorrere al lessico di Bourdieu – che lo istituisce porta bandiera del mondo dei signori, per questo il suo alter ego nella narrazione è un “gringo”. Tuttavia ragioni storiche, oltre che ideologiche e morali, lo spingono a combattere quella sua parte, portando a nudo una scissura drammatica tra il signore e l’altro sé.
A lettura conclusa, osservo che l’orizzonte narrativo è saturato dallo sguardo del “gringo”. Un personaggio mal sicuro quanto si vuole, ma incapace di aprirsi, fosse solo per un attimo, all’altro sé in attesa oltre la fiamma della perdita, unico passo che potrebbe scamparlo dal cinismo. Condizione, questa, che impronta il traboccante sessismo dello sguardo sulla moltitudine qua e là definita e più frequentemente pulviscolare di figure femminili. Nella invariabile condizione di oggetto, in cui sono imprigionate per sempre, si concretizza tanto lo sprezzo cinico del signore quanto lo stato predatorio del dominio. La distanza umana dall’altro da sé vive anche nelle descrizioni degli ambienti, delle figure maschili, nelle condizioni fisiche e materiali che affollano le pagine, la cui dominante è la connotazione esotica, non essendo sufficienti a frangerla davvero alcuni inserti documentali presenti soprattutto nella conclusione del romanzo.
Contro tale spinta, la narrazione si affida, per aprire uno iato tra lettore e punto di vista narrante, a due contromosse, ove potremmo leggervi quella che in psicoanalisi si chiama resistenza: una linguistico-retorica, l’altra narratologica. La prima è imponente e di maggior rilievo: domina uno stile fortemente tipizzato, in cui le inflessioni sentimentali sono virilmente rifuggite. Il tratto è con efficacia condensato nello specchio della descrizione di un adolescente anonimo: “con l’aria da bulletto e l’andatura da bulletto a esorcizzare le sue paure” (p.55). Talvolta la spinta, per dir così, antimimetica sbocca in ampie sequenze di parossismo accumulativo portate fino al paroliberismo di certe avanguardie europee primonovecentesche.
La controprova della funzione difensiva della maniera virile assunta dal ductus narrativo ce la offrono le stesse pagine del romanzo allorché, in una vasta digressione del dodicesimo capitolo, esse si aprono alla rappresentazione della vicenda del mercenario ex militare della Germania dell’est. Qui il punto di vista narrativo, misurandosi con un proprio pari, riesce a sciogliere i veleni della critica con una libertà, con una secchezza nuove e convincenti.
L’altra contromossa con cui la macchina narrativa cerca di aprire lo iato della riflessione e del sospetto, con un gesto che vuole proclamare “guarda che il gringo e tutto quanto qui è narrato non sono il piano della verità”, è l’affaccio, fin nell’iniziale Avvertenza, di una voce che dice io e che si proclama “l’autore”. L’inserto metanarrativo torna a intervalli nel corpo del romanzo, a ostentare la propria distanza dall’altra voce narrante, anonima in terza persona. Ambiguamente funzionali a tale valenza distanziante sono anche l’impiego mimetico della grafica di iscrizioni-slogan su magliette o di nomi di locali, l’adozione occasionale di modalità da copione teatrale, gli ‘a parte’ di certi corsivi, nonché il ricorso inopinato a cinque note a piè di pagina. L’artificio contemporaneamente s’incarica, secondo una linea di discendenza illustre, di épater il proprio lettore: “la belloccia dai capelli color mogano che scendono vaporosi sulle spalle (l’hai subito adocchiata, eh? gattamorta d’un lettore!) mostra un attimo d’esitazione, rallenta un attimo”, ecc. (p.273): “tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, / - hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!”, ci ammoniscono in limine i baudelairiani Fleurs du mal.
Il ricordo che segue è apparso sul Manifesto del 27 maggio 2020, p. 14, v.a.,28 maggio 2020.
Piero Manni
La scomparsa di Piero Manni mi giunge, stordente, con la lettura del mattino, prima della mia videolezione. Spero che nel vuoto urlio delle nostre giornate, dove quello che più si distingue è l’insaziata protervia dei dominanti, qualcuno si dedichi a studiare l’opera straordinaria di cultura fatta nascere e crescere da Manni. Io intanto sento la dolorosa verità della sapienza antica che nessuno nasce e muore solo per se stesso: una parte di me, tra le migliori, da oggi è caduta.
Dalle periferie dove vivo, mi sono sentito rarissime volte, a lunghi intervalli, con Piero Manni, ma ho incessantemente costeggiato la sua attività di promotore culturale. Proprio in questi giorni ho tirato giù la collezione dell’ “Immaginazione”, diretta da Anna Grazia D’Oria, e guardato ammirato i trentasei anni della sua vita, che hanno solcato la letteratura italiana a partire da uno sguardo aperto, curioso e insieme militante che affonda le sue radici nella sinistra radicale degli anni della contestazione. Conobbi Piero insieme con Anna Grazia nel 1983, alle riunioni di redazione della rivista diretta da Luperini, “L’ombra d’Argo”, che allora si tenevano nel monolocale romano di Filippo Bettini. Proprio in quel torno di tempo dava vita alla sua casa editrice. Ricordo la serietà e, come ha sottolineato Tommaso Di Francesco, la gentilezza che connotava la nobiltà dei suoi modi e del suo animo. Quando, più tardi, ha dato vita con Anna Grazia all’ “Immaginazione”, nell’inziale formato in folio, con una grafica curatissima già nel titolo a specchio e poi nella scelta delle immagini, nell’impaginazione, ho saputo trovarvi, negli intervalli delle latenze affollate o smarrite dei miei giorni, una sponda fidata, una voce con cui vale confrontarsi. Più avanti, quando ho cercato nella Manni un editore prima al mio romanzo e poi al mio canzoniere, ho ritrovato in Piero un lettore sensibile, fraterno, attento, pronto a incoraggiarti. La casa editrice Manni, nel panorama devastato e mortificante dell’editoria italiana – elemento non secondario, questo, della distruzione della sinistra e persino di un tessuto civile, operato dalla vittoria del finanzcapitalismo mondiale - costituisce una postazione dal segno forte, per la scelta del catalogo, per la cura editoriale d’altri tempi, per la trasparenza dei suoi rapporti con l’autore. Grazie, Piero, di aver portato una luce necessaria al nostro giorno.
Il testo che pubblico qui di seguito è parte della mia collaborazione alla cattedra di Letteratura italiana e didattica della letteratura dell'Università di Roma tre. v.a., 22 maggio 2020
Velio Abati
Arsenio o del dramma borghese
Arsenio, compresa negli Ossi di seppia nell’edizione del 1928, narra in presa diretta la breve camminata pomeridiana del protagonista in un’anonima cittadina rivierasca, durante un temporale di un giorno ugualmente indeterminato tra fine luglio e pieno agosto, stante il riferimento di “Canicola”. La voce poetante si rivolge direttamente al protagonista, alter ego dell’autore, descrivendone i movimenti e incitandolo ad agire. I pochi tratti impiegati per descrivere la città e soprattutto il registro linguistico, la strutturazione ritmico-sintattica, nonché il mondo valoriale fatto proprio dalla voce poetante fanno della vicenda narrata un piccolo dramma borghese. Le cinque strofi costituiscono i cinque atti del dramma.
In Montale le misure classiche del verso, della rima, della strofe proprie della poesia italiana, così come certo patrimonio lessicale, sono rivissute in proprio quali forme naturali che segnano la nobiltà della poesia, per quanto l’autore possa sentirle minacciate e anche quando, nell’ultima produzione della vecchiaia, si trovi a ricorrere a forme più prosastiche. È appunto il sentimento di corrosione di quelle misure che porta l’autore a farle rivivere nella pagina in forme scheggiate, sporcate, mimetizzate come pietre, marmi emersi da un edificio in rovina. Mai, dunque, lo fa con ironia o in falsetto, ma esse sono sempre il segno, insieme nostalgico e metro esistenziale di giudizio di una dignità oramai compromessa.
La spinta all’ordine in Arsenio si verifica già nella distribuzione della materia e nella strutturazione metrica. La prima strofe costituisce la presentazione dell’ambiente e dei due personaggi non antagonisti del dramma: la città, il temporale e Arsenio. La seconda dà avvio al dramma con l’esortazione della voce poetante ad agire rivolta ad Arsenio. La terza, ovvero esattamente a metà del componimento, la vicenda si sospende per aprirsi a un intermezzo coloristico-descrittivo. Nella quarta riprende e si aggrava lo sviluppo del temporale, mentre il protagonista si avvia alla definitiva impotenza. Nella quinta, abbandonato il tono esortativo, la voce poetante torna a quello iniziale e descrive lo smarrirsi di un caos liquido e buio, dove si confondono Arsenio immobile, frammenti di città, cielo e mare. La cogenza della ricomposizione simmetrica emerge anche dal numero dei versi di ciascuna delle parti del dramma - 11, 12, 10, 12, 15 – nonché dalla predominanza endecasillabica, per quanto spesso esasperata dall’ipermetria sdrucciola e in un caso dal verso tronco. Ma forse essa risulta più chiara dalla funzione delle poche eccezioni: il settenario e i due quinari della prima strofe, in concomitanza con la partizione sintattica e argomentativa, sono in realtà funzionali a rievocare la divisione in fronte e coda della stanza di canzone[1], mentre il quinario seguito dal senario sdrucciolo[2] della quarta disposti a scaletta non solo mostrano il potenziale ricongiungimento endecasillabico, ma segnano la bipartizione della strofe in analogia con quanto accaduto nella simmetrica strofe seconda.
È da osservare che la caratteristica ora osservata è parte di un più ampio e costitutivo elemento della poesia montaliana: la finissima sensibilità musicale che non è giocata solo sul più ovvio piano ritmico, ma anche su quello apparentemente più distante della tessitura sonora. Montale usa le parole come se avessero una massa, un peso, un’evidenza oggettuale. Una qualità che cattura subito il lettore, ad apertura di pagina. Tale caratteristica dà alla poesia montaliana un rilievo tutto particolare alle molteplici figure dell’allitterazione, segnata dalla dominanza di consonantismi.
In Arsenio i fenomeni più rilevanti, sotto l’aspetto più specificamente ritmico, sono le straordinariamente numerose occorrenze di trisillabi, anche sdruccioli, e l’alta frequenza di endecasillabi con accenti di 2^, 6^ e 10^, specie se in concorrenza di tre trisillabi, che assumono un incalzante ritmo minaccioso. Nella tessitura timbrica, in coerenza con la materia e lo sviluppo narrativo, emergono diffuse polarizzazioni di vocali scure - /o/, /u/ - spesso sotto accento.
Nella prima strofe notevole è il rullo di tamburi del primo verso, con i suoi tre trisillabi, tutti sdruccioli, con accenti di 2^, 6^ e 10^ a segnare il motivo ritmico dominante nell’intero componimento. L’aria ottusa in cui la cittadina è catturata è resa sia dall’assenza paradossale di rumori sia dalla mancanza di viventi, eccetto il protagonista che compare a metà e i cavalli immobili. Quando in chiusura compare il “ritornello / di castagnette” si tratta di un suono stranito e di sogno. I “vetri luccicanti degli alberghi” e la presenza servile dei “cavalli incappucciati” sono i segni della dignità borghese della cittadina che attrae la preziosità linguistica dell’arcaico “piovorno” o dello spagnolismo “castagnette”.
Nella seconda strofe le esortazioni della voce narrante incalzano il protagonista, soprattutto nella seconda metà. La clausola “delirio […] d’immobilità”, con una formula la cui sentenziosità è sottolineata dalla misura tronca del verso, concentra lo scacco permanente in cui è preso l’io montaliano. Un sentimento di derealizzazione che dovrebbe essere sconfitto da un ruvido incontro con elementi naturali: il passo che scricchiola, l’inciampo nel viluppo delle alghe. Il timbro scuro qui si rifrange nel testo a partire dalla capziosità della giuntura “orizzonte che sovrasta / una tromba di piombo” (complemento oggetto + verbo + soggetto) e in particolare da “trOMba di piOMbo”. La densità sonora e semantica della strofe è segnata anche dal passo che segue: “salso nembo / vorticante, soffiato dal ribelle / elemento alle nubi”. Fortini nella perifrasi “ribelle elemento” legge mare[3], il manuale curato da Segre invece “vento”[4]. Per ragioni di stile e contesto complessivo mi sembra preferibile l’interpretazione fortiniana. La stessa scelta letteraria “salso nembo” contribuisce al tono alto e drammatico.
Nell’intermezzo della terza strofe, il temporale è distanziato in una dimensione generale, mentre il racconto si sospende, per fare spazio a descrizioni rasserenate di suoni e colori. Evidente l’allentamento della tensione nel piano semantico. Per esempio, la percezione muiscale passa dallo stralunato “castagnette” alla nobiltà di strumenti orchestrali: “violini”, “timpani”, senza considerare l’esplicitazione della provenienza, “tzigani”. Per non parlare della preziosità linguistica, che ricorre a ben tre nitide onomatopee – “rotola”, “fremer”, “rombo” - di cui una in ossimoro, “rombo silenzioso”, cui si aggiunge la risemantizzazione sonora e quindi onomatopeica di un aggettivo, normalmente pertinente al campo visivo, ad opera della giunzione in cui è impiegato – “getto tremulo”. A ciò si accompagna la preziosità calligrammatica dell’immagine, la dominanza del timbro chiaro, ecc. Non è un caso che in questa strofe affiorano marmi dannunziani da una medesima area dell’Alcione: “Ascolta tra i palmizi il getto tremulo” (nei Limoni: “Ascoltami, i poeti laureati”): “Ascolta. Piove”, ecc. nella Pioggia nel pineto; e anche “nel cielo azzurro e lunge par la sera / ch’è prossima”: “su l’alta scala che s’annera prossima / […] mentre la luna è prossima a le soglie” nella Sera fiesolana.
Alla ripresa del dramma nella quarta strofe il temporale si scioglie nella pioggia. Il buio è precipitato sul mezzogiorno, la sua notte annulla i confini tra mare e cielo, mentre della città si colgono solo incerti punti luminosi, naufraghi galleggianti sulla riva. Contemporaneamente al compiersi dello sconvolgimento delle ore, prende piede il fallimento delle esortazioni al protagonista con il palesarsi della sua immedicabile incapacità. È funzionale a questo l’impossibilità, nel nuovo contesto, di sciogliere nella parola “discendi” l’ambiguità tra il valore imperativo e quello indicativo. La drammatizzazione della ripresa è segnata dall’addensarsi della scura /o/ spesso sotto accento o dall’occorrenza di ben cinque versi sdruccioli nei quali spiccano i drammatici “precipita”, “sbattono”. In questo contesto, dove con mossa realistica la voce poetante descrive l’attimo di sospensione, quando il temporale pare fermarsi un attimo fino a che le prime gocce cadono e poi velocemente si rovesciano, suono e senso tornano per un attimo più leggeri: “finché goccia TREpidO / il cielo, fuma il suolo che t’abbevera”. Qui, dove si riprende l’incipit dell’intermezzo (“Ascolta tra i palmizi il getto TREmulO”) tornano scaglie di Alcione: nel nesso ‘campagna-atto-del-bere’ della giunzione “suolo che t’abbevera” rinveniamo quello della Sera fiesolana: “[la campagna] da lei beva la sperata pace”.
Nell’ultima strofe ogni possibilità di epifania per Arsenio si è chiusa, la stessa vicenda atmosferica non ha ulteriori sviluppi. Alla voce narrante non rimane che seguire il protagonista nel suo naufragio per le vie dell’anonima città invasa dall’acqua, nel caotico accumulo di frammenti visivi. Tuttavia il componimento non si chiude in un ritorno ciclico. L’inanità di Arsenio risulta ora immutabile, così la descrizione in clausola s’impenna in una potente, dimensione escatologica. Scomparsi i segni del vivente, s’installa terrifica e definitiva, in martellante rintocco di 2^, 6^, 10^, una “ghiacciata moltitudine di morti” nella quale lo stesso Arsenio è ‘fitto’. Altre presenze sono solo larvali, ancora in cadenza di 2^, 6^, 10^: “a un vuoto risonante di lamenti”. Ma l’attrito più drammatico si ha all’apparire di termini che più si avvicinano all’umano, fino ad allora censurati: “un gesto ti sfiora, una parola”, ma confinati nella pura ipotesi di una “vita strozzata”. Notevole, a segnalare il cambio di passo, è il raffronto con un’analoga situazione della seconda strofe: se lì l’attrito con il vegetale era esortato come possibilità d’accesso epifanico (“fa che […] / t’inciampi / il viluppo dell’alghe”, ora è sentito invece come segno d’impotenza: “giunco tu che le radici / con sé trascina”. In questo aspro e ampio scioglimento del dramma densissima è la tessitura sonora di quasi rime, consonanze, allitterazioni fuori accento, la durezza di consonantismi in vibrante-dentale /tr/. Ma preme piuttosto osservare l’affiorare, tra quelle scaglie, deformato in parte dall’ipermetria di due coppie di rime alternate: “pORTIco”, “sOLA”: “mORTI”, “parOLA”. È come se in tanta frantumazione della città e dell’esistenza, comparisse il resto luccicante d’una civiltà perduta: una quartina di qualche misterioso sonetto. Potente, si diceva, è il congedo, la cui immagine cosmica conclusiva è scandita dal rullo di tamburo di 2^, 6^, 10^ che ha aperto il componimento e segnato come un pedale l’intera partitura ritmica.
La forza, la fascinazione di Arsenio, in questo senso emblematica della pagina montaliana, è nel contrasto tra la povertà di frammenti oggettuali, di eventi, per non dire dei gesti della solitaria presenza umana da una parte e dall’altra l’energia che carica ogni nervatura lessicale, ogni movenza ritmica e sintattica, ogni ossatura sonora, verso un ordine di senso che di gran lunga trascende quella minimalità, perché sentito come severa necessità morale ed esistenziale. Se la voce di Montale si presenta sempre come una della “moltitudine” – “noi poveri” dice nel suo primo libro contrapponendosi ai “poeti laureati”; “Non sono un Leopardi […] vissi al cinque per cento” ripete in Per finire, nella penultima raccolta – in realtà la sua pagina sempre intrattiene legami intensi, condivide succhi vitali con la tradizione letteraria, in un movimento continuo di riprese, contraffazioni, allusioni, fatto efficacemente e autorevolmente messo presto in luce da un critico per temperamento e cultura così consentaneo come Contini, quando afferma: “il est clair que sa poésie naît au terme d’une véritable saturation culturelle” [è chiaro che la sua poesia nasce dopo una vera saturazione culturale][5] (p.64). Questo è il limine in cui e da cui nasce la pagina montaliana, fatto che gli permette d’intrattenere legami vivi con pagine dantesche, petrarchesche, leopardiane, pascoliane, dannunziane, fino ai suoi contemporanei, per non parlare della letteratura in lingua inglese da Shakespeare a Eliot o del grande simbolismo francese. Da questo nascono gli echi dannunziani avvertiti anche in Arsenio e forse da estendere a più ampie analogie strutturali con la Pioggia nel pineto, se si considera che la passeggiata del protagonista è sotto la pioggia di un temporale estivo in una località marittima e che il contatto cercato con il mondo vegetale alla fine si trasforma, come nel componimento dannunziano, in una sorta di metamorfosi dell’uomo nella natura: “giunco tu che le radici”.
Il legame intrattenuto dalla pagina montaliana con il vasto patrimonio letterario è condotto con un sentimento di dignità grande-borghese, senza al contempo perdere la consapevolezza della sua rovina. La ricca disponibilità di echi letterari della poesia montaliana è stata un’offerta assai appetitosa per molta della critica a lui coeva. Tale fatto, certo unito alla forza subito percepibile della sua parola, spiega il fenomeno osservato da Fortini: “per mezzo secolo, a cominciare dall’attenzione dei suoi coetanei (come Sergio Solmi), nessun’altra poesia dopo quella di Leopardi è stata sottoposta a tanta varietà e qualità di esegesi”[6]. Ed è sempre la natura grande-borghese da cui la voce montaliana muove, che spinge Fortini a parlare di “snobismo”[7]. Così comprendiamo meglio il senso politico e culturale del giudizio fortiniano: nessuna voce nel Novecento è stata dalla critica “tanto amata e interrogata come voce di maestro. Capitolo, questo, di una storia intellettuale dell’Italia contemporanea e anzi di una parte del suo ceto intellettuale, che potrà dare importanti esiti”[8]. È un giudizio che prende le distanze da un ceto intellettuale italiano incapace di guardare criticamente alla propria appartenenza elitaria alla classe dominante e che per questo sente in Montale il proprio cantore, magari anche malgrado la sua poesia. È inoltre un giudizio che rifiuta il primato della poesia – tenace motore della pagina montaliana -, primato che a quella collocazione sociale è consentaneo.
[1] Ci si riferisce alla forma metrica classica, di derivazione dalla canso provenzale, normalizzata da Dante e Petrarca, la cui stanza è divisa in due parti, chiamate appunto “fronte” e “coda” (anche “sirma” o “sirima”). La compongono endecasillabi e settenari, variamente alternati, ma l’impiego endecasillabico predomina in apertura di stanza, come appunto qui avviene con il primo dei due periodi sintattici – la ‘fronte’ – che consta di cinque endecasillabi.
[2] La convenzione metrica italiana prevede di definire la misura del verso contendo sempre una sillaba in più rispetto all’ultima tonica.
[3] Franco Fortini, Eugenio Montale, in I poeti del Novecento, a cura di Donatello Santarone, Roma, Donzelli, 2017, nota ai vv.13-14, p.156.
[4] Cesare Segre, Clelia Martignoni, Arsenio, in Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento, vol. 4 (Il Novecento), a cura di Gianfranco Lavezzi, Clelia Martignoni, Pietro Sarzana, Rossana Saccani, Milano, Edizioni scolastiche Mondadori, 1992, nota al v.14, p.727.
[5] Gianfranco Contini, Pour présenter Eugenio Montale, in Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Torino, Einaudi, 1974, p.64.
[6] Franco Fortini, cit., p.154.
[7] Ibidem, p.160.
[8] Ibidem, p.154.
La lettura che segue è apparsa, con titolo redazionale, sul "Manifesto", il 13 maggio 2020, p. 11; v.a., 14 maggio 2020
Velio Abati
Dagli strappi del giorno. Luisa Gastaldo
La poesia di Luisa Gastaldo scaturisce da una faglia occultata dal nostro tempo convulso, che al comando del principio di prestazione e del profitto travolge consuetudini, rapporti umani, ambiente quotidiano d’esistenza, scaraventando i perdenti e i morti stessi tra gli scarti colpevoli. Gastaldo, soffertamente ancorata al retroterra friulano, ricovero dell’orto didattico cui si dedica, leva la propria voce da dove il tempo e il mondo appaiono nella fissità della morte. Ma - ed è qui la vena nutritiva – non è mossa dal moto funerario, dalla nostalgia o dal piegarsi della pietas. Paesaggi e persone vengono fatti vivere o rivivere nella trama complessa dei tempi, che smuove l’immobilità da cui la parola prende avvio: “Sembrano tutti uguali / lo scorcio – il pino / marittimo di lato”, così l’incipit programmatico. Se guardiamo meglio quale sia la coscienza del presente che la rievocazione governa, vi scorgiamo uno sguardo energicamente femminile. Già nella precedente, intensa raccolta, Della tua voce, a ridosso della morte del compagno, il poeta Luciano Morandini, Gastaldo aveva avuto la forza di portarsi in una zona primigenia dell’esistenza, da dove far vivere, nella ferita immedicabile della perdita, il tremore fecondo e senza riserve della relazione, mostrando che il rapporto con l’altro, tra il presente e il passato, che il desiderio di relazioni autentiche sono questioni di vita o di morte.
Nell’attuale raccolta, lo stesso titolo, La linea del rattoppo, mentre espone il raccordo tra tempi, persone, paesaggi, vicende personali, esibisce anche, in modo persino prosastico, il rinvio alla sapienza tradizionalmente femminile e domestica del rammendo. Ampia è la presenza di figure femminili, dal ricordo del funerale di una bambina, alle poesie alla madre, fino ad aprirsi ai miti (Alcesti, Lilith) o alle artiste e poetesse dedicatarie dell’ultima sezione. Delicatissima, in bilico com’è tra il gioco infantile dei versi e il contrappeso angoscioso del titolo, la poesia A Daniela (1958-2013) “Regina reginella / quanti passi devo fare / per arrivare al tuo castello bello bello?”. La voce femminile vive poi in prima persona, ora nell’esperienza dell’amore, dove s’incontra un endecasillabo che evoca l’incanto di Saffo: “ora che sei qui e parli e mi sorridi”; ora in quella di figlia con il vecchio padre cieco, della bella Ogni giorno per diverse ragioni, dove amore taciuto, conflitti, bisogno reciproco d’affetto compongono un tessuto mosso e insieme rattenuto; ora in quella della figlia in colloquio con la madre: “nella nostra nudità disarmate / quell’ultima estate non più / madre e figlia ma amiche”; ora in quella di vedova, ironicamente alle prese con le incombenze faticose dell’eredità “Assediata da oggetti e documenti / (lo vedi amore mio quanti problemi?) / mi sono convertita in archivista”, poi piegando a uno sguardo domestico e intimo, ancora una volta amoroso, a segnare la permanenza vitale del passato: “Guardo le tue radiografie / le varici la scapola dolente / a lato delle cervicali l’ombra / del tuo profilo e il collo – che baciavo”.
In coerenza con il moto da cui nasce, il verso di Luisa Gastaldo si accorda al respiro interiore, procedendo per una strada di semplificazione, prima di tutto interpuntiva. L’assenza di punteggiatura, grammaticalizzata da altre stagioni poetiche, è la veste naturale di una lingua che si sente oralità sommessa, certo assecondata dal vocabolario non rilevato. La medesima brevità dei componimenti non evoca la funzione misterica dello spazio bianco, ma palesa la loro natura di accensioni, frammenti, di persone, di esperienze, di paesaggi, che la voce s’incarica di riconnettere nel loro legame e senso necessario. Un’esigenza d’ordine regola ogni testo, già visibile nella simmetria strofica. Anche il ritmo, pur ricorrendo a versi brevi, è largamente segnato dalla misura dell’endecasillabo. Anzi, come Rodolfo Zucco ha mostrato in un sondaggio condotto in occasione di una lettura della poetessa ai Colloqui del Tonale, accade che l’endecasillabo, in controcanto, nutra una latenza sorretta dalle partiture rimiche o sintattiche, anche là dove la disposizione grafica esplicita lo nega.
Il breve pezzo che segue è stato pubblicato sul "Manifesto", il 7 maggio, 2020, p.3; v.a., 9 maggio 2020
Velio Abati e Maria Pia Betti
Tecnocrazia o democrazia
Punto 1. Come e più di ogni altra scelta, quella politica per un’intera comunità deve compiersi a partire dalla conoscenza della realtà. Le decisioni generali che il Governo e il Parlamento devono prendere, riguardanti il comportamento sociale (essenzialmente il distanziamento), ha bisogno della conoscenza scientifica della natura, della trasmissibilità e della vita di un virus nuovo, che solo un gruppo di alti specialisti e di più discipline può avere.
Punto 2. Il gruppo Colao è già di natura diversa, perché ha lavorato su tematiche (relazioni delle catene produttive interne e internazionali, orari delle città, rapporti tra finanza e attività produttive, ecc.) che un politico già dovrebbe conoscere, o comunque un’organizzazione politica dovrebbe avere al proprio interno. Dovrebbe, perché altre formazioni politiche, altri uomini politici hanno ovviamente avuto: te li immagini i Costituenti che assoldano tecnici? O le forze di governo del Centro sinistra degli anni Sessanta che ricorrono a esperti che non fossero già anche uomini e donne politiche? Questo slittamento è avvenuto non perché oggi le cose siano, diciamo, più complicate, ma perché i politici – e le forze che li organizzano – sono esperti solo in comunicazione e, quando va bene, gestione dei rapporti di potere.
Punto 3. La scelta di un comitato scientifico nel settore specifico dell’istruzione è ancor meno comprensibile di quello di Colao, perché esso ha di fronte un campo decisamente più ristretto e omogeneo. Alla fine deve solo decidere come organizzarlo entro le coordinate indicate dai due precedenti comitati tecnici. Qui, vogliamo dire, le conoscenze davvero richieste concernono i diritti dei bambini e dei ragazzi, i diritti dei lavoratori, i bisogni delle famiglie, l’organizzazione della struttura burocratica intermedia, gli spazi fisici, i mezzi informatici, la formazione del personale. Tutte decisioni che hanno a che vedere con l’organizzazione sociale e sindacale. Se una persona di governo non sa fare questo che cosa sa? E per governarlo deve naturalmente confrontarsi con scelte politiche – che dovrebbero derivarle dalla sua parte e organizzazione -, con scelte sindacali e con scelte amministrative. Ma se uno, come dimostra la ministra Azzolina, ha idea che tutti i corpi intermedi (sindacati, forze politiche, associazioni) sono da rifiutare, che le strutture esistenti (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, dirigenti ministeriali, ecc.) sono antagoniste, non le resta che concepire il governo non come attività politica, ma esclusivamente tecnocratica. Tra il governo di uno Stato e il governo di un’impresa non c’è differenza. Anche per questo il governo diventa comando.
Ricevo dall'amica Daniela questa seconda nota di lettura su Marusca che molto volentieri pubblico di seguito, v.a., 7 aprile 2020
Daniela Marretti
Posso, dal lettrice, testimoniare la bellezza e la forza. Posso dire dell'acre sentore di zolfo - a volte di legno, di sudore, di foglie, di fatica, di vita vera e bracciante -, che sai insufflare nel denso 'capitale' della tua cultura, nella complessa architettura intellettuale delle tue opere. C'è, nella tua narrativa, l'odore della macchia mediterranea, la struttura nodosa dei suoi arbusti, un odore e una fatica e un valore, che so venire dal basso, e che infaticabilmente emerge tra le volute di costruzioni complesse, spiazzanti e sapienti. Una tensione proficua e vera, una dialettica feconda tra il basso e l'alto, il prima e il dopo, la terra e il cielo, le mani e il cervello, la zappa e la penna.
Mavì De Filippis mi gratifica della nota di lettura, a proposito di Marusca, che volentieri pubblico di seguito, v.a., 27 marzo 2020
Mavì De Filippis
Non ho parole, ne sono rimasta priva. Appena finita la lettura sono avvolta da un silenzio inusuale. Come se tu avessi raccontato un sogno in cui tempo e spazio non sono più necessari. Ieri e oggi si rimescolano. I fatti e la letteratura son lì affiancati. Il senso della letteratura è modificato dall’oggi.
Il giudizio sul presente è dato, quasi impercettibile da due parole: “bollettini in camice bianco e oscene figure, stentorei eminenti del mondo” .
Grazie veramente non solo con tutto il cuore ma anche con la mente. Certo hai sempre più il dono della parola. Parole ricche, capaci di comunicare, di avvicinare chi scrive e chi legge. È scritto oggi ma ha già la forza di un classico.
Marusca
Non so nulla. Intendo non solo ieri. Seguivamo le insofferenze di mio padre, questo sì, generose. Ci aveva avvertito, ma quando, svoltata l’imbrecciata polverosa che scendeva dentro cerri e marruche, affacciammo alle Zolfiere, ci fu chiaro che non avevamo compreso. Una volpe, ci disse poi quella famiglia, o forse un tasso fu trovato morto nel breve sprofondo del campo, che in autunno diventava troscia e polvere pungente agli occhi d’estate. Ci volle del tempo, prima che il puzzo di carogna sovrastasse quello di zolfo: ci andarono cauti, faticarono in due o tre con le pertiche lunghe, per tirarlo fuori e finalmente interrarlo.
Andavamo tutt’e quattro la mattina presto, per ripulire le due stanzette messeci a disposizione dalla famiglia. Marusca capitava all’improvviso, indaffarata dietro le donne di casa, gli occhi neri che fissavano dritti, poi fuggivano via ridenti. Sgobbammo tutta la settimana per svuotare la stanza dai pollai, dal pagliericcio, per raschiare e lavare i mattoni dell’impiantito, i muri. Mamma ci legava un fazzoletto alla bocca per via dello spolverio della merda. La famiglia delle Zolfiere aveva spostato le galline in una baracca dietro casa, addossata al tronco della quercia.
Finito questo lavoro, babbo si portò dietro mezzo sacchetto di calce viva, che sparse a manciate sui mattoni, sui muri, sui davanzali come lo zucchero a velo sul pandispagna di mamma a Natale, perché era comunque necessario disinfettare. Marusca si divertiva nel vedere tutto quel lavorio. La guardavo, sorpreso, quando potevo. Fino ad allora per me Marusca aveva significato la testa ricciolina con gli occhi celesti che anni addietro, per un’intera estate forse, nei tanti nostri pellegrinaggi, aveva accompagnato i giochi sbandati fino a buio.
Ora, sul tavolo, il peso dei fogli scomposti. Appena questa mattina, scrivevo di rileggere a capofitto nei ritagli strappati al pane quotidiano, alla giusta decenza, nei giorni affannosi e strani di fine inverno. Ma è solo la brevità della luce, annotavo, a segnare il conforto di ciò che è familiare. Come sempre, proseguivo, il richiamo perentorio delle scadenze consuma le ore di luce, troppo intensa, però, troppo tiepida. Ma ora, improvviso come il soprassalto della notte invernale, il tempo s’è squarciato: la luce e il buio sono sull’orlo del tempo.
Ritrovavo, ritrovo il giovanile piacere del corpo a corpo con il fine della parola critica, che più di altra si figura il profilo, almeno apparente, a cui parlare. Proprio per questo, perché indissolubilmente dialogica, essa non può, non dico vivere, ma neppure nascere in assenza di una cerimonialità pratica, di una relazionalità istituzionale che letteralmente istituiscono la possibilità di parlare e quella di ascoltare. Non è un atto di volontà.
La pagina su cui m’affatico, che pure in prima mossa si sottrae e si eclissa in una testura irta, anch’essa in dissimulata esibizione di altre voci e stagioni, ha un’energia vigorosa. «Le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall’azzurro». In ogni parola trovi il godimento della cosa, urti il suo spessore ruvido, senti il suo peso. Vive, nell’attimo eterno della scrittura, nella finzione più che reale del suo atto, la pienezza dell’adesione al mondo, che subito ti accende l’acume della sua mancanza. Basta accompagnare una cadenza, per sentirne il valore, ben prima di comprenderla. È proprio quella promessa, anzi caparra che chiede la fatica dell’ascolto, sempre.
Marusca mi sorprese subito. Non aveva la voce squillante della nostra giovane età, possedeva estensioni misteriose. Si muoveva in risonanze ora profonde e quasi solenni, ora intime e assorte, ora s’impennava in brevi squilli giocosi, ora si abbassava in lente movenze, profumate come le castagne. Erano giorni, mesi penosi. La giornata principiava parecchio prima dell’alba, quando babbo alla porta sussurrava leggero il mio nome. Appena intravedevo Marusca, dietro le sue faccende di casa e dei campi. Fatica, la mia, non solo fisica. Irruzioni di quiete, anzi di euforia sconosciuta erano le parole balbettate in una lingua antichissima, a stento compitata: άνθει καί σκόλυμος. νϋν δέ γύναικες μιαρώταται, e fiorisce il cardo; ora, le più lussuriose le donne.
Una corsa cieca, la mia, una fuga all’ignoto dove ogni voce era paradiso e inferno. La notte brevissima e gelida delle stanzette delle Zolfiere, tra i rami nudi dei cerri e delle querce, si fece turbolenta. I colpi di tosse secchi e violenti senza tregua scuotevano il sonno, tanto che una notte Marusca arrivò con un bicchiere d’acqua, a sorreggermi la fronte.
I libri, ora, sono sul tavolo. Di lato, di fronte alla finestra due o tre piante di terre lontane vi fioriscono, vigorose per le mie cure. Tutto appare conosciuto, ma nulla lo è. Il sole troppo tiepido ne è indizio. Non so più da quanto la porta rimane chiusa: il tempo della lettura è altro, la fatica sembra allentata.
I libri sono suolo fertile, gli organismi vi stratificano, nei decenni, nei millenni. Chi legge incontra, diceva un mio maestro con qualche enfasi, i chiodi di chi in precedenza ha scalato quella pagina. Ho detto “libri” con automatismo di casta, ma è l’opera dell’uomo, perché è lui che sempre vive in relazione e sempre la trasforma.
I giorni si fecero più leggeri. Piegarono, senza che me n’avvedessi, verso altro, indefinito, mentre alle spalle tutto, per strappi, ritorni, gradazioni si negava, si dimenticava, s’affievoliva. Quando, nella stagione calda, partivo presto con babbo dalle stanzette delle Zolfatare per rientrare la sera, prima che l’umidità dei lunghi crepuscoli saldasse di nuovo il legno secco delle pigne assestate bene nei larghi riquadri del campo di trebbia, non sempre riuscivo a incrociare Marusca mentre governava le galline. Sentivo il suo gorgheggio dentro il pollaio addossato alla quercia. Se potevo, mi attardavo intorno al podere, sudato, ancora nero in faccia e nei panni della polvere densa dei pinoli. Dopo essermi lavato e cambiato, prima di cena, potevo di nuovo uscire nell’aia a respirare la brezza e il primo saluto dei grilli. Una sera, quando l’ultimo chiarore del cielo anneriva oramai le frasche e l’erba, sentii, oltre il trillo già fitto dei grilli, un parlottio lieve, mosso da brevi sussulti d’allegria e quasi eccitazione.
Una parte, credo, del godimento nella lettura degli Ossi derivava anche da quel tanto di familiare che mi sembrava di scoprirvi. Arrovellavo con furia il mio giorno sulla scrittura ispida, acuminata, erudita di uno dei più autorevoli critici del poeta e del proprio tempo. Scolaro paziente, comprendevo, annotavo, imparavo con ardore.
Nessun’ombra si muove nelle strade da tempo vuote del profumo di mimosa, ogni volta più precoce. Dalle porte chiuse, solo il ronzio di nere file di bare, bollettini in camice bianco e oscene figure, stentorei eminenti del mondo. Ai crematòri, i cartelli annunciano aperture di ventiquattr’ore insieme con i moduli di prenotazione. Notte tempo, silenziosi camion militari sfilano verso cimiteri sconosciuti. Gelidi alcuni grafici disegnano salite parallele di smog e infezioni virali. Scomparsi persino dagli schermi, ammassati in discariche carcerarie o abbandonati nel fango, dispersi negli orizzonti sabbiosi, senza eco muoiono scarti umani.
Con altra fretta, ora, ad altre attese, spalanco la finestra alla luce già calda e mi siedo al tavolo. Il secolo che ho vissuto è finito questa mattina, nasce oggi il nuovo millennio. Riprendo il libro che attendeva, riapro la pagina su cui in altri tempi m’affaticai. «Certo diverge come più non si potrebbe dagli uffici stralcio di quel classicismo romantico in cui si accese, con gli uomini e i vicini della ‘Ronda’, la luce più splendida della letteratura di ieri. Una realtà quotidiana e assurda, che cola irrazionale e ininterpretabile senza possibilità di tagli e inquadrature necessarie, come fusa in ghisa: questa è l’essenza dell’atteggiamento che volentieri chiamerei realismo esistenziale; e che, anch’esso attuato scrupolosamente da alcuni narratori (allora quasi esclusivamente toscani) sùbito prima della seconda guerra mondiale ha poi trovato un buon collaudo della sua probità flaubertiana e courbettiana nell’applicazione a temi ‘civili’». No, non è il lasciarsi sommergere dalla parola ascoltata, esperienza vivida. Altro è ora insopportabile. Per la prima volta scopro nella torsione antiborghese, dal critico impressa alla sua sapiente consonanza coltivata da vaste letture, un insoffribile compiacimento. La notazione ricca, a indicare la caducità, la fallacia, il senso di morte della grande cultura letteraria, è, vedo ora, inscindibile da un’intima e altrettanto energica condivisione. La cura di dissimulare l’acribia nella concettualizzazione di scienze più diverse, aprendo in questo modo indiretto alla connotazione metaforica l’iniziale natura ‘positiva’ del lessico specialistico, gli avari rimandi tecnici, poco più che cenno a chi già sa, segnano la pagina di una sgradevole postura snobistica. La cecità più importante del mio fervore d’allora è stata aver scambiato quella funzione allusiva, convinta pratica del primato della letterarietà, con il valore propriamente conoscitivo del rinvio alla totalità dell’agire e della vita umana. È questo un movimento per natura asintotico, una tensione, più che una meta. La sua unità non è nella letteratura, che ne è invece solo parte, da cui il ricorso inevitabilmente ellittico, che però, lungi dalla goduta ostentazione, si sforza sempre di piegare il piacere letterario alla funzione d’inciampo al già saputo, di esercizio, insieme con il proprio lettore, alle slogature necessarie a far irrompere l’imprevisto, la realtà nascosta sotto la compattezza dell’ovvio, del buon senso. Il fraintendimento di allora mi aveva celato la funzione fondativa del compiacimento letterario, tanto evidente nella passione rabdomantica con cui il critico insegue la densità degli echi prossimi e distanti: un narcisismo che si riconosce nella pagina letta, a sua volta da questo rinchiusa.
Il sole scalda i muri e l’aria, dove è inghiottita ogni voce. Quando, a intervalli, il vento tace, dalle finestre vuote filtra la cantilena dei proclami. I militari, si annuncia dagli schermi, scendono nelle strade: ognuno rimanga nella propria casa. La retorica nazionale, leggo da una mano amica, dà la caccia ai piccoli untori, i grandi Untori del malmodello di sviluppo continuano ad inquinare e a mettere le loro grinfie insanguinate anche sulla morte.
Ma noi non siamo innocenti. Guardo sorpreso e smarrito come così tanti, spesso i più esposti, corrano senza avvedersi al pericolo proprio e altrui. Intere generazioni, condotte da una educazione al narcisismo all’acquiescenza del farsi i fatti propri piegando capo e gambe, scoprono di colpo e collettivamente messa in dubbio la superba libertà dell’individuo e del genere umano. Molti semplicemente non riescono a comprendere che nessuno vive e muore solo per se stesso e che la misconosciuta distruzione di aria e acqua non è senza conseguenze, per cui corrono spensierati al danno e alla morte. Altri, annichiliti dall’improvviso rivelarsi della fragilità comune, la negano in radice, come se nulla fosse accaduto. Il nuovo millennio muove da questa dura replica. Niente lascia come prima.
Il fidanzato di Marusca era di una bellezza mortificante. Solo la pelle, forse, era troppo rossa. Un nido folto di riccioli biondissimi segnava l’ovale fermo del volto dagli occhi azzurri e labbra carnose. Era già un giovane di vent’anni, gli arrivavo a fatica alla spalla. Veniva regolarmente la sera, finita la giornata di idraulico al paese, quando lasciammo per sempre il sentore acre delle Zolfiere, che ci portavamo addosso anche quando ci si lasciava alle spalle la strada imbrecciata. Da allora, ho imparato a ritrovarlo nelle vigne assolate di giugno.
L’infermità del marito di Marusca, aggravatasi rapidamente, era stata lunga. Lei e la figlia dovevano assisterlo come un bambino. Solo loro capivano le parole mute della fronte o della mano.
Il camion del latte arriva presto, la mattina, per la strada non più imbrecciata tra le querce e i cerri. Marusca ha appena finito di mungere, intanto che la figlia prepara per tutt’e due la colazione.
25 marzo 2020
Lo scritto che segue è apparso anche sulla rivista on line
Virtù
La pandemia in corso certifica in modo sbrigativo che oggi il genere umano è uno. L’allarme ecologico ne è solo l’altra faccia, quella che esplicitamente collega la storia del genere umano al complesso naturale. Entrambi sono, prima di tutto, interdipendenti: il numero di uomini e la loro relazione produttiva (al singolare, “relazione”, perché, fatte salve le ovvie differenze storiche e regionali, unico è il segno) sono all’origine di questa e di altre possibili future pandemie. Il tema del venire a termine di un certo modello di sviluppo, quello capitalistico attuale, è oramai sul tavolo; che l’uscita sia regressiva o progressiva è la questione.
Che il genere umano sia unificato e che gli effetti del suo modo di riprodursi abbiano immediata ripercussione (attualmente distruttiva) sull’ecosistema terra non necessariamente spingono per una regressione al locale, al nazionalismo, alla separazione; né, dal mio punto di vista, sono esecrabili. Mettono anzi in evidenza la curvatura oscurantista e autoritaria di certe parole d’ordine che sono state della sinistra anni Settanta, come l’equiparazione immediata tra autonomia e democrazia. L’autonomia scolastica inaugurata da Luigi Berlinguer è l’incubazione dell’attuale concorrenza liberista tra istituti e della distruzione educativa, così come la regionalizzazione dei sistemi sanitari è stata la chiave di volta dell’impoverimento delle strutture pubbliche a vantaggio della sanità privata. Detto in breve, il nazionalismo autoritario e fascistoide di Salvini non è in contraddizione con il separatismo bossiano, ne è l’inveramento.
Si può affrontare lo stesso grumo da un approccio volgarmente pragmatico: problemi globali richiedono risposte globali. Che la questione di chi sia il soggetto di tale risposta globale sia da discutere è questione del tutto diversa dal sostenere che essa debba essere rifiutata in radice ricorrendo alla parola d’ordine d’altri tempi “piccolo è bello e democratico”.
Non so se ha ragione chi sostiene che l’esperienza in cui siamo costretti avrà esiti negativi sull’educazione sentimentale degli individui. Intendo il fatto che l’unica risposta contro l’attuale emergenza, positiva sul piano fattuale e moralmente augurabile, sia la separazione fisica sociale. Credo, come sempre, che rispetto a un dato di fatto, non ci sia mai una sola risposta deterministica, ma dipenda dalla capacità di risposta, ossia dai conflitti sociali intorno ad essa: l’uno, diceva Mao, si divide sempre in due. So comunque che l’appello alla responsabilità individuale – mai come in questa occasione, in mancanza di delega alla cura medica, unica risposta sensata e possibile - è o può essere una potente occasione di educazione di massa alla consapevolezza che nessuno, sottolineo nessuno, vive e muore solo per se stesso. Un’educazione tanto più importante nella forma di vita da almeno trent’anni dominante in Italia e nel capitalismo occidentale, nella quale la libertà individuale sperata, propagandata e praticata è quella del profitto privato, che ha reso e rende giusta e buona la morte dell’altro, della concorrenza levatrice della democrazia, come se il suo mezzo non fosse la soppressione del perdente e la sua meta non fosse il monopolio.
Persone come me capiscono benissimo che il pericolo di questa regolamentazione e limitazione dei comportamenti personali possa essere esercizio al panopticon orwelliano. Ma, ripeto, sia si deve sempre partire dai fatti che, diceva un pensatore dimenticato “hanno la testa dura”, sia la risposta possibile non è mai univoca. D’altra parte, e simmetricamente, leggo con vero fastidio gli esibizionismi pseudo-radicali di certi opinionisti che, giudicando “manipolatorio” l’appello dei responsabili di governo all’autocontrollo, di fatto auspicano e in alcuni casi reclamano l’intervento della polizia e dell’esercito.
Forse, l’attuale crisi sanitaria e climatica segna davvero il salto di paradigma tra il Novecento e il nuovo millennio. Che la formazione politica oggi necessaria non possa essere quella terzointernazionalita e che la teoria non possa essere quella bolscevica non cancella la necessità di forme politiche capaci di una visione complessiva alternativa e di una corrispondente capacità di agire in modo coordinato all’altezza del disordine mondiale organizzato del capitale.
19 marzo 2020
Il testo è comparso sul n.9, gennaio 2013, di Poliscritture di Ennio Abate e ora leggibile anche nel suo sito
La cartella di Fortini
Quand’ebbe detto ciò, con li occhi torti
riprese ’l teschio misero co’ denti,
che furo all’osso, come d’un can, forti.
Il realismo furente di Dante ha incrinato per qualche terzina il silenzio glaciale della palude. L’orrore indicibile si squaderna ora in un esserci eterno. Il passato non muore e ha annientato di colpo il futuro. Tutto l’universo infernale è infatti un viaggio alle radici della selva dove ’l sol tace, al fermentare d’un passato che divora chi vive. La terzina conclusiva incardina l’incubo nella posa definitivamente animalesca della vittima-carnefice, “occhi torti”, e nella fissità d’una coazione senza fine: “riprese ’l teschio”.
Il lettore sa che l’emersione del rimosso, il vis à vis con il suo carico paralizzante d’angoscia è la costanza di ogni scena espiativa, offerta al pellegrino sotto la mediazione vigile del maestro. Così come pervasivo è l’assillo politico che l’accompagna e che l’artificio del viaggio, collocato alla vigilia della catastrofe umana - cioè politica, etica, estetica, filosofica ed esistenziale – dell’esilio, rende incombente, ad ogni passo ravvivata da profezie ora stizzose, ora neutre, ora intenzionalmente consolatorie.
Ogni dannato ha la propria fissità e ognuno diversamente rifrange la biografia del pellegrino. Mille sono i modi con cui ciascuno, per dirla con Pirandello, rimane agganciato al proprio assillo.
Quando s’accorse d’alcuna dimora
ch’io facea dinanzi alla risposta,
supin ricadde e più non parve fora.
Ma quell’altro magnanimo a cui posta
restato m’era, non mutò aspetto,
né mosse collo, né piegò sua costa.
Può, tra le mille, assumere la postura nobile quanto marmorea dell’assillo pubblico, oppure il patetismo trepido e cieco della passione familiare. Ma ciò che inficia alla radice e quindi scaraventa nella discarica infernale energie e sforzi vitali della miriade di dannati è stata l’incapacità di ciascuno di trascendere l’immediato, di allungare lo sguardo verso il futuro: dilettoso monte, da cui solo si può decifrare il passato e vedere il presente.
Fortini conosceva bene questo punto della nostra umana condizione, quando ripeteva: ogni immediatezza, ossia ogni rifiuto della mediazione, è intimamente reazionaria.
Credevo che la mia generazione, esclusi i cinismi e i rampolli dominanti, avesse scoperto per tempo –ai primi anni Ottanta, ricordo – la lezione eroica del prigioniero comunista Antonio Gramsci. Ma non ho mai immaginato che avrei dovuto insegnare la speranza ai miei alunni, che il mio compito sarebbe stato formare alla speranza. Fortini, a un giovane che nel 1993 lo interrogava su che cosa debba fare, come debba vivere la propria quotidianità chi s’affaccia alla vita adulta, rispondeva: “io domando ai giovani con cui lavoro, se vivono con i soldi di papà, se vivono con i propri, quanto guadagnano”. La risposta presuppone una condizione oggi lunare, vivendo i giovani la corrosione, di giorno in giorno maggiore, delle possibilità di lavoro, di sostentamento, di relazione. Nella selva non c’è luce, i sentieri sono false piste.
Gli alberi sembrano identici,
la specie pare fedele.
E sono invece portati via
molto lontano. Nemmeno un grido,
nemmeno un sibilo ne arriva.
Non è il caso di disperarsene,
figlia mia, ma di saperlo
mentre insieme guardiamo gli alberi.
È in tale immobilità che germina la disperazione. Non c’è, in se stessi, nell’hic et nunc circostanziale possibilità di lume. Questo è l’acheronte per chi si trovi oggi ad apprendere e a insegnare. Perché la speranza, se è una necessità primaria, non vive senza alimento. Il sapere di cui Fortini parla alla figlia, nelle circostanze date, viene solo da fuori; meglio: dai tempi lunghi.
Da questa béance, prima di tutto esistenziale, in cui insegnante e alunni sono presi, proprio da questa assenza d’ossigeno che grava nell’aula e nelle case, trova vita e scopo la potente lingua dantesca. Il piacere del testo è per il lettore la messa in esperienza dell’uscita da sé, quella che il pellegrino compie con lui. Il lettore, alunno-docente, passo dopo passo, impara a riconoscere con Dante che il male, con la paura che esso genera, non è assoluto, ma ha un’origine e ha una fine.
Ho detto esperienza, perché di essa vive la fatica del concetto, non della spiegazione astratta. Fortini aveva un amore sconfinato per il conversare, come sa chiunque l’abbia incontrato. Le sue lezioni pomeridiane a Lettere in via Fieravecchia si protraevano indefinitivamente. Arrivava con la cartella, elegante, sorridente, bello nella sua capigliatura candida e iniziava la lezione. Ho imparato dalla sua lettura perché un poeta va a capo prima della fine del rigo.
Non c’era un termine formale alla sua lezione, a un certo punto si trasformava in altro. Via via gli studenti si alzavano dalle sedie fino a che rimanevamo i soliti quattro o cinque. Oramai parlava del mondo. Solo quando l’anziano custode – si chiamava Dante, mi ricordava la figura d’un carraio della mia infanzia - suonava la sirena, egli si decideva ad alzarsi, prima che le luci spente ci chiudessero dentro. Nella mesta spensieratezza del Settantasette si leggeva nei muri di Via Fieravecchia una scritta; girava voce che ne fosse autore Gianni Scalia: Franco Fortini, il Lattes a lunga conversazione. Una volta – eravamo già al secondo anno – ci confidò perché non faceva precedere nessuna introduzione al suo corso. Solo la strada percorsa fino alla fine avrebbe potuto spiegare gl’inizi.
“Essere figlio” scrive l’Istat “di un avvocato (cioè avere un’origine borghese) oppure di un operaio non è affatto la stessa cosa: le probabilità di diventare un libero professionista, imprenditore o dirigente – ossia di accedere alle posizioni di vertice della gerarchia sociale – nel primo caso sono relativamente alte, mentre nel secondo sono decisamente più contenute. I figli della borghesia sono in netto vantaggio sui figli degli operai dell’industria e dei servizi anche nelle competizioni per l’accesso alla classe media impiegatizia. Ciò significa che le diseguaglianze di classe continuano a trasmettersi di padre in figlio”. Credo che pochi ragazzi conoscano questi dati che li riguardano. Anche Lettera a una professoressa suona inoffensiva come una carta medioevale; troppo grande è il velo sia dell’ideologia dominante, sia delle apparenze arcaiche di cui quel testo si veste. Credo anche che generalmente sfugga loro, per quanto rapido e imponente sia il fenomeno, il degrado dell’istruzione pubblica, cioè l’aggressione alla forza emancipativa della scolarizzazione di massa dei trenta gloriosi, breve tempo di cui ha beneficiato la mia generazione. Non lo sanno, perché il passaggio dalla condizione di fatto alla sua consapevolezza ha bisogno del rischiaramento della coscienza.
Non sfugge però loro una verità della propria condizione, ovvero la sostanziale impotenza dell’istruzione a modificare il destino già iscritto nella carne della loro famiglia. Solo che ne rimangono atterriti, proprio in conseguenza della loro cecità circa le cause e la natura storica, ossia mediata, di quel destino. Quando domando per quale motivo andare a scuola, mi si risponde “per socializzare”. Per socializzare è di sicuro la constatazione di un’azione positiva esistente. Per socializzare è però anche la verbalizzazione d’un bisogno autenticamente vissuto. È il grido di uno spavento, d’un vuoto: se parli è meno buio, invoca un certo paziente di Freud.
Sono partito militare il primo aprile del ’78, pochi giorni dopo il rapimento di Moro compiuto dalle Brigate Rosse. Ero laureato da qualche mese. Fortini, seppi poi, era corso via dall’Italia, per cercar scampo dall’oppressione. Dalla rabbia, immagino, e dall’impotenza insopportabili. I trenta gloriosi si chiudevano nella tragedia farsesca, nell’imbecillità.
Quando sono tornato dal congedo, ho seguito altre strade, da lontano. Ho incontrato Fortini a intervalli radi. Ogni volta, ricordo, con festoso slancio paterno, a Milano, a Montemarcello, al mio podere. La presenza del suo insegnamento è maturata lentamente, quasi inavvertita. So che se qui davanti avessi i miei primi alunni e quelli attuali farebbero fatica a riconoscere la stessa persona.
[…] Celeste è questa
corrispondenza d’amorosi sensi
Con altro orecchio leggo oggi, scartando la magniloquenza che da noi puzza da lontano di ridicolo, di fetidume nazionalista, scovando invece e invitando a una verità più mite, fraterna e semmai indomita. Lavorando con i ragazzi, ho scoperto quanto a lungo il ramingo bordeggi rive di morte, dai Sepolcri alle Ultime lettere, fino alla Sera e a In morte del fratello. C’è ben poco di eroico, molto di bisogno di fratellanza, entro cui cercare ostinatamente un orizzonte di senso comune per il quale vivere e soffrire.
Trascinato via dalla risacca – era solo gl’inizi – che scomponeva e ora travolge destini e istituzioni, persi tutti i contatti. Non fui ai funerali di Fortini.
Fu Ruth a ricordarsi di me, di noi, dopo che era rimasta sola. Venne a trovarci. Facevamo delle passeggiate non distratte, quasi serene. Le piaceva ascoltare i canti e la fisarmonica, si cercavano i profumi della macchia. Tornò più volte. Ricordo le giornate piene di sole.
Dice Sartre da qualche parte che se le rivoluzioni costituiscono i momenti in cui i gruppi sociali sono in fusione, l’immobilismo è delle società fredde. Ma la restaurazione capitalistica che è seguita dopo i Settanta e che oggi giunge forse al suo culmine – che è sempre marciume, pestilenza sociale, devastazione di corpi e di anime - è ancora diversa: non c’è alcuna fusione visibile, né staticità, piuttosto un precipitare disperato, perché impotente. La distanza tra ciò che è necessario e ciò che ciascuno di noi può è tale da atterrire le energie più agguerrite, le menti più lucide.
Non si tratta di disperarsene, ma di capirlo.
Oh dei giorni mie fatiche, oh sorrisi
muti scavate e fidi nell’ordito:
- Dov’è l’inferno? dove i paradisi?
Dentro tremo, se fuor v’appaio ardito
che forti e fragili son i cuori e i visi
ma ultima la risposta che v’addito.
Per questo, punto tutte le mie forze a scartare l’erudizione e a coltivare intensa la critica. Mi tornano in mente le riflessioni di Fortini, lo scopro e lo coltivo maestro: agire perché si trovi e si manifesti più verità politica (dico “politica” e subito sbalordisco per la spaventosa distanza dell’odierna pratica posticcia dal suo significato) in una poesia sulle rose che in un documento politico e viceversa. Attivo con pazienza le verità che ho imparato, filtro le antiche sapienze, le metto ogni volta alla prova con le domande mute dei miei alunni, con le loro fatiche, le loro rabbie.
Ruth, dopo che la sua malattia precipitò, non volle più che andassimo a trovarla. La voce ferma e amica al telefono ci ripeteva che avrebbe deciso il tempo.
Ci chiamò in autunno inoltrato, invitandoci per il febbraio. Teneva sotto controllo il dolore con la terapia. Nelle poche ore che stemmo in via Legnano, dalla finestra dove si scorgevano gli alberi, era come sempre energica e determinata. Il non detto non tradiva pressioni sulla sua voce. A metà visita, chiese solo di farle un’iniezione. Spiegò tranquilla il modo a mia moglie, che non osò dirle di non averlo mai fatto. Tutti i pacchetti erano stati preparati, con i foglietti e le istruzioni di chi trasloca.
Sarà per la fiducia nella vocazione dell’uomo al bene, di cui parlava Brecht, o forse per il necesse della speranza, che soprattutto mi capita di ricordare il Fortini ‘cinese’. In un luogo riferisce l’insegnamento del saggio taoista al giovane andato a chiedergli d’istruirlo. Vuoi scoprire il segreto di fabbricare l’oro?, gli risponde press’a poco, comincia a percorrere tutte le mattine dieci chilometri a piedi. Oggi comprendo che la cosa più difficile, ma quella decisiva, non è la meta, bensì la direzione. Oggi comprendo la conseguenza suprema dell’umana condizione: nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. So e scopro ad ogni passo e insegno e comprovo che il futuro è la nostra realtà, è la verità del nostro presente, il senso del nostro passato; che quel futuro è intimamente, appassionatamente di parte. Non qualunque parte. Solo quella degli sconfitti, solo la parte di noi debole e oppressa detiene la ragione e la forza del futuro comune:
“Oppressori e sfruttatori con la non-libertà di altri uomini si pagano l’illusione di poter scegliere e regolare la propria individuale esistenza. Quel che sta oltre la frontiera di tale loro ‘libertà’ non lo vivono essi come positivo confine della condizione umana, come limite da riconoscere e usare, ma come un nero. Nulla divoratore. Per dimenticarlo o per rimuoverlo gli sacrificano quote sempre maggiori di libertà, cioè di vita, altrui; e, indirettamente, di quella propria. Oppressi e sfruttati (e tutti, in qualche misura, lo siamo; differenziati solo dal grado di impotenza che ne deriviamo) vivono inguaribilità e miseria di una vita incontrollabile, dissolta ora nella precarietà e nella paura della morte ora nella insensatezza e non-libertà della produzione e dei consumi. Né gli oppressi e sfruttati sono migliori, fintanto che ingannano se stessi con la speranza di trasformarsi, a loro volta, in oppressori e sfruttatori di altri uomini”.
È un giornalista dell’“Unità” a raccogliere nell’agosto, a due mesi dalla morte, le ultime riflessioni, che il quotidiano titolava E se il marxismo fosse il futuro? Più il tempo della mia vita scema, più insegno la passione, la fatica e la forza dei tempi lunghi. In quella primavera Fortini aveva scritto che quanto di te rimane, di tutti rimane, non sono i libri, non sono nemmeno gli affetti, nemmeno l’insegnamento, ma ciò che la tua vita ha cambiato nel rapporto con gli altri uomini.
Quando, di rado, mi capita di andare a tenere qualche discorso pubblico, apro l’armadio. Prendo un morbido sacchetto celestino d’altri tempi, con una grande scritta in nero, Furla. Si chiude con una filza di cordino nero. Appena lo apri, si spande il profumo di cuoio. La cartella marrone sembra appena uscita dalle mani dell’artigiano. Ha un solo graffietto sotto la piega che la chiude. Non una cucitura è strappata. All’interno vi sono tre scomparti per pochi fogli, giusto di formato A4. Su quello anteriore è cucita, a reggipenne, una striscia di vacchetta. La cinghia che sorregge la cartella è lunga e comoda, può essere indossata senza impaccio anche con la giacca blu con cui arrivava a lezione fresco e furioso.
Ci dispongo il foglietto d’appunti, controllo che vi sia un lapis, ripasso a memoria la scaletta. Il borsellino di cuoio nero, fermato su tre lati con la cerniera, lo lascio invece chiuso nello scomparto. So che all’interno porta stampigliata in caratteri gialli una parola, “mundi”.
11 febbraio 2020
Benedetto
Della tua persona ricordo il volto schivo e amico, le parole rare di chi ne conosce l’importanza, pronunciate quasi sottovoce, perché la ragione chiede argomenti. Del profilo intellettuale ci mancherà la tua curiosità viva per le asperità, le teste di medusa del presente, che ti spingeva a porgere ai lettori del “Manifesto” continui aggiornamenti su quanto di meglio nella cultura marxista e critica si muoveva, sempre attento a dar conto in modo chiaro, mai rapsodico del pensatore, del saggio, della ricerca, ma mai rinunciando a proporre con altrettanta chiarezza il proprio punto di vista, con i propri sì e i propri no. In questo senso hai rappresentato uno degli aspetti migliori del “Manifesto” e della sua cultura. Splendide le tue pagine penetranti e aggiornatissime sul capitalismo delle piattaforme: più di una volta mi è capitato di usarne nel mio mestiere d’insegnante. Sapevo della tua lunga, terribile malattia, ma il lettore del giornale non credo che se ne sia accorto, perché fino all’ultimo hai letto e scritto, con indomita passione e strenua lucidità. Da oggi siamo un po’ più soli, da domani avremo una ragione in più per difendere le nostre verità.
Ciao, carissimo Benedetto
7 gennaio 2020
Lorenzo
Il primo piacere è stato nello scrivere. Rivivo nitido – quale, maestro Ciso, fu il tuo innesco, in seconda elementare? – il godimento nel descrivere le lunghe ombre del tramonto sui campi dell’Aquilaia: giorni lenti e attoniti, densi dell’odore di quercia e di cacarelli di pecora, che il pomeriggio menavo al pascolo. In certi periodi nonno veniva a stare con noi. Il giorno cantava spesso, mentre lavorava sui poggi che scendevano da un versante e dall’altro del podere, o giù, nelle due piane dietro il Turbone. Cantava con voce fine, perché se non poteva essere potente era – il suo vanto - ariosa e limpida. Dopo tanti anni, negli urti quotidiani dei doveri, improvvisa trabocca la nostalgia, il rimorso di non ricordare quelle romanze. Questo forse, oscuro, mi agita la notte.
Era nato nel millenovecentouno, conservo ancora, da qualche parte, insieme alle canzoni di mio padre, uno o due dei suoi maggi. Sono in lunghi versi doppi, del paesino della nonna che non ho mai conosciuta, non so se ancora vi vengano composti. Hanno la melodia struggente degli amori primaverili e insieme solenne, come solo la voce di un popolo può avere. La piccola comunità di montagna, dove viveva vedovo da tanti anni, gli riconosceva da sempre un’autorità che lo rendeva orgoglioso. Non solo quando qualcuno riceveva o doveva scrivere una lettera d’amore, ma quando si trattava di affari, o di contrasti con il podestà, del cui partito mai prese la tessera, era lui che si andava a chiamare.
Ascoltavo come, mai andato a scuola, avesse imparato prima a leggere, poi a scrivere. Me lo facevo ripetere, la sera, in casa, dopo cena. Non era facile trovare, tra gli uomini delle varie famiglie presso cui dai sette-otto anni era stato mandato garzone, chi sapesse appena leggere e in più avesse tempo e pazienza d’insegnargli. Ma cantare era il suo godimento. Nei campi rubava ai grandi le parole, aveva buona memoria. Un giorno gli capitò (o se ne impadronì di soppiatto?) tra le mani il foglio stampato – circolavano nelle campagne, arrivati alle fiere o da venditori ambulanti ceduti in cambio di un pasto e di un angolo nella stalla – il testo intero di una romanza che già conosceva bene. Ne ebbe più d’una assicurazione, da chi sapeva leggere. Così si esercitò a lungo, dietro le pecore, a scovare via via nei righi stampati le parole che sapeva cantare. Imparò a indovinare i momenti di pazienza in chi sapeva leggere, per chiedere indizi e conferme. Grande fu la sua soddisfazione, quando s’accorse che poté imparare da solo, sul foglio, nuove romanze. Certo, solo più tardi, trovò un vecchio paziente che la sera gl’insegnasse il corsivo. Ma mai per lui l’attesa fu troppo lunga. Ogni tanto rivado alla pagina che scrisse per il mio matrimonio, rileggo l’animo gentile dei buoni sentimenti dell’occasione, accarezzo le righe sghembe, i confini incerti tra le parole, gli sbagli di suono.
Sognavo a occhi aperti per giornate intere, lungo le siepi, nelle anse del fosso, dove a maggio, prima della tosatura, s’appozzavano le pecore. Ascoltavo nella voce di mio padre le ansie non dette, la fatica, nelle necessità, della sua penna storta, la tenacia forte di mia madre, i giochi della sorellina. Solo qualche anno più tardi mi si svelò il piacere della lettura, come un godimento intimo, geloso. Dormono le cime dei monti, mi faceva recitare ammirata la mia insegnante in prima media, e le vallate intorno, i declivi e i burroni, cantavo a me stesso all’imbrunire piovoso, mentre immaginavo il mare che mai avevo visto.
No, scrivere non è bisogno divino o dono. Ho subito saputo, meglio, sentito l’inganno, l’albagia beffarda, il ghigno di chi lo ostenta. Scrivere è solamente necessario, come il respiro, il pane e l’acqua, come un nome e un tetto, una mano da stringere, un volto con cui guardarsi. Più tardi, nella mia vita adulta intendo, per un certo periodo di tempo ho creduto e affermato che ciò che è stato scritto ha la stessa realtà di una sedia, volendo indicare una sua rocciosa realtà indifferente all’autore e alle prevaricazioni del lettore. Sbagliavo, naturalmente, sull’opera letteraria e prima di tutto sulla sedia. Reagivo a certa critica assai intelligente e raffinatissima che faceva del proprio cinismo il lasciapassare per la sua danza sulle rovine che già si annunciavano, anche se forse nessuno immaginava di durata e ampiezza oggi a tutti palese. Soffrivo il sogghigno di quella elegante riduzione al nulla di qualsiasi testo, sentivo in quella disinvolta vaporizzazione una ferita sanguinosa sul mio corpo. Un’aggressione analoga solo all’oscena offesa all’intelligenza di chi ci governa, che quasi subito prese avvio e tutt’ora dura. Così, per reazione e per debolezza di ira e studio, mi sono aggrappato al pane duro e alla terra conosciuti accanto a mio padre, ascoltati nella voce di nonno. Per il troppo d’identificazione che allora non scorgevo, quasi a scartare da uno sguardo indegno, scagliavo quella sedia fuori della storia, come fosse una pietra o una pianta. Non vedevo che non solo, com’è ovvio e sapevo, la sedia è frutto storicosociale, ma soprattutto che è fonte di nuova storia e di nuova socialità, le quali a loro volta la rinnovano e trasformano. Il rigetto sano della derealizzazione intellettualistica m’impediva di vedere che la materialità non obbliga all’immobilità.
Questo so dirlo ora, ma prima, lentamente, con la forza delle cose si è fatta strada un’altra chiarezza. Parlo dell’idea di opera d’arte. Accompagnare per anni, quotidianamente, giovani adolescenti all’ascolto di un testo, scornarsi insieme con loro nei fraintendimenti improvvisi, nelle sordità, nelle impuntature, nelle proiezioni narcisistiche, percorrere le digressioni cui il loro chiarimento obbligava nella cultura, nella storia, nell’esperienza personale e nel sogno mi hanno portato al grado zero: i meccanismi che fanno vivere e regolano l’opera artistica sono i medesimi della conversazione con l’amico, della lista della spesa, della lallazione del bambino, del sogno. È solo questione di quantità e d’intensione: prendere consapevolezza di quei meccanismi, saperli vedere all’opera, fatto necessario per comprendere il testo, è un modo per comprendere noi e i nostri atti linguistici; così come è vero e produttivo il reciproco.
Noi non parliamo come lo fa una macchina. Sempre, in ogni atto linguistico palpita la vita: la sua memoria in continua ricostruzione, i legami privati e sociali del suo presente, l’investimento sul futuro che tutto riorienta. Ogni nostro atto linguistico è prima di tutto una domanda, anche quando sembra solo un’affermazione: a noi stessi allorché sembra solo all’altro e tanto più all’altro quanto più sembra solo a noi stessi. Nessun atto di parola, all’infuori di quello di dio, potrà mai dire tutto, ossia potrà essere in sé concluso. Sempre, a un grado più o meno grande, in ogni atto linguistico soffia e preme la massa del taciuto (perché ovvio, perché inavvertito, per economia di tempo, per volontà d’ingannare, per intimorire, per dominare, per paura) e del non linguistico (il legame e la posizione sociale, il ruolo istituzionale, la salute e la malattia, l’età e il sesso), ognuno potentemente concorre al significato, tanto che è sorprendente quanto tutto sommato poco frequente sia prendere fischi per fiaschi parlandoci. Non sorprende, invece, quanto sia difficile comprendere davvero e comunicare, tanto che lo stesso Dante se n’è sentito sopraffatto e, al culmine del suo titanico sforzo che ci lascia muti, torna allo smarrimento da cui era partito: “’ntender non lo può chi non lo prova”. Proprio perché l’atto linguistico è per sua essenza atto sociale in cui respira, anche se non intera, ogni lato della vita, esso è esperienza di vita, con la magmaticità intransitiva del soggettivo e del corporeo, del terragno che nessuna codificazione grammaticale, nessuna formalizzazione algoritmica, nessuna moltiplicazione enunciativa potrà interamente illimpidire. Si potrà solo praticamente trasformare entro certi limiti, maggiori questi nel breve periodo e in ambito individuale, minori in quello collettivo e nel medio-lungo periodo.
Chi scrive opere letterarie si colloca in una posizione particolare nella dinamica della comunicazione. L’assenza di un destinatario in presenza (e, in epoca odierna almeno, anche il sentimento d’impotenza che quell’assenza genera) sospinge chi scrive in un’area prossima a quella del sogno: la comunicazione gli appare e sente come prima di tutto rivolta a se stesso. A chi cantava mio nonno le romanze che a un certo punto principiò a comporre, mentre badava le pecore e le capre dietro le siepi? Ma, come si diceva, la domanda latente al sé è insieme domanda di un altro. È consolazione, certo, ma proprio perché è ricerca di un medicamento è al contempo costruzione, nella forma del come se, di un altro io, desiderato. In tale figura, in cui si congiungono quando il valore lo permette le molteplici parti, l’opera costruisce e quindi sceglie il proprio lettore, cui affida il “sii come me” che la fonda.
Se l’atto linguistico di chi scrive o parla dà vita a un’esperienza che convoglia zone più o meno ampie di taciuto e d’indicibile necessarie alla significazione, anche l’ascolto e la lettura sono un’esperienza che richiede un convergente investimento di personale indicibile e taciuto. Se, quando qualcuno ci parla, le nostre armoniche non risuonano con le sue, le parole rimangono inerti. Anche l’avversione e persino l’odio richiedono un preliminare terreno d’intesa: tout comprendre c’est pas tout pardonner. Comunicare è un atto di collaborazione - il che non implica che sia tra pari - il frutto è il significato.
Proprio perché l’atto linguistico, contro la sua apparenza e talvolta pretesa, è sempre, sui due lati dell’emittente e del ricevente, sporco di terra, sangue e rapporti sociali, la sua comprensione passa preliminarmente sulla doppia domanda: chi parla? chi ascolta? Risiede qui la ragione del fatto che la Verità è sempre storica, che due persone diverse che dicano la stessa cosa non dicono la stessa cosa, che – per ricorrere a parole antiche e più chiare– le idee dominanti sono sempre della classe dominante, come concretamente sapeva mio nonno, anche se non sapeva dirlo. Ed è sempre da qui la spiegazione del fatto – costatazione banale – che di ogni scritto, di ogni memoria – ivi compresa quella personale - cambiano nel tempo significato e giudizio.
La posizione di chi legge rispetto a chi ascolta è simmetrica a chi scrive. La maggiore figuralità cui è costretto chi scrive - figuralità che a sua volta è alle prese con una vicenda più o meno complessa, storicamente codificata della già molteplice strumentazione della figuralità – costringe a sua volta il lettore a un grado decisamente più alto di collaborazione nella produzione del senso. È appena il caso di notare che tale figuralità è in parte resa necessaria dall’assenza del ricevente e in parte, la maggiore, dalla cerimonialità del ruolo, anzi dei ruoli sociali assunti nel tempo e nelle determinate civiltà dall’istituzione letteraria, dal ruolo del singolo autore, nel tempo della sua vita, e della sua opera nel corso storico, dai ruoli sociali della critica, dei singoli critici, per non parlare degli aspetti materiali della circolazione, della produzione, ecc. Forse è stato Leopardi a dire la consapevolezza più acuta della rilevanza del lettore: “ben ch’io sappia che oblio / preme chi troppo all’età propria increbbe”.
La fruizione artistica è un’esperienza. Leggere un’opera letteraria lo è: differente dalla posizione di ascolto in una conversazione solo nel grado e nelle forme di contatto. Non diversamente da ogni esperienza, viene coinvolta a gradi diversi la totalità della nostra persona e delle nostre facoltà, uscendone modificati, tanto che, volgendoci indietro, possiamo ogni volta dire con Petrarca “quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono”.
Come e anzi più che nella conversazione, dove la posizione d’ascolto può agevolmente trasformarsi in interlocuzione che riattiva la conferma o la confutazione o la precisazione di chi ha parlato, il lettore collabora alla produzione del senso. Vale qui richiamare che la stessa figuralità e la complessità delle forze che la producono, né l’una né le altre tutte e sempre controllate o controllabili da chi scrive, impedirebbero di fronte a un testo un’interlocuzione del lettore con il suo autore analoga a quella della conversazione, quand’anche fosse possibile. Come e più di chi ascolta in una conversazione, il lettore non è lo specchio del testo. Leggere non è premere il tasto di una registrazione: è una collaborazione, il suo frutto è il significato di volta in volta assunto dal testo. Detto rapidamente, ristretto lo sguardo alla poesia che, rispetto alla prosa, opera una forte intensificazione di alcuni aspetti della figuralità linguistica allentandone altri, l’esperienza della lettura chiama alcune specifiche facoltà del lettore: da quelle fisico-corporee (apparato e muscoli fonatori) che attivano l’area della sensualità; alla fantasia e alla memoria da cui origina la scoperta di nessi, analogie, risonanze; a quelle logico-cognitive da cui vengono innescate relazioni, conoscenze culturali, esperienze; fino alle istanze psichiche profonde che, sollecitate dal testo, attivano la loro massa emotiva e figurale. Va da sé che la storia dei significati prodotti dalle differenti interpretazioni non è meno interessante di ognuna di esse e che chi legge, lo sappia o no, s’impegna anche in questa seconda costellazione di significati.
L’ascolto in una conversazione, o in quei veri e propri comizi che nell’odierna comunicazione sociale si mascherano da conversazioni, è facile solo in apparenza. Le difficoltà provengono dalla mancata chiarezza - per ignoranza, inganno o autoinganno - nella risposta alle due fondamentali domande preliminari: chi parla? chi ascolta? L’importanza negativa della non consapevolezza di sé nella collaborazione al senso non va sottovalutata, proprio per la rilevanza del sottaciuto e dell’indicibile nella produzione di significato. Il suo peso si rivela meglio se consideriamo l’azione dell’imbonimento demagogico. Come ogni discorso, il comizio costruisce il proprio fruitore. Il demagogo costruisce un ascoltatore che accoglie in parte la realtà sociale del suo destinatario, quel tanto che sia funzionale al proprio fine e al contempo generi in esso l’illusione che quel tanto o poco sia se stesso, al fine di nascondere ciò che più propriamente gli appartiene. In questo modo, il discorso demagogico, con la forza performativa di ogni comunicazione, attiva un circolo progressivo di nascondimento e adesione.
Di fronte all’opera letteraria (intendo quella di valore, che passa per la figuralità), il lettore si trova paradossalmente in un grado di difficoltà paragonabile a quella del destinatario del discorso demagogico. Questo dipende, a un livello puramente strumentale, dalla necessità di far fronte all’alto tasso di figuralità, poi dal prestigio sociale del genere ed eventualmente del testo e dell’autore, infine dalla forza illocutoria data dal piacere e dalla capacità di persuasione dell’arte, tanto più forte quanto più essa sia di valore: il “sii come me” tende sempre a trasformarsi in “sei come me”. Solo che se il lettore si lascia condurre a questo punto, giunge, come in certe esperienze mistiche, all’annullamento di sé, al puro silenzio. Realizza così, sul lato del lettore, quello che gli antichi greci e romani dicevano del poeta: essere un puro vaso dove soffia la voce del dio. Ma dio non ha voce umana. Il lettore dell’opera letteraria si trova dunque di fronte a una lotta che impegna tutto se stesso: corpo, ragione, sentimento, morale, memoria, relazioni sociali e umane, senza però trasfigurarle, anzi vivificarle e chiarirle. Deve abbandonarsi completamente all’opera e però tornare se stesso più sicuro e consapevole di prima. Questa è la collaborazione del lettore da cui può nascere il senso dell’opera, che non può che essere nuovo senso, come nuovo è diventato il lettore.
Il critico non è diverso, se non per collocazione e ruolo sociali, poi per gradi diversi di competenze tecniche, dal lettore comune. Lo sappia o no, il suo compito non è mediare tra opera e lettore comune, non è istruire quest’ultimo, spiegandogli l’opera. Spiegare significa aprire il plico, di cui misteriosamente il critico conoscerebbe la chiave, cosicché il tesoro senza di lui chiuso si offrirebbe ai profani. Egli non è il prete cattolico cui è riservato la custodia della chiave della scrittura. No, il critico ha un compito assai più arduo e responsabilità ben maggiore. Non solo è tenuto a padroneggiare il privilegio della sua corporazione, ossia le conoscenze tecniche, quelle storico-filologiche dell’opera e dell’autore, la conoscenza della storia delle interpretazioni, ma deve anche avere una viva sensibilità per le relazioni sociali in cui sono presi se stesso e la propria opera interpretativa. Egli, lo sappia o meno, in forza del proprio ruolo sociale compie sempre un’interpretazione che si colloca in una certa parte dell’epoca in cui opera: sociale, politica, culturale, umana. Questo anche in un tempo, come l’attuale, in cui tutto appare opaco, in cui ogni pagina scritta, analogamente a quella del poeta, prende la forma d’una pagina di diario. Per questo il critico più avvertito oggi scrive come se una parte collettiva lo riconoscesse e vi si riconoscesse, perché, come ogni discorso, il suo contribuisce alla formazione di essa e alla consapevolezza di se stessa.
9 dicembre 2019
Pubblico qui di seguito i testi di due mie lezioni nell'insegnamento di Letteratura italiana e didattica della letteratura dell'Università di Roma tre. I testi sono stati presentati, rispettivamente, nella lezione del 29 ottobre e in quella del 28 ottobre 2019. v.a., 4 novembre 2011
Venire al mondo
Su una poesia di Zanzotto
Nella complessa stratificazione linguistica, retorica e culturale della produzione zanzottiana, che soprattutto prende avvio con La beltà del 1968, la poesia Al mondo non presenta particolari difficoltà, tuttavia, per comprendere il significato appena più che letterale di alcuni passaggi e quello d’insieme del componimento, è necessario vedere preliminarmente sia alcune caratteristiche della produzione di Zanzotto, sia il posto occupato dalla raccolta del ’68 nel percorso del poeta.
L’esordio postermetico (Dietro il paesaggio, 1951) evidenzia subito nella voce poetica di Zanzotto una robusta tensione orfica, per la quale il canto nasce da uno stato di perdita, di taglio irrevocabile, di caduta da un’Origine, il cui raggiungimento è insieme impossibile e necessario, gettando il poeta in una condizione di tremore di fronte a qualcosa di sacro. La parola, unico terreno mondano di quel ritorno, è, nella sua essenza, impossibile, cosicché ogni rinnovato tentativo di canto può prendere la via del tragico o, come nel primo Zanzotto, dell’elegiaco. Se in quel primo periodo il varco dalla condizione di derealizzazione e sofferenza veniva tentato con un’uscita per dir così immediata “dietro il paesaggio”, in seguito è progressivamente cresciuto il bisogno d’immersione nella realtà, dai suoi livelli biologici e materici a quelli storici, da cui è derivata l’apertura alle scienze – chimiche, matematiche, linguistiche, mediche, psicoanalitiche, ecc. -, ai loro linguaggi e al loro rigore razionale. Ha cioè energicamente preso piede un’altrettanto vitale controspinta materialista, da connettere al socialismo resistenziale e postbellico di cui il poeta è stato parte. Per dirlo sinteticamente, Zanzotto, avendo nella prima raccolta trovato vietata la strada di un ritorno immediato all’Origine, nella Beltà ha vigorosamente volte le spalle per un lungo détour di attraversamento del mondo.
Per concludere questo punto in modo più stringente sul piano tecnico e stilistico, vanno sottolineati tre elementi, importanti soprattutto a partire dalla Beltà. L’atto linguistico, considerato tanto nelle dinamiche fisico-biologiche e logiche del suo prodursi, quanto nella dimensione semantica e simbolica è in Zanzotto il terreno primo della sua esplorazione della realtà. Detto diversamente, se in lui la poesia nasce dal bisogno della Verità che è insieme verità dell’Essere e principio di piacere, il linguaggio è il corpo fisico e simbolico dove ciò può essere cercato.
Inoltre, il corpo a corpo con la lingua – ove sono fatti convogliare materiali via via crescenti delle cognizioni scientifiche di fisica, linguistica, psicoanalisi – porta il poeta, in certe aree della sua ricerca, a porre in forte rilievo la connessione, sentita aurorale della parola, tra suono e significato, cosicché il secondo spesso pare nascere per metonimia dal primo, in un processo di continuo slittamento allitterativo su cui rampollano nuovi significati. Preme sottolineare a questo riguardo che non pochi interpreti, a principiare da Stefano Agosti, hanno posto l’accento sulla meccanica del significante e oscurata la proliferazione di significato cui essa approda, dimidiando in questo modo la potente fertilità della poesia zanzottiana, la cui densità semantica colpisce qualunque lettore, magari stordendolo.
Infine, se l’amplissima apertura avvenuta dopo Dietro il paesaggio ha portato a una sorta di verbalizzazione del mondo, tanto da generare l’impressione che il moltiplicarsi dei tentativi di parola abbia cancellato la sua impossibilità costitutiva, uno sguardo più attento riscontra, si può dire a ogni passo, la faccia di Giano dell’antinomia fondamentale di cui sempre vive la poesia zanzottiana, tra tensione orfica e spinta materialistica, tra impossibilità e necessità. Tale lacerazione traduce nella pagina un andamento spezzato di accensioni e perdite, che collocano l’io poetante in una condizione psicologica ed emotiva non dissimile dalla voce petrarchesca del Canzoniere, per quanto distanti siano gli approdi dello sperimentalismo zanzottiano. Così accade che spesso la furia linguistica, l’energia emotiva e razionale del contrasto, in cui la poesia di Zanzotto si genera e vive, si raggrumano nell’antitesi, talvolta nell’ossimoro a costituire, insieme con le figure dell’allitterazione, i procedimenti retorici fondamentali dello stile.
Il componimento di cui parliamo, compreso nello snodo fondamentale del 1968, è in qualche modo emblematico della mossa che sempre costituisce il sorgere dell’atto poetico: l’uscita dal proprio solipsismo, dall’angoscia del vuoto esistenziale e gnoseologico per il tramite dell’incontro con la realtà, qui colta nella sua sintesi più inclusiva, esplicitata programmaticamente già nel titolo: Al mondo. La poesia mette in scena la mossa dell’io poetante verso il fuori di sé. La descrizione di dinamiche e di episodi, con la loro intermittenza, i loro abbagli e conquiste, è accompagnata da una lucida sorveglianza razionale che ricorre anche alla strumentazione della psicoanalisi lacaniana.
Il testo si articola in tre strofi di diversa lunghezza (vv.: 8,8,6), chiuse da un monostico finale. I versi liberi hanno misura fortemente variabile: dal pentasillabo tronco al verso di quattordici sillabe. La scansione sintattica innerva di sé tutto il componimento, al punto d’imporsi sia nella misura del verso che della strofe, risultando assente l’enjambement e coincidendo i confini dei quattro periodi con le quattro partizioni del testo (eccezione minima l’ultimo verso della più breve e concitata terza strofe). Tale predominanza del ritmo sintattico è la manifestazione tecnica della forte sorveglianza razionale che impronta il componimento, di cui si è detto.
La prima e la terza strofe sono apostrofi al mondo (nella prima un breve passaggio al sé), mentre la seconda e il monostico finale parlano dell’io poetante (nella seconda un breve passaggio al mondo): la seconda in forma descrittiva, il monistico in forma di apostrofe. Tale costruzione binaria della macrostruttura rispecchia la coppia oppositiva fondamentale, sorgente del componimento: il soggetto nella sua inanità, falsità e il proprio fondamento, la propria ragion d’essere e Verità, l’Origine, cercata nel “mondo”. Prima di procedere all’osservazione più ravvicinata della poesia, è utile richiamare la condizione costitutiva della ricerca zanzottiana: il soggetto (io poetante) e l’Origine (qui “mondo”) – semplificando: soggetto e oggetto – sono presi in una relazione che vede nel secondo il fondamento del primo, ma il taglio radicale intervenuto ha gettato il soggetto in un piano definitivamente altro. Per questo il tentativo del soggetto è sottoposto a un’infaticata coazione a ripetere e a un inesorabile destino di fallimento.
La prima strofe si apre con l’invocazione: “Mondo, sii, e buono;”. Gli accenti di prima, terza e quinta sede (preferibile la lettura di senario con dialefe, sul possibile quinario), subito impostano una disposizione ritmica incardinata in quella sintattica, cadendo ciascuno nelle tre articolazioni di questa, ben segnalata dall’interpunzione. E subito la comparsa semantica si lega in una robusta struttura allitterativa: la prima e l’ultima parola, bisillabiche, sono in quasi rima. Il secondo verso, generato dal primo per connessione semantica (sinonimica nel caso del verbo; in figura etimologica nell’avverbio) e allitterativa, denuncia in questa ridondanza un’ansia esortativa propria di chi chiede soccorso. Si noti, di passaggio, come l’energia allitterativa favorisca l’apertura plurilinguista divenuta clamorosa all’altezza della Beltà: “buonamente” è un arcaismo che il Grande dizionario della lingua italiana curato da Battaglia attesta nella scuola siciliana. Nel terzo verso si dispiega la tensione avviata nei primi due, come in una fuga musicale: ai due verbi che sollecitavano l’esistenza (“sii”, “esisti”), nel terzo verso fanno riscontro quattro verbi di sollecitazione all’azione, che incalzano uno dopo l’altro fino all’esplicitazione della chiusa: “fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto”. Qui ogni elemento converge e si rafforza vicendevolmente in una tensione unica crescente: le quattro proposizioni sintattiche coordinate in asindeto dispongono ognuna il verbo in apertura, il quale costituisce le prime quattro parole piene; tutti gli accenti ritmici sono in levare, dal momento che cadono nella prima sillaba di ogni verbo; i primi tre sintagmi, essendo privi del necessario completamento sintattico (la prima si conclude con la congiunzione subordinante, le altre due con una preposizione) sia enfatizzano l’azione invocata (“fa’”, “cerca”, “tendi”), sia segnalano la sua indeterminatezza. Nell’ultimo sintagma lo sforzo invocante esplicita la vera azione attesa: “dimmi tutto”. Il verso ora si distende nel ritmo solenne dell’endecasillabo che, tanto nella trama allitterativa quanto nella disposizione ritmica, asseconda la concitazione ascendente. Per il primo aspetto, il verso passa dalla doppia allitterazione iniziale della gutturale /c/ in posizione post tonica, all’ampia proliferazione della dentale, alternata nei due esiti sonora e sorda: “fa’ CHe, cerCa Di, TenDi a, Dimmi TuTTo”; per il secondo, mentre il verso si apre con gli accenti in levare nelle sedi dispari (prima e terza), nella più ampia seconda parte e in parallelo con i fenomeni allitterativi l’accento ritmico cade nelle sedi pari: sesta, ottava, decima. Il terzo verso raggiunge dunque l’acme della prima breve sequenza di apostrofe al mondo.
I tre versi successivi costituiscono simmetricamente una sequenza volta ora al soggetto. Il passaggio avviene senza connessioni logico-sintattiche, per la giustapposizione di una brusca apparizione: “ed ecco”. L’opposizione referenziale tra le due sequenze (oggetto/soggetto), evidente sul piano semantico, si stempera per la forte attrazione allitterativa e ritmica sul verso iniziale di questa sottosequenza. Evidentissima la prima per l’analogo disporsi nel verso dei due consonantismi (gutturale e dentale), ma evidente anche per il secondo, essendo endecasillabo: “eD eCCo Che io ribalTavo eluDevo”. La nuova sequenza, già in apertura, contrappone all’invocazione all’agire dell’oggetto un comportamento dell’io poetico del tutto incongruente con la propria stessa richiesta, a indicare una condizione di totale impotenza: “ribaltavo, eludevo”. Il primo verbo, “ribaltare”, ‘rovesciare’, implica tanto un capovolgimento fisico-spaziale, quanto un cambiamento di segno dal positivo al negativo, o viceversa. Come confermano retroattivamente gli sviluppi della seconda strofe e il monostico finale, questo verbo attiva nella pagina la strumentazione culturale psicoanalitica freudiana dell’autore. Le due valenze fondamentali del verbo indicano due diverse forme - patologiche - di difesa dalla sofferenza attuate dal soggetto, rispettivamente: la ‘proiezione’ all’esterno di una dinamica psichica interna e la ‘negazione’, compresa la variante ‘rinnegamento’.
La compresenza di significati contraddittori ora evidenziati si fa palese nelle antitesi che costituiscono i due versi successivi, incardinati nella catena di antitesi “eludevo” / “inclusione” / “esclusione” come di consueto rafforzata dal gioco allitterativo, nei secondi termini condotto fino alla figura etimologica. I due poli dell’antitesi non configurano un positivo e un negativo definitivi: rimangono stretti nella comune ambivalenza. Come l’inconscio, non obbediscono al principio di non contraddizione: “ogni inclusione era fattiva / non meno che ogni esclusione”, dove “fattiva” ha chiaro valore positivo, riconnettendosi anche per figura etimologica all’esortazione “fa’ che”. L’immedicabile impotenza del soggetto non esclude un accesso imprevisto e intermittente alla pienezza della Verità e del piacere, perché non è frutto del proprio agire, ma manifestazione dell’Origine, qui “mondo”. In questo Zanzotto condivide l’idea del grande simbolismo europeo per la quale il poeta non cerca, ma è colpito dalla verità. Sempre per lo stesso motivo, al fondo della ricerca zanzottiana permane la concezione che la Verità veste la forma del sacro, la poesia quella della preghiera. Per dirlo scherzosamente, Zanzotto non è cattolico, per il quale la salvezza viene dalle opere, ma luterano, per cui ci si salva solo per fede.
Il distico rimanente, nel riprendere circolarmente l’apertura della strofe, esplicita nella clausola finale la sovrapponibilità dei due antitetici soggetto e oggetto: “su bravo, esisti, / non accartocciarti in te stesso in me stesso”. La messa in scena dell’indeterminatezza del piano semantico è ovviamente assecondata – si potrebbe dire prodotta – da un’allitterazione densa fino alla pura ripetizione. Il verbo ‘accartocciarsi’ qui impiegato a raffigurare la negazione del senso, ossia in Zanzotto del manifestarsi dell’Origine, nella memoria del lettore rinvia a un passaggio topico di uno degli autori del nostro, tanto da destare il sospetto di trovarci di fronte a una traccia mnestica, Spesso il male di vivere ho incontrato: “era l’incartocciarsi della foglia”, scrive appunto Montale.
La seconda strofe è lo sviluppo riflessivo di quanto presentato nella prima. Il passaggio del tempo verbale dal presente all’imperfetto ne è la conseguenza. Già la distribuzione della materia segnala il fatto: i primi sei versi sono interamente dedicati alla riflessione del soggetto sul rapporto precedentemente introdotto; gli ultimi due tornano invece a rivolgersi direttamente al mondo.
La sequenza dei sei versi iniziali argomenta autocriticamente che quanto mostrato nella prima (“Il mondo così concepito”) è stato soltanto una proiezione del soggetto: “il mondo così fatturato / fosse soltanto un io male sbozzolato / fossi io indigesto male fantasticante / male fantasticato mal pagato”. Una rimessa in questione che certo non sorprende, ma che conferma il costitutivo movimento antinomico. Ora il ricorso a termini (“io”, “fantasticante”) e dinamiche (la proiezione dell’io nel mondo) genericamente freudiane e lacaniane diventa esplicito, necessario per comprendere il senso. Sempre rimanendo al livello lessicale, è notevole il rovesciamento di valore subito dalla medesima radice verbale: positiva nella prima strofe (“fa’”; “fattiva”), negativa nella seconda (“fatturato”). Nel campo semantico di quest’ultima ricade anche il significato di ‘fattura’ nel senso di fascinazione malefica, corrispettivo dell’io “male fantasticato”, espressione questa che rinvia al lacaniano “oggetto fantasmatico” teorizzato per la fase che lo spicoanalista francese chiama “stadio dello specchio”, nella quale l’io coglie la propria unità individuale, in connessione con l’identificazione narcisistica fuori di sé. Del resto il rinvio lacaniano è impiegato in un testo che nella Beltà precede di poco (X 1. – Lo stadio piscologico detto «dello specchio»), mentre la relativa nota d’autore ne conferma l’implicazione psicoanalitica. C’è infine un ultimo rilievo lessicale: “mal pagato”. Nel componimento finale della sezione Memorie o profezie o giornali murali e penultimo della Beltà, intitolato XVIII L’un l’altro guarda e del suo corpo essangue, incontriamo questo esplicit: “14. «La mia paga, la mia paga!»”, così annotato dall’autore: “«mes gages, mes gages», come dice Sganarello concludendo il Don Juan di Molière, dopo la scomparsa del suo padrone tra le fiamme”. Il riuso zanzottiano trasferisce la dinamica servo/padrone nel rapporto io/mondo e lo sberleffo plebeo di Molière diviene in Zanzotto aggancio per uno sguardo di vitalità elementare, mentre l’ironia della sequenza, ancora attiva, stempera la spinta tragica della vicenda. Non credo che sia ormai necessario soffermarci sull’addensamento allitterativo, presente qui e altrove, insieme tessuto generativo e prodotto della strutturazione semantica.
Come accennato, gli ultimi due versi della strofe tornano a rivolgersi al mondo. Gli incipit delle due parti della strofe sono in chiara contrapposizione anaforica: “Io pensavo” / “e non tu”. Anche qui, ora sul versante dell’oggetto, gl’impieghi lessicali producono un ulteriore passo verso la chiarificazione: “non tu «santo» e «santificato»”. I termini non lasciano dubbi sulla connotazione che essi danno al mondo, ovvero all’Origine. Rimane da chiedersi il significato delle virgolette che, com’è noto, vengono impiegate quando si fa ricorso a parole altrui, o per valorizzarle con l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, o per scaricare in parte la responsabilità di chi le riporta quando non le condivida, quindi per parzialmente svalorizzarle. Nella logica antinomica che governa la poesia zanzottiana, mi sembra plausibile il secondo significato, tanto più che l’aggiunta “santificato”, ovvero ‘fatto santo’ introduce una presa di distanza, come di chi dice ‘la tua santità ti è stata attribuita’. Tuttavia quel nesso “tu «santo»” insiste nella memoria, fino a richiamare il versetto appena variato di un inno della liturgia cattolica in lingua italiana, Gloria a Dio nell’alto dei cieli: “tu solo il Santo, tu solo”, ecc.
La connotazione religiosa induce retrospettivamente a soffermarci sull’iniziale “fa’ che”. In una raccolta successiva, Pasque, un testo d’intensa, straordinaria bellezza, La Pasqua a Pieve di Soligo, presenta un distico che principia con “Fa’ o Signore che-”, formula ripetuta in anafora senza il “che” per altri tre versi contigui. La concordanza autorizza dunque l’inclusione entro lo stesso campo semantico anche l’occorrenza, meno evidente, del terzo verso. D’altra parte, la possibile incidenza liturgica della giuntura “tu «santo»” spinge a ipotizzarne un’altra in connessione con la forma più esplicita della Pasqua. Le note d’autore alla raccolta tacciono al riguardo, ma è certo suggestivo che la formula incipitaria ricorra in più di una preghiera in lingua italiana degli Scout: “Fa’, o Signore, che io ti riconosca”, “fa’ che io sia sempre loro di esempio” (Preghiera del Capo); “Fa’, o Signore, che io abbia sempre le mani pure” (Preghiera dell’esploratore).
Come abbiano visto a suo luogo, il fondamentale endecasillabo conclusivo della prima sequenza, di cui abbiamo ora discusso “fa’ che”, si conclude con “dimmi tutto”. Tornando alla Pasqua a Pieve di Soligo, proprio nei distici che precedono la sequenza appena indicata, leggiamo in anafora trimembre: “Dic nobis Maria: quid vidisti in via?”, citazione di un versetto dell’inno Victimæ paschali laudes. L’imperativo latino è per una sua valenza perfettamente sovrapponibile al “dimmi tutto” del verso italiano, mentre la presenza dell’iniziale (“fa’ che”) autorizza l’estensione ad esso anche del valore religioso della formula liturgica.
La seconda strofe si chiude con un verso composto, si può dire, di parole che i grammatici chiamano “vuote”, ovvero che non sono portatrici di un vero valore denotativo autonomo, ma principalmente relazionale, ossia in riferimento ad altre parole della sequenza sintattica o del contesto extralinguistico: “un po’ più in là, da lato, da lato”. L’indeterminatezza indica l’inaccessibilità dell’Origine, il sottrarsi irrimediabile a qualunque definizione e avvicinamento. Il deittico “là” che compone di sé, per allitterazione – sempre in posizione tonica - l’intero verso, come in una lallazione infantile senza senso, è portatore, appunto, di un significato indefinito quanto assoluto di distanza.
La più breve terza strofe, che segue lo smarrimento appena indicato, riprende l’apostrofe con cui il componimento si è aperto. Ma dopo gli sforzi, gli avvicinamenti e gli smarrimenti che abbiamo seguito, l’energia pulsionale e la spinta razionale di avvicinamento alla Verità del mondo e della propria esistenza, si caricano di una furia tutta nuova che spinge sia alla concentrazione verso le articolazioni minime del codice linguistico, sia, con un moto opposto, all’ampliarsi del compasso plurilinguista. Per il primo aspetto si veda il verso d’apertura, “Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere”, cui si deve almeno aggiungere il deittico “su” ripetuto in apertura e chiusura dell’ultimo verso della strofe. Per il secondo aspetto si vedano già nel verso iniziale i latini“-sistere” e le preposizioni che lo precedono, poi il francese “chance”, la ripresa dell’arcaismo “buonamente”, il linguaggio settoriale della linguistica (“preposizioni”), il tecnicismo “congegno” e il ricorso etimologico colto della forma “etc.”. In tale affanno trova spazio un ulteriore chiarimento: “il congegno abbia gioco”. Il contesto e in particolare l’incipit della strofe danno a “congegno” il significato di ‘azione combinatoria del codice linguistico’ dalla quale si genera la possibilità della parola, che va intesa in senso forte, ovvero la parola che manifesta la Verità, dunque “congegno” indica il codice linguistico e, in modo più pregnante, l’atto poetico stesso. “Che il congegno abbia gioco” è esortazione-invocazione a un gioco serissimo, in analogia, ad esempio, con il “coup de dé” presente nel celebre Un coup de dé jamais n’abolira le hasard (Un colpo di dadi non eliminerà mai l’azzardo) di Mallarmé.
Il monostico finale, vistosamente evidenziato dal vasto spazio bianco che lo precede a sinistra, è latore di una sovradeterminazione di significato: “Su, münchhausen”. Il primo e più evidente significato si manifesta, come di consueto, a livello fonico, con la ripresa, in anafora, della sillaba esortativa (“su”) che apriva e chiudeva il verso conclusivo della terza strofe, la cui posizione anaforica, già apparsa nella sottosequenza finale della prima strofe, lo riunisce alle due strofi invocanti l’oggetto.
Il sostantivo è segnato con la minuscola per antonomasia, così come scriviamo ‘sosia’ per dire somigliante o ‘cesare’ per dire imperatore. Il nome proprio da cui deriva è il personaggio del romanzo inglese di Rudolf Erich Raspe, Le avventure del barone di Münchhausen, nonché di numerose altre opere, anche cinematografiche. È personaggio di mirabolanti avventure, delle quali la più nota è l’essersi tirato fuori dalla palude afferrandosi per i propri capelli. Se la palude è la condizione di smarrimento del soggetto, della negazione del mondo, münchhausen non può che essere il poeta stesso, rappresentato nell’atto tragicomico del suo uscire dalla condizione di derealizzazione, del suo venire al mondo. Allora il rapporto di uguaglianza stabilito dalla vistosa ripresa di “su”, unisce due versanti referenziali opposti:” mondo” e io poetico; oggetto e soggetto. Il riproporsi, in sede conclusiva e per certi aspetti riassuntiva, della sovrapposizione di uguaglianza e antitesi in un gesto tragicomico sia conferisce all’atto poetico - che è insieme venire al mondo dalla derealizzazione e avvicinamento alla Verità –uno statuto di provvisorietà per il quale l’incontro è sempre intermittente, sia lo mostra irrevocabilmente soggetto al dubbio di proiezione fantasmatica e narcisistica. Inoltre la connotazione tragi-comica dell’atto di venire al mondo replica l’antinomia del procedimento nel campo della tonalità affettiva, revocando in dubbio la tragicità insita nella descrizione dell’impotenza, tramite l’immissione della distanza ironica.
Per comodità espositiva abbiamo lasciato ai rilievi occasionali l’osservazione sul registro linguistico, cui conviene qui dedicare uno sguardo complessivo. La prolifica disponibilità plurilinguistica, praticata da Zanzotto a partire dalla Beltà, vede nel nostro componimento un’ampia escursione, che dall’alto al basso va dall’arcaismo (“buonamente”), passa per l’infratestualità letteraria (“accartocciati”, “mal pagato”), si apre a lingue diverse dall’italiano (latino, francese), ricorre ai linguaggi settoriali (psicoanalitico, liturgico, linguistico), si abbassa a sintagmi di un tecnicismo impoetico (“congegno” e soprattutto “super-cadere super-morire”) ove sono da includere anche i sintagmi di verbi privi di complemento del v.3, non teme di costruire versi, come nel caso della chiusa della seconda strofe, che si avvicinano all’asemantismo, per raggiungere infine zone che potremmo chiamare di grammaticalismo puro: “Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere”. Vero punto limite, questo, dove viene a nudo la costitutiva spinta a ritroso, verso la struttura logica originaria - ancora presemantica del linguaggio, quindi di ogni significato possibile - dell’esistenza stessa, verso l’Origine, appunto. Tuttavia tale escursione non dà mai all’impasto linguistico una tonalità letteraria, quasi che il piacere che ne deriverebbe fosse un velo, peggio un inganno, nel furioso tendere alla radice dell’esperienza esistenziale, la cui intermittenza di accensioni e oscuramenti è meglio messa in risalto dalla coloritura media del tono. Il tutto, naturalmente, genera ed è generato dall’addensamento allitterativo del dettato.
Riassumendo, abbiamo visto che l’io poetante, partendo dal senso di non appartenenza e di intransitività, ovvero dallo smarrimento del sé, s’impegna in un gesto di apertura al mondo. Nel suo percorso, nelle sue conquiste e nelle sue perdite il testo commentato è il paradigma della venuta al mondo. Allo stesso tempo, poiché per Zanzotto tale processo coincide con la nascita della parola e, in particolare, con la nascita della parola poetica, il componimento è il paradigma della nascita della poesia.
Il testo ci conduce preliminarmente in una zona dell’esperienza che le resistenze psicologiche, le finzioni sociali nascondono a noi stessi: là dove la domanda di senso dell’esistenza nostra e del mondo si fa radicale. Ci porta quindi nella complessità delle stratificazioni linguistiche, e, data la particolare densità dei fenomeni, ci fa fare esperienza della materialità dell’atto linguistico, che è sonorità e movimento corporeo. Noi lettori compiamo, potremmo dire, un lavoro culturale-razionale e uno sensuale-emotivo. Infine, a un livello più alto, il testo ci apre all’esperienza che il senso della nostra esistenza individuale è tutt’uno con il senso del mondo, che l’approdo all’uno è approdo all’altro e viceversa. Venire al mondo è in una certa misura far avvenire il mondo, con l’enorme responsabilità che questo ci chiede. È però questa una conquista mai stentorea, mai – per usare un linguaggio caro a Zanzotto – paranoica o, direbbe Leopardi, superba e sciocca. È una conquista sempre consapevole di essere falsa, inesorabilmente impastata di proiezioni narcisistiche. Di qui l’esperienza di un eroismo rasoterra, doloroso, certo, ma mai tragico, mai definitivamente sconfitto.
Il grido di Saba
Il breve sviluppo narrativo, che nasce nel mezzo dell’esperienza di psicoanalisi freudiana dell’autore, si articola nella tripartizione consueta dei componimenti sabiani. La poesia si apre con un artificio grafico non usuale che espone vistosamente il ternario iniziale, preceduto da un ampio spazio bianco, fenomeno ripetuto ravvicinatamente da altri due ternari. Il fatto impone di analizzare preliminarmente l’andamento ritmico del testo. Tutti i versi, eccetto l’incipit, i due successivi ternari e gli adiacenti ad essi, sono endecasillabi, sicché la distribuzione grafica indica che il testo si compone di 18 versi endecasillabici, 3 ternari e 2 novenari. Tuttavia uno sguardo più attento rivela che malgrado la misura di novenario sia in entrambi i casi confermata dalla struttura sintattica, terminando con il punto fermo, il contiguo ternario, così clamorosamente isolato nello spazio bianco, va idealmente a ricomporsi, per sinalefe, in un endecasillabo regolare con il novenario che lo precede. In altre parole, ci troviamo di fronte a una latenza che prende la forma dell’ambivalenza: sono due coppie di novenari più un ternario, ma anche due endecasillabi. Chiave di volta è il ricorso possibile alla sinalefe, un fenomeno che ricorda il precedente illustre della sinuosissima clausola di un novenario del pascoliano Gelsomino notturno (“È l’alba: si schiudono i petali / un poco gualciti”), dove tuttavia la sinalefe era più esplicitamente richiamata. L’effetto comunicativo, pur ricorrendo ad artifici opposti (in Pascoli la regolarità è riottenuta per separazione; in Saba per riunione), è convergente: si parte da una sospensione, oppure si è costretti a crearla. In entrambi i casi si fa largo un vuoto, in Saba raddoppiato dall’enjambement; quel vuoto è l’emersione dell’indicibile.
La scena d’apertura, che si dispiega nei primi quattro versi, è la presentificazione ex abrupto del trauma, che irrompe, come indicano i puntini di sospensione, nel tessuto ordinato del vissuto. È questa la punta dolorosa su cui s’impegna il lavoro poetico. I verbi sono al presente, la vivezza di singoli particolari e l’indefinitezza dell’insieme producono la fissità di un incantesimo malefico. La percezione auditiva coglie solo rumori preverbali, quasi preumani, giusta l’attacco singhiozzante, dove l’assonanza interna concorre a sottolinearne il sobbalzo: “…un grIdO / s’alza di bImbO”. La cadenza dolorosa, travalicando la semantica esplicita, si aggruma nella fissità ossessiva, proclamata dalla rima baciata, della clausola trisillabica dei primi tre versi su quattro: “…Un grido”, “E piange”, “Si frange”.
Ma già al v.4, che pur s’apre con lo straziante “per sempre”, s’insinua un primo, quasi mimetizzato, movimento distanziante: “quel”. Il deittico deposita, senza dirlo, uno iato temporale tra la scena iniziale e lo sguardo che la osserva. Appena oltrepassato il confine del novenario, la spinta mossa dal deittico spaziale si fa subito, con quello temporale, irruenta: “Adesso”. Il tempo verbale al presente (“è un uomo”; “È Umberto”), riacquistata la propria determinazione nel flusso del tempo, si contrappone frontalmente al valore assoluto della presentificazione iniziale. Il ternario, così rilevato dalla disposizione grafica, si carica di un’energia del tutto particolare, come uno strappo doloroso dalla scena iniziale, tanto che alle sue spalle si riconnette alla notata cadenza trisillabica facente capo all’iniziale “…Un grido”, davanti a sé propaga la propria energia in altre tre occorrenze consecutive dello stesso movimento ritmico-sintattico: “Il bimbo”, “esperto”, “È Umberto”. Va notato che, dopo la ripresa di “Il bimbo” che incarna il suo polo temporale opposto, il deittico “Adesso” si lega per assonanza e per consonantismo doppio ai due successivi trisillabi in rima baciata: adEssO : espErtO : umbErtO. Pertanto esso viene a costituire esattamente il centro focale di due diverse catene semantiche e ritmico-sintattiche: quella del ternario graficamente rilevato che fa capo a “…Un grido”; quella, più ampia, dei trisillabi non separati dall’endecasillabo: ““E piange”, “Si frange”; “esperto”, “È Umberto”. A rafforzare la rilevanza, in qualche modo a sé stante, della catena dei trisillabi concorre anche il fatto che sono tutti esposti in enjambement forte.
Ecco la sequenza complessiva:
“…Un grido”, “E piange”, “Si frange” “Adesso” “Il bimbo”, “esperto”, “È Umberto”, “quel bimbo”.
Non sarà inutile, a questo punto, osservare che nella rete allitterante è attratto anche “sospEttO,” interno al v.14, con la quale condivide anche il tono affettivo.
Che “bimbo” e “Adesso” costituiscano i due termini dell’opposizione riconquistata dal lavoro poetico (“Adesso / sono passati quarant’anni. / Il bimbo / è un uomo adesso, un vecchio, esperto”) è confermato, oltre quanto già detto, dall’avere anche il secondo una ripresa interna al verso in cui cade l’assonanza.
Nell’ipersedimentazione dell’organismo artistico ogni elemento concorre al messaggio, anche in modo contraddittorio. Così, se sul piano della consapevolezza semantica e sintattica la conquista di “Adesso” si contrappone al “grido” del “bimbo”, invece in sede rimica il consonantismo e il prevalere in chiusura del timbro scuro (“-o”) accomunano longitudinalmente l’intera sequenza, cosicché la loro ruvidezza fonatoria sospinge ciò che per un aspetto è opposto in un’unica sfera emotiva di dolore e sforzo. Sciogliersi dallo sguardo di Medusa della scena del trauma, agganciarsi al principio di realtà dell’“adesso” non libera dallo strazio, da qui la secca sentenza di due emistichi, franta dall’‘abisso’ dell’enjambement: “È Umberto / Saba quel bimbo”.
Dopo la pausa forte, l’emistichio che segue apre la seconda parte della prima strofe, nella quale la voce poetante prosegue il lavoro di allontanamento dal trauma che la sta impegnando. I tempi verbali sono ora saldamente incardinati nella netta distinzione tra presente e passato (“va” / “fu”, “lasciava”, “fu”, “parve”). La sequenza è in realtà una ripresa dall’ancora oscura indicazione iniziale: v.3, “la donna che va via”. Lì l’allitterazione risentita della labiodentale connotava l’espressione di fretta sinistra (la memoria di lettore spinge verso un passo celeberrimo dell’Inferno, là dove, nella selva dei suicidi, “il gran pruno” di Pier delle Vigne cerca la parola tra spruzzi di sangue dal rametto troncato da Dante, così come uno stizzo al fuoco geme “per vento che va via”, XIII, v.42). A quell’immagine dolorosamente oscura si contrappone ora il gesto netto della voce poetante che parla di sé in terza persona: “E va, di pace in cerca, / a conversare colla sua nutrice”. In questa frazione il testo si fa discorsivo, l’argomentazione è finalizzata a consolidare il principio di realtà, l’andamento sintattico e ritmico si fa più leggero fino alle movenze da arietta melodica così frequenti in Saba, cui qui in particolare contribuisce anche la rima baciata: “che anch’ella fu di lasciarlo infelice”. Si deve notare di passaggio che la suggestione dantesca poco fa rilevata ne richiama un’altra, consonante con la più leggera e quasi euforica temperie emotiva di questo passaggio: l’emistichio “E va, di pace in cerca” rievoca al lettore le parole con cui Virgilio, di fronte a Catone, perora l’entrata di Dante nel Purgatorio: “libertà va cercando, ch’è sì cara / come sa chi per lei vita rifiuta”. I, vv.71-2.
Il cambio di passo ha riscontro diretto nel cambio di timbro. Rispetto ai due precedenti casi, la nuova rima baciata (“nutrice” : “infelice”) sia ricorre alle sole vocali chiare, sia, evitato il doppio consonantismo, poggia sulla levità della labiopalatale. Che la rima costituisca il grumo genetico di una nuova spinta emotiva e semantica è provato dalla ricca rete che essa prima e soprattutto dopo istituisce tanto in sede rimica che all’interno del verso. Già nell’emistichio che si è detto inaugurale abbiamo una quasi rima interna subito ribadita nell’allitterazione contigua (“di paCE in Cerca”). Verso il basso, poi, sia essa rima a distanza, prima con l’antonimo (“felice”) poi con “dice”; sia si collega in quasi rima con “piaCE”, ripetuto all’interno del v.22 (dove compare l’ultima occorrenza della sua quasi rima) del quale non sfugge la retroazione di paronomasia con il già indicato “paCE”. La rilevanza delle occorrenze attrae certo nella sua orbita anche “dolCE”, interno al v.19. Basta dare un’occhiata al lato semantico dei lessemi coinvolti, per vedere che essi dispiegano un campo opposto alla concatenazione ritmica, semantica e fonica caratterizzante la prima parte del componimento. Ora la tonalità emotiva è connotata da parole quali “pace”, “felice”, “dolce”, né sfuggirà che tutte convergono su “nutrice”.
La prima strofe si chiude sulla parola “nemico”, in rima baciata con il primo verso della seconda strofe: “antico”. In questa strofe, più breve, il racconto si distende nel quadretto sereno della visita serale dell’io poetante a casa della nutrice. I tempi verbali, salvo l’imperfetto “regolava”, sono tutti al presente. Il marito è morto, l’oggetto totemico che lo ricorda, l’orologio, è ora regolato con piacere dal visitatore. È dunque quella memoria ad attrarre le asprezze rimiche dell’avvio (“conforto” : “morto”), nonché a ricorrere alla richiamata rima baciata, che certo rinvia alla medesima negatività sia sul piano semantico che nell’assonanza a distanza con “grido”. Tuttavia la nota negativa tende a sfumare nella lontananza, acquisendo un tono vagamente nostalgico: “Appeso al muro è un orologio antico / così che manda un suono quasi morto”. / Lo regolava nel tempo felice / il dolce balio; è un caro a lui conforto / regolarlo in suo luogo”.
Soffermando lo sguardo sul versante simbolico, non possiamo non rilevare che il piacere di cui ci dice il soggetto poetante nel sostituirsi al “dolce balio” è nient’altro che la presa di possesso del posto del padre da parte del figlio, gesto da cui, appunto, nasce il godimento intimo della scenetta d’interno descritta dalla seconda strofe.
A questo punto, concluso il processo di allontanamento dal trauma, la voce poetante non ha più ragione d’esistere. La scena interiore si chiude per aprirsi rasserenata alla realtà, dove risuona la voce della balia. Il lavorio psichico di cui la poesia è stata il resoconto si scioglie in un epilogo cui è sufficiente un monostico. La colloquialità piana che pare voler nascondere a se stessa l’aura ritmica dell’endecasillabo (“È tardi. Torna da tua moglie. Berto”) ha la sua ragione profonda nell’essere il rischiaramento, lì pensato definitivo, dell’“Urlo” che ha aperto il componimento. L’angoscia del tempo bloccato d’apertura è stata elaborata con il recupero della distanza e dei confini temporali, per cui non solo il “bimbo” si è determinato in Umberto e Berto, ma chi con lui soffriva, “la donna”, si è rivelata la “nutrice”. A conclusione del processo messo in scena dalla poesia, per il quale l’adulto Umberto ha riconosciuto in sé l’antico Berto, la voce della balia, sciogliendo il soggetto dal debito affettivo, ne autorizza il ritorno sereno alla moglie. Dico “sereno”, eppure quella rima aspra che torna, quel “Berto” resistente a tanta distanza di tempo, non lascia cadere del tutto il resto angoscioso da cui, nella prima parola, la poesia era partita: “… Un grido”.
Rimane un aspetto, che però può essere chiarito solo salendo dal testo in esame al macrotesto dell’intero canzoniere: in un’opera d’arte nessun elemento è davvero significante a sé, ma trova la ricchezza del proprio valore nella rispondenza con l’insieme. La conciliazione finale tra la balia e la moglie copre in realtà un altro conflitto, quello che, taciuto e per questo tanto più angoscioso, apre il componimento, ossia tra la balia cacciata e la madre che la licenzia: nella battuta finale s’insinua in questo modo una tensione silenziosa a pregiudicare la certezza serena che il tempo presente vorrebbe definitiva.
In sede di conclusione, dobbiamo osservare un dato di fatto elementare ma cruciale: se l’autore ha tratto la materia dalla propria esperienza psicoanalitica, non per questo il testo è opera del setting. La dinamica che abbiamo osservato, i suoi principi, le sue acquisizioni e il suo frutto, ossia la poesia Un grido, appartengono interamente al lavoro poetico, che come tale avrebbe potuto prodursi su qualunque altra materia ed esperienza. Questo ci permette di considerare gli elementi fondamentali messi in luce nell’analisi non dico come frutto della psicoanalisi, ma neppure come solo risultato di un’esperienza individuale su cui pure così vistosamente s’installa Un grido, bensì, come sempre accade con opere di valore, quali condizioni storiche e collettive. Detto in sintesi: il lavoro poetico che Saba ha messo all’opera nel parlare di sé è il lavoro poetico nel nostro tempo; il Grido di Saba è il nostro grido. Ricapitolando per sommi capi, l’urgenza del lavoro poetico nasce dal trauma, ossia la sua spinta genetica è la risposta al dolore dell’impotenza, il passaggio qui osservato dall’oscurità alla chiarezza, dal dolore al piacere, dall’angoscia alla serenità è quello che il lavoro poetico realizza nella propria opera. Abbiamo osservato che il godimento conquistato dall’io poetante trascina con sé, nel congedo della balia, una sotterranea proiezione narcisistica a compensare il senso di colpa e che, infine, esso apre la strada all’identificazione conflittuale moglie-madre. Tale particolarità del Grido ci parla di un’altra condizione della poesia nel nostro tempo, che merita un’ultima riflessione.
La poesia, si è detto, nasce da uno scacco e gli reagisce. Ma i due piani non sono complanari: il primo è uno strappo, una cancellazione nella vita reale; il lavoro poetico si rifugia in un’imitazione, ciò che esso realizza è sempre “come se” fosse vero. La poesia (e l’opera d’arte in generale) è costituzionalmente un ibrido; per un verso è una realtà, anzi – quando è un’opera di valore – una realtà affascinante e desiderabile (è questo lo spazio del godimento estetico), per l’altro è invece una pseudorealtà, peggio, una finta pezza sullo strappo della realtà. Da qui il fatto che la risposta della poesia e dell’arte è sempre connessa all’eccesso e alla tara del narcisismo, ossia dell’inganno. È una realtà che il fruitore più ancora dell’autore deve sempre tener presente. Dalla mancata consapevolezza della diversa natura dei due piani sono nate nel secolo scorso e si riproducono le posizioni ora ciniche ora tragiche di chi afferma che l’arte è vita e che la vita è un’opera d’arte.
Mi sembra urgente rammentare queste verità elementari oggi che la cultura dominante, il senso comune, la condizione e la comunicazione sociale sono dominate dall’elemento estetico ed emotivo, oltre che dalla manifesta difficoltà di tutti a uscire dal perimetro soggettivo. Saba, invece, pur ossessionato dalla sua sofferenza egoica, sapeva bene che quel recinto è del tutto ingannevole. C’è una sua sentenza, a ricordarcelo: “Pianse e capì per tutti / era il tuo motto”.
26 maggio 2019
Lo smarrimento è grande, non minore del tracollo. Il primo dovere è l’accertamento di morte degli ultimi refoli che dal culmine dei primi Settanta mimavano vita. Il rimbalzo (termine borsistico) del PD - ossia del partito concausa della potente ondata nazionalista e autoritaria che travolge l’Italia e scuote l’Europa -, la derubricazione delle forzucole italiane alla sinistra del PD – l’1,7 oggi è tutt’altro dall’uno virgola di DP in presenza del PCI –, la sconfitta di Tsipras, l’arretramento della Linke e di Podemos tolgono, soprattutto a noi italiani, qualunque alibi.
Ciò che mi addolora non è la sconfitta personale – s’è fatta abitudine, da tempo, in ogni campo – ma la rabbia dei figli. A chi si affaccia ora alla vita, che da quando ha cominciato a votare ha sempre duramente perso, che cosa rispondere? Se uno di loro mi chiedesse “perché?”, rimarrei muto. Che cosa abbiamo lasciato? Che cosa abbiamo da indicar loro?
Madri e padri ci hanno additato la strada della crescita, seppur irta e aspra, accompagnandoci con parole e sostegno. Noi, la nostra “consapevolezza” che cosa facciamo? Basta ripetere le parole che abbiamo appreso? Basta rammentarle, nel tempo dello sperpero e dell’insignificanza? Le parole non bastano, dice l’amico. Prima ancora, la parola deve farsi carne: le parole che avevamo imparato vanno risignificate, rimasticate, ricacate nel tempo che ci travolge.
Ogni alibi è finito. Nessuno, nessuno detiene il potere di sciogliere e di legare. Ognuno si senta quel che è, effimero, ognuno misuri sul proprio pensiero e sulla propria parola la responsabilità per i moltissimi, ognuno ne accetti la verifica sulfurea dell’ora e insieme del secolo futuro. La parola è morta, se non diventa fatto, se non diventa legame, se non diventa progetto collettivo in movimento, se non diventa un’idea augurabile, fattibile – non importa se noi non ci saremo - per il mondo.
28 maggio 2019
Se un giorno uno sconosciuto lettore
il dito severo puntando ti chiederà
perché noi mai i sensi
abbandoniamo all’ebbrezza e perché
tanto avare consegniamo parole
tu, mia incolpevole figlia, questo potrai dire
caro costò il pane d’ogni giorno
là dove egli visse, che brevissime
fece le ore e mai scordò
il di mille anni sepolto sudore
di padri e madri, lievi ora
come fronde frementi alla terra
che dura consumò e mani e bocca e occhi.
Questo, dirai, seppe e operò che altri
almeno, non tocchi.
Intravista in sogno. 19 aprile 2019
Ripropongo qui l'intervento uscito su Officina dei Saperi. v.a., 5 aprile 2019
Mezzogiornificazioni
“Dopo venticinque anni di privatizzazioni e saccheggio al di fuori di qualsiasi standard di legalità diverso dal puro formalismo, si individua la cultura della vendita come nuova mission dell’Agenzia del Demanio. Invece di difendere l’interesse generale a curare i beni pubblici che sono in proprietà di tutti, il presidente dell’Agenzia, Carpino, li considera in proprietà del Governo in carica e si propone come facilitatore di una svendita volta a far cassa, in mancanza di una norma del Codice Civile capace di introdurre principi giuridici solidi che funzionalizzino il patrimonio all’interesse di tutta la comunità nazionale (che ne è proprietaria) insieme alle generazioni future. Il saccheggio del Governo ai danni dei cittadini continuerà indisturbato”. Per i motivi da lui qui espressi, Ugo Mattei, presidente del Comitato popolare di difesa dei beni comuni, “Stefano Rodotà”, invita tutti a firmare la legge di iniziativa popolare promossa dal medesimo Comitato.
Colpisce tale iniziativa del Governo italiano, non solo per gli effetti di sostanza a cui ci conduce la da lui proclamata “manovra economica del popolo”, ma più ancora per il ritrovarvi le identiche misure tempo fa “raccomandate” alla Grecia nel pieno del soffocamento per debiti, alla quale si consigliava di vendere il Partenone e qualche isola, costretta poi alla vendita di asset fondamenti come parte del porto del Pireo. A suo tempo e da più parti, soprattutto elleniche, si è parlato delle spoliazioni della Grecia come di un primo esperimento in corpore vili, di un sacrificio esemplare da sbandierare a possibili futuri e più onerosi indebitamenti, quali l’Italia.
Ma un teso volumetto di un paio d’anni precedente, ricchissimo di dati, scritto con mano agile e calibrato come un secco resoconto peritale, di Vladimiro Giacché, Anschluss. L’annessione (Imprimatur, 2013) sta lì a indicarci come quella strada fosse già stata efficacemente collaudata. La Treuhandandstalt, l’Istituto statale creato per la privatizzazione dei fattori economici della Repubblica democratica tedesca nel suo scioglimento nella Germania unificata, dal 1990 al 1994 privatizzò terreni agricoli e forestali, fino ad allora di “proprietà del popolo”, che “lo stesso Istituto indicò equivalenti al 40 per cento dell’intera superficie della Repubblica democratica tedesca” (p.162). Naturalmente questa è solo una parte dell’insieme della svendita compiuta dall’Istituto: “tutte le fabbriche e le aziende statali della Rdt, che impiegano 4,1 milioni di persone (oltre un quarto dell’intera popolazione della Rdt, e il 46 per cento degli occupati del paese) […] 8500 Kombinate e imprese, 20.000 esercizi commerciali di ogni dimensione, 7.500 trattorie e ristoranti, 900 librerie, 1.854 farmacie” (p.61). Proprietà andate interamente nelle mani del capitale della ex Germania federale, in modo tale che si può parlare della più grande colonizzazione nel cuore dell’Europa. È interessante notare che quella liquidazione totale di un intero stato e della sua economia ha assunto, come in Grecia, come in Italia, come altrove, la forma del ripianamento del debito. Nel caso della Rdt, sostiene Giacché, si è provveduto a crearlo con veri e propri trucchi contabili.
Tale espoliazione ha fatto precipitare la ex Rdt in una condizione preindustriale, gravata da disoccupazione, denatalità, emigrazione, perdita della capacità di ricerca e innovazione, diminuzione del reddito, assistenzialismo. La dinamica dissimmetrica creatasi tra le due regioni tedesche è tale da divenire stabile e, permanendo gli assetti capitalistici, irreversibile: “in un articolo comparso sul «Financial Times Deutschland» del 18 giugno 2008 si ipotizzava addirittura che per un completo riallineamento del reddito pro capite tra le due parti della Germania sarebbero occorsi ancora… 320 anni!” (p.168). Così il lettore italiano o quello greco non rimarrà molto sorpreso quando Giacché riferisce che nella pubblicistica tedesca è apparsa l’espressione mezzogiornificazione per indicare il dualismo tedesco e ancor meno si sorprenderà di vedere che l’appropriazione dell’Ovest prima e il successivo permanere dell’Est in una condizione di impossibilità a riallinearsi sono state accompagnate e coperte da una vulgata che commiserava la generosità della parte occidentale per l’enorme massa di capitale trasferito a quella orientale e successivamente addebitava alla pigrizia, al parassitismo dei cittadini della ex Rdt la loro arretratezza.
La vicenda dell’annessione tedesca ricostruita da Giacché assume valore paradigmatico di come la spinta costitutiva del capitalismo a trarre nuovo alimento dalla distruzione locale delle forze produttive abbia, nell’attuale fase cosiddetta neoliberista, sottomesso alla propria logica le forze politiche, le istituzioni, la cultura fino a scomporre e ricomporre interi stati. Un paradigma che ci aiuta a comprendere il filo rosso che tiene insieme l’Anschluss tedesca, la depredazione del popolo greco, la svendita del demanio italiano, la micidiale spinta disgregativa guidata dalle tre regioni del Nord (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) con la cosiddetta autonomia rafforzata. Una presa di coscienza ampia, un lavoro conoscitivo e pratico, per quanto ardui, sono sempre più urgenti.
Ripropongo qui la recensione apparsa su "Critica Marxista", nuova serie, 1. v.a., 2 aprile 2019
Franco Fortini, I poeti del Novecento, a cura di Donatello Santarone, con un saggio introduttivo di Pier Vincenzo Mengaldo, Roma, Donzelli, 2017
L’opera infaticabile, al contempo generosa e severa, di Donatello Santarone, nel riproporre alla disponibilità del lettore opere ritenute fondamentali per ricordarci del futuro, ci regala un nuovo gioiello del suo maestro, Franco Fortini. C’è in questa fatica dello studioso romano sia la sensibilità pedagogica dei suoi trascorsi d’insegnante nelle scuole, che la consapevolezza della ferocia entropica con cui oggi l’industria della comunicazione fagogita il passato e annulla il futuro nell’eterno presente della notizia spettacolo, o dell’urlo mediatico.
Se è vero che in Fortini, convinto che di sinistra non sia l’‘autenticità’ dell’innovazione ma l’ecologia del riuso, nulla è d’occasione, l’affresco dei Poeti del Novecento è anche istituzionalmente una proposta meditata di tre quarti del secolo breve, essendo uscito nel 1977 come parte dell’enciclopedica Letteratura Italiana Laterza, curata da Muscetta. Una proposta, quella di Santarone, quasi provocatoria oggi che il discorso politico affida se stesso ai tecnici della comunicazione e ai sondaggisti, mentre la ricerca accademica, in particolare quella umanistica, deprivata di risorse economiche e di ricambio intellettuale, è costretta a mendicare riconoscimenti da un ipercapitalismo finanziario che nei suoi algoritmi brucia in una frazione di secondo interi popoli e natura. E purtroppo suona conferma il fatto che, il pur pregevole saggio introduttivo alla riedizione Donzelli di Pier Vincenzo Mengaldo, sia un lavoro uscito nel 1979.
Santarone, nel concludere la sua ampia postfazione, La poesia ago del mondo: il Novecento di Fortini, annota documentatamente che “I poeti del Novecento sono il punto d’arrivo di una lunga frequentazione della poesia italiana del Novecento” (p.281). In effetti uno dei pregi di questo lavoro è proprio la sua funzione sistematrice, che permette al critico di presentare in modo organico e articolato sia le sue ricognizioni – sulle quali Mengaldo analiticamente si sofferma, in gran parte condividendo, qua e là togliendo o aggiungendo -, sia l’impianto teorico complessivo.
“Ciò che anzitutto colpisce […] è il fermo rifiuto di privilegiare «linee» o tendenze su altre, e sulla autonoma consistenza degli individui. I poeti, e non La poesia, del Novecento è certo un titolo non casuale” (p.VII), afferma Mengaldo. A mio parere, della distinzione dei due piani indicati è notevole quella che sottolinea la incommensurabilità tra il valore della singola opera poetica e la linea di appartenenza.
Come è consuetudine nella saggistica fortiniana, anche in questa, che pure per dovere di genere si presenta piana e didattica, il discorso connette dialetticamente e talvolta contraddittoriamente ordini differenti. L’argomentazione più ampia e, per dir così, in primo piano, è la composizione e la descrizione delle diverse linee che cronologicamente strutturano il periodo storico considerato: dall’età giolittiana, alla prima metà degli anni Settanta. Agisce qui l’acuta attenzione fortiniana ai mutamenti storici, al diverso disporsi, scomparire, emergere di tensioni culturali, sociali, politiche. È quell’ossessione, com’egli la definisce, quell’allarme del presente che segna l’intera sua opera e soprattutto la saggistica. Ecco allora i grandi quadri: L’età espressionista; Da Ungaretti agli ermetici; Montale e la poesia dell’esistenzialismo storico; Le avanguardie e il presente. Quadri che tuttavia si articolano non poco e spesso cronologicamente si sovrappongono, come Fortini si premura d’indicare analiticamente nelle due pagine finali della sua Premesse alla poesia del nostro secolo: linee di sviluppo e problemi di periodizzazioni. In questo terreno, che gramscianamente potremmo chiamare di organizzazione della cultura e degli intellettuali, Fortini ricorre a strumenti culturali, sociali, ideologici, linguistici per delineare forme della cultura e dei gruppi intellettuali in relazione al contesto storico complessivo. I giudizi valutativi del critico non mirano a stabilire gerarchie (non si crede in una linea “di tendenza”), bensì a mostrare le diversità delle risposte alla situazione storica: “le vere differenze, che segnano il passaggio da un’epoca a un’altra, provengono dalla torsione, tanto più tenace quanto più indiretta, che la realtà socio-storica imprime alle istituzioni della cultura e quindi della letteratura e della lirica” (p.257).
Entro, anzi oltre tale sistemazione emergono i ritratti e i relativi giudizi di valore dei singoli poeti, nel senso che, per esempio, quanto detto a proposito dell’“età espressionista”, non diventa, non dico il metro, ma neppure lo strumento per valutare il valore di un Rebora o di un Campana. Il fatto è – e qui tocchiamo un punto nevralgico della concezione fortiniana – che per l’autore l’agire storico umano del poeta, dell’artista, per non dire del critico appartiene a un campo del tutto separato, rispetto a quello in cui vive e si organizza l’opera poetica e artistica. Non si discute qui dell’ovvia distinzione tra dire e fare, intenzione e realizzazione, si tratta del fatto che l’opera d’arte, sulla scorta delle ricognizioni dell’idealismo tedesco, è una totalità organica: il giudizio di valore nasce dalla compiutezza di questa. Da qui è la ragione, sebbene non esplicitata, della incongruenza tra i due piani. Si deve aggiungere che i giudizi di valore pronunciati – sempre vivi, talvolta straordinari, come quelli su Ungaretti – non si soffermano anche – purtroppo, direi - sul piacere del testo, ma sulla risposta al mondo storico, così come generalmente sottointendono, senza esporla al lettore, l’analisi delle figure e del linguaggio che quel valore sorreggono, cosicché talvolta ne sortono condanne fulminanti nella loro assertività: Trilussa “godé larga fama per la sua favolistica; si tratta di una equivoca agilità nell’uso del romanesco, al servizio di un moralismo senza coraggio, con qualche convenzionale sberleffo ai potenti” (p.126).
Lutero
Conosco da parecchi anni Claudia Angeletti, la sua impazienza santa nella ricerca della Verità. Mi consegna la traduzione di sua mano di un testo del riformatore, da lei stessa prefata, chiedendomene un parere.
“Soltanto lo Spirito intende le Scritture rettamente e secondo Dio” dice il teologo e Angeletti sintetizza “la Scrittura è infatti sui ipsius interpres”. Non dovrei meravigliarmi, dato l’impeto mistico dell’autore, eppure avverto un urto che mi chiede ragione.
Mi dispongo a osservare quanto la studiosa apparecchia, con cura perspicace: la messa in scena del testo e del suo lettore. Presto m’imbatto in un nuovo inciampo: l’acribia del teologo, intento a stabilire l’esatto significato delle espressioni sul potere dell’apostolo Pietro, collaziona testi di autori diversi come fossero della stessa mano. Inciampo profano il mio, mi rendo conto, perché se i vangeli e le altre scritture sono parole di Dio, agli uomini che le hanno pronunciate rimane la funzione di strumento che le rende udibili, il segmento in cui l’eterno s’incide nella storia. La scrittura è parola di Dio, anche e prima di tutto nella lettera.
Mi fermo, penso allo scontro che oltre i libri, prima e dopo di essi, durissimo sfidò poteri assai terreni, arse corpi, sbudellò membra. Come s’innestava, lì, la parola? Da dove nasceva il significato, di quelli e di questa? La risposta non è ovvia.
Teniamoci, in prima istanza, entro le coordinate fissate dal teologo. L’eternità attribuita al testo – il singolare è dovuto all’essere puro fainomenon la pluralità concreta –, su cui l’interprete si affatica e per il quale combatte, facilita il nostro compito, perché restringe la discrezione propria della storicità al solo versante del ricevente. Da dove origina, dunque, il differenziarsi e anzi il conflitto delle letture, ossia del loro significato asserito? Certamente in parte è dovuto alla semplice malafede, ovvero all’uso strumentale e distorto del testo per fini di potere: a ciò sono riferibili quelle determinazioni delle scritture che il wurttemburghese designa come espressioni dell’Anticristo. La parte rimanente, forse la maggiore, è frutto di semplice incomprensione, per ignoranza o debolezza di lettura. “Il movimento umanista – osserva riassuntivamente Angeletti - stava portando avanti la battaglia culturale di una revisione globale della Weltanschauung medievale, basata spesso su presupposti testuali errati, o su testi falsificati ad hoc, proponendo e adottando metodologie filologiche d’indagine dei documenti”. Errori soggettivi cui, si asserisce, la scienza filologica e, si aggiunga, la dedizione ermeneutica sono sufficienti a far fronte. Il fatto vistoso – comune, per la verità, a ogni azione ermeneutica che pensi la propria battaglia solo nei termini del recupero del senso autentico – per il quale la polemica del teologo assume la forma di una veemente rincorsa a ritroso, tesa a scrostare la roccia delle false interpretazioni, aspetto che in termini politici diremmo restauratore se non reazionario, è in realtà figlio legittimo dell’assunto di partenza, per il quale la temporalità pertiene esclusivamente alla lettura. Dico “temporalità” ed è da intendere sia la fallacia che il peccato.
Guardando più in profondità in questo gesto radicale di resa del lettore, c’imbattiamo in un resto che lo slancio eroico di annullamento mistico del sé (“Soltanto lo Spirito intende le Scritture rettamente e secondo Dio”) non arriva a cancellare: “della Scrittura l’essenziale”, il suo insegnamento, è “quello che esperimento nella mia coscienza, il senso di sicurezza, di salvezza che provo affidandomi alla sua opera redentrice”. La storicità, cacciata dalla porta come fonte del male, torna nelle vesti di vita e anzi di prova del bene, ossia dell’autenticità della lettura. Si apre qui tutta la tematica sul posto da assegnare alla storia e sullo statuto di illuminazione soggettiva della lettura autentica, tale da impedirne semplicemente l’insegnamento, nonché la spiegazione.
Nel sanguinoso conflitto delle interpretazioni, il fuoco della ricerca di senso autentico, volto alla purezza di un testo “sui ipsius interpres”, deve concedere un residuo che contraddittoriamente è sia il male, l’inadeguatezza ineliminabile - trovandosi la purezza assoluta della scrittura a incidere nella temporalità - sia il bene, la finalità stessa del senso che la scrittura destina. Tale natura contraddittoria del senso è figlia diretta dell’assunto fondamentale che colloca il testo fuori del tempo e il lettore nella temporalità. Ciò sia assegna, paradossalmente, l’origine – se non la genesi – e la vita del senso solo dal lato del lettore, sia getta la storia nel male, nell’insignificanza.
Se noi invece riguadagniamo il testo alla sua storicità originaria e genetica, ci mettiamo nella condizione di recuperare le connessioni sia prassiche che semantico-referenziali che hanno fecondato il codice linguistico, le quali propriamente costituiscono il senso vivo cercato, prodotto dall’autore. Reciprocamente, è la realtà storica, sociale e psicologica del lettore a fecondare un'altra volta il testo, producendo nuovo senso. È precisamente per questo che, tra l’altro, ogni aspirazione al recupero originario, la quale è in realtà aspirazione all’annullamento della storia, si mostra illusoria. Solo per il dogmatico si dà una sola interpretazione per sempre. Quindi se è vero che la filologia serve a scartare “i presupposti testuali errati” e le falsificazioni, lo può proprio in quanto è storicizzazione, né essa si lascia pensare come scientificità scissa dall’interpretazione, fatto che sarebbe una palese contradictio in objecto. Ben sapendo che interpretazione non è arbitrarietà.
Solo guardando all’atto linguistico come costitutiva produzione di senso, possiamo scorgerne due aspetti coessenziali: la comunicazione, pur escludendone l’uso strumentale e falsificante, in quanto gesto della realtà storico sociale di chi parla o scrive, è sempre espressione del suo potere individuale e sociale; ogni ascolto o lettura è a sua volta esercizio di un potere sociale e individuale. Che la diversa produzione di senso nei conflitti luterani sia stata letteralmente questione di vita o di morte nasce da qui, non dal preteso statuto di Verità del testo in discussione, elemento che semmai contribuisce a offuscare lo sguardo e a tranquillizzare gl’ipocriti; se la controversia fosse sorta da una laicissima legge dello stato, non avrebbe condotto rischi diversi. È nella genesi stessa dell’interpretazione, ovvero della produzione di senso che germina la questione di vita o di morte, nel caso che i poteri coinvolti siano tali da averne l’autorità. Per questo esatto motivo le “le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti”.
25 febbraio 2019
Politéia
Càpita, nel condurre l’adolescente alla lettura, di scontrarsi in un incaglio. Non parlo dell’ostinazione alla non lettura, fatto non infrequente però superato dalla forza intrinseca all’istituzione in cui il processo avviene. Dico invece dell’afasia sul sé, dura come la rimozione, di fronte a quanto è stato letto. Lo impegni in un diario di lettura e ti ritrovi con un resoconto succinto della fabula o poco più. Ti sforzi in esempi, raccomandi apertura d’animo e di mente, per poi ricevere pagine più estese di dettagli gelidi come referti anatomici: la scena interiore rimane una notte deserta. Non vale qui alcun dovere, né alcun consiglio, scorgi che la radice è al di là della tua azione.
“Interpretare”, forse da “pretium”, quindi “valore”, ma certamente da “inter” che indica appunto la messa in relazione. Nel caso in questione il rapporto è tra un testo immutabile e, per dir così, eterno, in cui il posto dell’autore con il suo alito vitale è rimasto vuoto, per questo ogni testo chiuso è non diverso dai cadaveri; ma diversamente da questi la carne, il sangue e la ragione del lettore – se ha avuto il coraggio di portarli con sé - danno ogni volta ad esso la sua carne e la sua ragione, rianimando al contempo la scena dell’autore e del suo tempo.
C’è un motivo se la riflessione ermeneutica in Occidente prende avvio dalla pratica dei testi religiosi e poi dalle leggi. È palese la condivisione da parte di un testo religioso e di un testo giuridico di due elementi costitutivi: entrambi hanno carattere fisso e universale; entrambi sono prescrittivi, pretendendo la conseguenzialità pratica del loro lettore. Così l’uomo di fede, come quello soggetto alla legge, è posto di fronte a un rischio di cui egli è responsabile e insieme – fardello ben più pesante – egli solo è giudice. Se il testo con cui fa i conti si pretende universale, l’interprete è costretto – pena la demenza della comprensione e la follia dell’azione – restituirne la storicità, per distinguere il loglio della contingenza dei tempi, dal grano di ciò che è da ritenere ancor valido.
La discriminazione sul testo non può letteralmente compiersi, se l’interprete non si sottrae alla condizione di determinatezza vuota, disincarnata cui l’esibita universalità del testo lo sospinge, se non guarda cioè la propria rugosità sociale e temporale. L’interpretazione è insomma movimento doppio, per il quale il soggetto, mentre costruisce ogni volta la storicità di ciò che gli sta di fronte togliendogli la pretesa di essere una volta per tutte, determina se stesso nella propria storicità, che è poi tanto una scommessa sulla verità propria quanto avvio della sua realizzazione.
Il motivo per il quale anche l’opera d’arte si trova alla prese con il processo ermeneutico è propriamente nella sua intrinseca natura illocutoria. “Sii come me” è il messaggio, tacito perché ovvio, direttamente discendente dal patto che da sempre vincola opera d’arte e fruitore. L’uomo di fede, l’uomo soggetto alla legge e l’uomo che gode di un’opera d’arte sono determinazioni diverse di una medesima funzione sociale.
“Sii come me” non è una metafora, né un comando da prendere alla leggera, in quanto costituisce la ragione profonda, l’energia ultima che lega e muove i due soggetti: quello a monte a comporre il testo, quello a valle a cercarlo e a fruirlo. Forse dovrebbe dirsi “chiamata”, perché all’ingiunzione del pater unisce la commozione dell’animo, che convince ad abbassare le difese, a dare vita all’opera, a svellerla dalla sua fissità e a portarla dentro di noi. Io sono della generazione formatasi sulle note teatrali di Brecht per un teatro epico, contro quello catartico. Oggi capisco meglio le sue buone ragioni, perché comprendo che la sua non era, come mi appariva, la negazione dell’identificazione, ma un’identificazione di secondo grado. Era, diciamo meglio, l’esposizione didattica e in un campo particolare di un processo fondativo generale: non si dà, in senso stretto, comprensione se non ci si abbandona all’opera, se non si diventa l’opera; d’altra parte, non si è in grado di parlare, di riprendere la nostra voce se a un certo punto non si mette alla porta l’opera. In mancanza di questo passaggio, essa ci si para davanti nella sua eternità, Medusa che pietrifica chiunque la guardi. Le figure allora possibili sono non il critico, ma l’erudito, non il cittadino ma l’idiota o l’aguzzino, non il timorato ma il fariseo o l’integralista.
Tale rapporto duale, generato dallo strappo dalla determinazione storico-sociale, non prende solo la forma della desertificazione del soggetto, ma si manifesta anche nell’opposta cancellazione dell’oggetto. In questo caso all’afasia subentra un’esuberanza critica pseudocreativa che riempie il fantasma dell’opera. È questo il campo della libertà paranoica. Ridotte l’opera d’arte, la legge, la religione a fantasma del sé, il soggetto istituisce se stesso a mondo e insieme a suo legislatore, indossando, di volta in volta, i panni del rivoltoso sacrificale, dell’urlatore egotico, o del sadico.
Come sempre accade nei fatti storico-sociali umani, certi fenomeni specifici – qui la relazione tra un prodotto chiuso nella sua fissità e il fruitore preso nella dinamis della propria vita - hanno una più ampia validità generale, nel caso di cui si tratta la comune relazione tra gli uomini. Per esempio, è dalla necessità di storicizzazione propria del processo interpretativo che prende senso il salutare caveat all’ascolto, “chi ci parla?”. Vero inizio della comprensione di quanto ci viene detto. Certi studi recenti di fisiologia umana sembrano asserire la relazione tra autismo e assenza o difettività dei neuroni a specchio: la forma estrema di assenza di relazione troverebbe la sua eziologia nell’impossibilità funzionale a mettersi nei panni dell’altro. L’evidenza patologica confermerebbe dunque la fondatezza antropologica delle caratteristiche e della dinamica della relazione interpretativa.
Rientrando al di qua dell’estremo patologico, che come tale si colloca ai margini ultimi, se non esterni, della socialità storica, oggi misuriamo le vaste desertificazioni del tessuto sociale che spingono l’individuo alle molteplici espressioni delle due intransitività relazionali. Si pensi alle solitudini impotenti che presto si fanno rassegnato silenzio, oppure esplodono in astio gridato o freddamente agito fino al sangue proprio e altrui. Si pensi alle domande senza risposta che in breve si tramutano in asserzioni dell’identico. Non raramente, le socialità si costruiscono in recinti nei quali i componenti, mentre credono di parlare a tutti, si convincono della verità per il fatto che risuonano della medesima asserzione. Capisci allora che la difficoltà del tuo adolescente nell’interpretazione non origina da un difetto personale – caratteriale o culturale – sebbene ne assuma la veste, comprendi cioè che tale possibilità è prima di tutto una relazione sociale, dalla quale il tuo potere di docente è, costituzionalmente, in gran parte escluso.
27 dicembre 2018
Avendone chiesta l'autorizzazione, pubblico qui la riflessione inviatami in forma di lettera da Lucio Niccolai che, in dialogo con il mio Dove sei?, ne prosegue e ne approfondisce il ragionamento. Ho espunto i passi più personali. v.a. 21 dicembre 2018
Caro Velio,
è stata una settimana faticosa, e solo ora riesco a risponderti […] La prima reazione è stata quella disarmante di trovare le parole giuste, perché la tua riflessione solleva problemi di vario tipo e necessiterebbe di ben più tempo e attenzione di quanto di norma io non possa mettere nelle mie cose, sempre sopraffatto da impegni e carichi di lavoro che divengono (specie quelli burocratici) sempre più insopportabili e invidio la tua costanza di studio e scrittura che a me in questo omento manca (il riferimento iniziale all’ascetismo di Cassola è autobiografico o una meta da raggiungere?). Dirò per prima cosa che la tua è una bellissima riflessione, scritta molto bene, bella da leggere e rileggere. E mi fa piacere che l’incontro di Montemerano, il dover riprendere in mano un lavoro vecchio di 20 anni, ti abbia stimolato una riflessione così profonda e significativa. E, d’altra parte, come hai accennato anche nella conversazione montemeranese, inevitabilmente il riflettere sui 20 anni passati, non poteva non implicare un ragionamento – forse anche liberatorio – sul percorso compiuto, le sconfitte subite o forse più e meglio le amarezze vissute, su quel te stesso “Quand’era in parte altr’uom” da quello che sei oggi. Ma l’occasione – e questo mi sembra il significato più importante del tuo testo – ha stimolato una analisi più ampia, su un cambiamento sociale, culturale e politico che probabilmente ha ancora bisogno di strumenti di lettura, di conoscenza e di analisi. In fin dei conti, guardiamo indietro e, come l’angelo della storia di Benjamin, non vediamo che macerie. La stupenda contingenza – una classe operaia forte, organizzata, protagonista - che vissero Vittorini, Cassola, Bianciardi è rovinata nel tempo, eppure forse il male era già al suo interno, in quel Partito, nella sua strategia, nella sua prospettiva riformista e rinunciataria destinata alla sconfitta. O anche, giustamente, come noti, nel rapido franare di quelle certezze che venivano dall’Oriente (e che Gramsci aveva già avvertito e denunciato). Nella incapacità di un gruppo dirigente come quello italiano di misurarsi con la lezione gramsciana, ridotta ad uso e consumo della tattica delle alleanze. E Gramsci è stato, forse, in Italia, l’unico che davvero si sia misurato con una analisi della complessità, che abbia utilizzato il metodo marxista per la comprensione della società italiana e delle sue dinamiche interne. E poi sono vere tutte le altre cose che dici: le trasformazioni oggettive; la chiusura delle fabbriche e delle miniere; la globalizzazione; la politica ridotta a interessi di ceto e di funzionari, grigi e stupidi; l’incapacità di cogliere il nuovo e farne tesoro (guarda ancora oggi, cosa pensano e scrivono sul Sessantotto quelli che furono del PCI e che hanno votato per Renzi e contro la Costituzione). Certamente sarebbe utile una rilettura del passato, la ricerca della comprensione degli eventi, il loro maturare e trasformarsi, la disfatta e la sconfitta epocale che hanno prodotto e che ha coinvolto singolarmente anche noi. E il presente? Lo subiamo. Nella cultura, nei posti di lavoro, nella vita quotidiana; la prospettiva è ancora più spaventosa che nel passato (e tu noti giustamente il dominio assoluto, sordo, insensibile e ignobile della borghesia globale). Ed è significativo che la più grande forza della ex sinistra non abbia né un briciolo di analisi della società attuale e delle sue dinamiche interne ed esterne, né un interlocutore sociale, né una prospettiva che non sia quella della difesa del proprio ruolo di ceto professionale.
Da questo punto di vista anche le nostre vicende personali […] si inquadrano in una dinamica grottesca: ciò che rimaneva dell’apparato, ha operato – non solo in Maremma, a Grosseto o a Santa Fiora – per chiudere ogni luogo di dialogo, di democrazia culturale, di espressione non del dissenso, ma della ricerca critica, e quindi i centri culturali, le riviste, le associazioni (che cosa è oggi l’Arci?) e ogni altra cosa che non fosse omologata alla loro smania di dominio, cancellando ogni senso di appartenenza, e spianando la strada al renzismo e, finalmente, al ”populismo” leghista che ormai dilaga in tutta Europa. Le destre hanno generalmente completato (e stanno completando) l’opera avviata da quel ceto di burocrati ottusi e ignoranti (guarda a Grosseto la posizione del Sindaco nei confronti di Fondazione cultura). Ma non c’è autocritica o ripensamento, come dimostra anche la lettura del Sessantotto che ci viene proposta dagli ex del PCI (e che per me è uno spartiacque, come lo è stato il Referendum sulla Costituzione: c’è tutta una parte della ex sinistra con cui non è più possibile nessun tipo di confronto e di dialogo, anche perché manca ormai il referente naturale: la classe operaia, o se vuoi, più in generale, un soggetto sociale multiplo. E di nuovo manca una analisi della realtà, un’indagine storica, una comprensione degli eventi, che evidentemente non interessa più a nessuno, mentre il revisionismo storico imperversa. E forse, se non avessimo avuto quel libro di Biancardi e Cassola, non sapremmo niente neanche sui minatori. Così come non sappiamo niente dei contadini e della Riforma agraria. Cioè sappiamo molto di storia istituzionale, ma poco delle lotte contadine prima, della proposta del PCI della cooperazione agricola (sul modello sovietico, che qualcuno ancora fantastica come un’utopia mancata), delle trasformazioni sociali e culturali dell’appoderamento, che non hanno trovato cantori come Cassola e Bianciardi. Un pezzo di storia che sembra ormai completamente rimosso.
Caro Velio, ancora tanto ci sarebbe da dire, riprendere da capo il tuo Dove sei? e ricominciare. Il tuo scritto merita considerazioni più profonde e attente, una scrittura più agile e raffinata che non le mie parole storte e disadorne. Ma sicuramente lo leggerò di nuovo e continuerò a ragionarci, pur nella consapevolezza di questa sorta di impotenza a cui la situazione sembra costringerci, nel senso che poi riflessioni come le tue avrebbero bisogno di strumenti concreti per diventare qualcosa di più che semplici parole, ma sempre più rari sono gli interlocutori, i destinatari, coloro anche, semplicemente, in grado ancora (te ne accorgerai anche tu quotidianamente a scuola) di fare proprio un pensiero critico o di esercitare un diritto di critica.
Grazie ancora per il tuo scritto, Lucio Niccolai
Dove sei?
Nel respiro inavvertito dei giorni c’è un fascino forte e sfuggente tanto che pochi, come Carlo Cassola nelle sue pagine migliori, sanno raggiungere l’ascetismo capace di dirlo. Bellezza e intossicazione svelate dalle intermittenze d’un fatto o di una notizia. “Conosci questo? - mi scrive un amico inviandomi la notizia di una pubblicazione - mi ricorda il tuo romanzo Domani”. Mi è sconosciuto il libro e il suo autore.
Alla conferenza cui ero stato chiamato per un mio lavoro di vent’anni fa, con il quale provavo a ricostruire vicende avvenute nel secondo dopoguerra, ho creduto di leggere qualche parola di un intellettuale che certo non si è mai mascherato con i panni del popolo, perché, proprio per questo, con più vivezza rappresenta il sussulto di un’Italia e di un ambito sociale, politico, culturale. «Ricordo una sera, verso piazzale Corvetto, una specie di hangar mal illuminato, pieno di operai, di donne con i bambini sulle ginocchia; e ascoltavano parlare del “Politecnico” come di una cosa loro, come se si trattasse del loro lavoro e della loro salute, e interrogavano, volevano sapere. (Si arrivò a proporre una tournée di tutta la redazione attraverso l’Italia meridionale e la Sicilia). Capitavano in redazione i personaggi di quegli anni: operai affamati, giornalisti, avventurieri, ex partigiani, ragazze scappate di casa, mentecatti […] Si aveva l’impressione che, dovunque il settimanale giungesse – ce lo confermava la fitta corrispondenza dei lettori – molti animi che erano stati scossi dalla recente esperienza rispondessero alle nostre incerte astruse parole. Era per noi la conferma della scoperta che avevamo fatta durante la guerra; quella delle incredibili possibilità della nostra provincia, delle energie latenti nelle classi mute».
Il mio studio sul breve torno d’anni non si soffermava tanto su quel ribollire scomposto di energie, corpi, speranze sfrontate, rabbiosa voglia di futuro, difficili oggi non dico a credere, ma a comprendere; piuttosto la mia ricerca aveva seguito il rilievo, misurato la forte consistenza di un blocco sociale che da quel vortice improvviso era sedimentato, dandogli un orizzonte di senso capace di additare un futuro, di permettere la possibile verità del presente e del passato, di pensare il vivere comune non come flusso informe, bensì come un ordine plausibile della dislocazione sociale e del sé in esso. Non sto qui a dire – né allora lo dicevo – se quello specifico orizzonte di senso fosse vero o ingannevole; ciò che poi è accaduto ne indica anzi gli errori, per quanto ancora ignorati o addirittura contraffatti. Notevole è invece il riscontro in esso della circolazione verticale e orizzontale della parola intesa come dialogo: scambio e scontro. A guardar meglio, quando si trovi il coraggio di liberarsi dal “già saputo”, ci si accorge come quella circolazione non sia frutto di un convergere ignoto e miracoloso di mille fiori, ma opera di un lavoro complesso, di lunga durata, per il quale le più forti “energie latenti” prendono forma, radicandosi e combinandosi in una trama diffusa e viva di associazioni, sindacati, partiti, ramificazione che ha reso udibile la voce pronunciata, senza che essa si disperdesse nel vuoto del rumore, come atomi di elio nell’atmosfera. Un’ossatura che ha fatto diventare l’energia voce, la voce sangue e respiro, schiudendo al domani uno spiraglio diverso dal puro colpo di dadi. È questo che, nel brevissimo tempo in cui la voce dei senza voce è durata, ha reso possibile, in un’area marginale, il fertile sodalizio di Bianciardi e Cassola, fruttando l’inchiesta comune dei Minatori della Maremma e gettando il seme della futura narrativa bianciardiana.
Lo conosci?, insiste il giovane amico inviandomi la foto della copertina. Esito, guardo, allargo l’immagine, scruto la mia mente, ma anche la memoria visiva si ostina muta.
Quand’era in parte altr’uom da quel ch’i sono. L’epifania impietosa del ventennio rivelato dal “finito di stampare” è troppo brusca perché, in apertura di conferenza, non tenti la complicità del gioco dotto. Epperò la domanda non può essere elusa. Da dove nasceva quel ripensamento dopo cinquant’anni, per chi e con chi quell’altro che io ero voleva riappropriarsi del futuro? Non era lo stesso blocco sociale da cui Bianciardi e Cassola erano nutriti e che essi avevano alimentato. Come sempre, la risposta al caso particolare, al delimitato luogo geografico raggiunge la verità concreta solo per una strada che appariva estranea. Non era lo stesso blocco sociale, non solo perché il capitale che per più d’un secolo aveva chiamato da tutta Italia un esercito di minatori li aveva licenziati da decenni, lasciando dietro di sé rovine di gallerie e d’inquinamento, mentre altri gruppi di classi subalterne non erano riusciti a raggiungere la stessa forza e la medesima compattezza, ma soprattutto perché in tutto il territorio nazionale come nelle fabbriche francesi, nelle miniere britanniche, nelle officine statunitensi, nelle comuni cinesi e prima ancora nelle miniere e nei campi argentini la secolare spinta all’emancipazione arrivata a sbocciare nel secondo decennio postbellico, aveva iniziato nel terzo un arretramento vasto e inarrestabile, che lasciava campo – vediamo oggi – all’impeto forse più distruttivo che l’umanità abbia mai conosciuto: quello dell’attuale iperborghesia finanziaria internazionale. Come in altri Paesi europei, nel nostro, dove pure la forza politica che più di altre aveva saputo comprendere la spinta delle “energie latenti”, nutrendosene e alimentandole, era stata la più forte in un paese capitalista, le organizzazioni politiche delle classi subalterne erano state tradite dalla presunzione della propria forza. Smarrita la differenza tra il presente e il futuro, avevano respinto da sé con fastidioso sprezzo proprio la fioritura più alta della stagione postbellica, bollandola di ribellismo piccoloborghese, così riducendo se stesse ad articolazione dello stato liberale e il proprio personale a ceto sociale. In questo modo, dopo che il processo di smantellamento aveva già rovinosamente proceduto prima nelle fabbriche, poi nelle più ampie diramazioni sociali, dopo che il retroterra orientale da cui, agl’inizi del Novecento, era sembrato prender il balzo, era ceduto sotto il peso dei propri errori e della competizione con l’avversario, nel nostro Paese il partito delle classi subalterne credette di rimediare alla propria difficoltà abbandonando il nome, sciogliendo i ranghi e cercando altre forze. Drappelli di reduci fino ad allora tenuti ai margini e oramai portavoce di se stessi risposero alla chiamata.
È precisamente in questo paesaggio che anche nello sperduto distretto che era stato dei minatori della Maremma un minuscolo gruppetto di volenterosi formatisi in altra stagione e in diversi percorsi poté diventare interlocutore credibile, grazie ad alcuni che, dall’interno delle forze di sinistra, presero sul serio la linea della nuova apertura. Da quell’incontro fortunato, dalle energie che seppe far convergere, dalle speranze che esso alimentò nacque appunto il mio studio di allora, con molti altri lavori. I fatti hanno poi mostrato che si trattava del convergere di un doppio equivoco. Chi agiva dall’interno delle forze di sinistra aveva interpretato l’apertura come un cambio verso sinistra; i volenterosi immaginavano che il loro interlocutore politico fosse il medesimo della stagione dei minatori. Comune alle due parti l’errore di guardare ai nomi invece che alla cosa, alle idee, invece che ai fatti, agl’interessi di ceto invece che al conflitto sociale di classe: tutto era oramai accaduto. Così, quando le speranze cominciarono a confrontarsi con i fatti, quando la natura effettiva di quella che era stata creduta generica apertura chiese il conto, bastò un battito di ciglia a spazzare via tutto. Ed è pianamente istruttivo della cogenza delle relazioni sociali sull’agire individuale il fatto che i demolitori furono proprio gli stessi che fino al giorno prima sorreggevano e favorivano.
Guardo ancora la foto della copertina: un fondo bianco con intrecci radi di foglie, come di esilissime canne. “Sono poesie ma la materia viva, scrive con competenza l’amico, è quella del tuo romanzo”. Però solo il nome della casa editrice mi dice qualcosa.
Foglie, appunto, in questo terzo tempo. I bollettini sulle repliche beffarde e smisurate ai ciechi proclami grotteschi ma orrendi dei portavoce che ci comandano, gli allarmi intermittenti, per quanto autorevoli, scivolano senz’eco nel quotidiano urlio di egotismi, pubblicità, pettegolezzi, onanismi. Una lunga epoca si è conclusa, seppellita da una meccanica al momento inarrestabile: da una parte un capitale condotto dalla sua vittoria al compimento della propria follia, per la quale erge se stesso a unica ragione e diritto sotto cui tutto, e terra e acqua e aria e vita e sogni è materia inerte per il proprio profitto; dall’altro un pianeta offeso, consumato dei suoi equilibri che con brevi fiati sommerge uomini, animali, piante, profila, con accelerazione visibile, i continenti.
La mattina, nelle ore ancora brune, scruto l’oriente. Torno a mia scienza, confido che il genere umano sempre cerca ciò di cui ha bisogno, so che è degli ultimi, dei senza voce la forza lavica delle ere e infine la voce, la quale ogni volta si leva imprevedibile e nuova.
Nei vuoti, scrivo irte paginette private. Godo del privilegio di parlare alla scuoletta, mescolo, con arte del tutto inabile, briciole di pane, molecole arsenicate, particole di lievito, tracce di lima.
6 dicembre 2018
La recensione che segue è apparsa sull'Immaginazione di Lecce, n.308 (novembre-dicembre 2018). v.a. 25 novembre 2018
Quando le notizie che ci raggiungono servono solo a rassicurare
la nostra presuntuosa ignoranza
Per T. Di Francesco - M. Biani, La balenottera Mar
Quando le notizie che ci raggiungono servono solo a rassicurare la nostra presuntuasa ignoranza e le voci che si levano da mille tastiere e strumenti ‘personalizzati’ sanno solo gridare l’odio chiuso, il bercio vuoto di chi non sa più o non ha mai saputo dare un nome alla distruzione pianificata di quanto in lui è di umano, senti tutta la fatica della parola che chiede perché vuole ascoltare, che nomina perché vuole conoscere, che comunica perché la mano vuole cancellare il mondo della sopraffazione. L’arte allestisce una scena, anzi conduce a un’esperienza che, entro i confini del suo ‘come se’, può permettersi e permettere l’avvicinamento a una parola di verità. Quella di Tommaso Di Francesco, d’indiscutibile valore, si è mossa lungo due strade. Una, maggioritaria, ha perlustrato i salti, le slabbrature, i vuoti del vivere quotidiano, divaricato tra la cronaca dolorosa che filtra nel suo mestiere di giornalista ‘dalla parte del torto’ – è attualmente codirettore del “Manifesto”, da lunghi anni responsabile della pagina esteri - e gli affetti privati, le incombenze; perlustrazione severa e ardua quanto infaticata a segnalare ora la necessità, ora la nostalgia di un orizzonte di senso. L’altra si è invece nutrita dell’impeto breve, arguto o graffiante dell’epigramma, dove prevale l’impazienza morale, l’irriverenza del raziocinio, l’energia del riscatto.
Sorprende, dunque, l’ultima pubblicazione di Tommaso Di Francesco, illustrata da Mauro Biani. Non mi riferisco alla collaborazione con un disegnatore, perché chi conosca il poeta sa del suo amore bibliofilo, la sua attenzione per l’oggetto libro; né mi riferisco al ricorso alla prosa. La sorpresa è proprio nel registro. Tommaso Di Francesco ha questa volta scelto lo sguardo basso del mondo infantile, il tono confidente della fiaba, ha scommesso con il lettore sulla forza del lieto fine. Le tavole di Mauro Biani concorrono in modo perfettamente armonico al medesimo fine. Di quest’ultimo vediamo ogni giorno, sulla prima pagina del “Manifesto”, come l’eleganza del segno, i rinvii colti della sua iconografia spiazzino con una critica immanente gli orrori quotidiani che è costretto a registrare. Nelle diciassette tavole qui presenti, invece, domina il piacere sorridente degli azzurri. La cupezza, che pure segna, a distanza, la favola è da Biani lasciata riaffiorare dal serbatoio della memoria tramite la tenerissima iconografia del corpicino adagiato sulla spiaggia.
“Com’è come non è, Mar a un certo punto scoprì che era rimasta sola”. La favola inizia in medias res, per poi compiere qualche passo indietro. L’incipit e la vicenda si rifanno ai moduli tradizionali della fiaba, ma sia lo sviluppo che la levità del tono non hanno nulla della crudezza che così sovente caratterizza il genere. La balenottera tratta esplicitamente il tema della devastazione ambientale provocata delle piattaforme nelle ricerche petrolifere, eppure la forza allegorica spinge oltre la lettera e le pagine stesse, addita – come Biani ha intuito – altri strazi, altri morti, direttamente umani che “il piccolo oceano” quotidianamente inghiotte: anche di questi, ci chiede conto.
La consueta lingua aspra, prima di tutto con se stessa della poesia di Di Francesco, si fa confidente, fraterna: “le balene e i balenotteri sanno distinguere le mille musiche che là sotto vibrano. Le chele dei granchi che sbattono, lo sciamare dei banchi di pesci che fanno un fruscio come di frusta (dovreste sentirlo), la ninna nanna delle maree, la nenia del plancton sempre in culla”.
A segnare ipotetici capitoli della storia sono adibiti cinque quartine, prima di ottonari a rima baciata, poi più liberamente strutturati: ‘cori’ di distinti “trabocchi” (Teo, Leo, Meo, Ne, Ma appellata al femminile: Trabocca), termine che nella costa abruzzese-molisana designa una struttura fissa da pesca.
Il testo è aperto e chiuso da due soglie, che assumono la veste di note autoriali. Se la prima, sin da suo incipit (“Questa favola di mare si ispira a un fatto drammatico di cronaca: nell’autunno del 2014 sette balenotteri che avevano perso l’orientamento spiaggiarono tutti assieme sulla costa di Punta Penna, in Abruzzo”) si dispone su di un piano neutramente documentale, nella seconda l’autore ricorre all’artificio della pseudodocumentazione: “n.b. La multinazionale del petrolio si è ben guardata dal raccontare alla stampa che per tre giorni la sua nave-sonda è stata assediata nell’autunno del 2014, in Adriatico, da centinaia di balene infuriate, ma possiamo confermare che l’episodio è accaduto davvero. Deve essere accaduto. Quanto al bambino migrante salvatosi a cavallo di una balenottera, nessun giornalista vi potrà mai raccontare questa storia. Ma, credeteci, il bambino che si è messo in salvo a cavallo di Mar è l’autore di questa favola”.
Il testo che segue è apparso sulla rivista on line "Odissea" di Angelo Gaccione (v.a. 14 settembre 2018)
e sul sito "Officina dei Saperi" (v.a.26 febbraio 2019)
Grosseto. Italia
Ho conosciuto Grosseto dalla campagna, ultima tappa di un avvicinamento partito dalla montagna, passato alla collina e infine arrivato alla pianura. A Grosseto non ci sono nato. Ma chi davvero ci è nato? Alla proclamazione dell’unità d’Italia contava quattromila abitanti, solo nel dopo guerra ha conosciuto un balzo del quarantacinque per cento rispetto al precedente censimento del 1936, raggiungendo i trentottomila. Oggi ne ha ottantamila. Luciano Bianciardi notava divertito che le possenti mura medicee di Grosseto, dell’ultimo Cinquecento, sono forse l’unico esempio di mura a difesa della campagna.
Ma i numeri nudi non parlano. Grosseto è il contado della repubblica di Siena, dunque, come in tutti i comuni e poi i ducati italiani, terra di esproprio: economico e umano. I Paschi messi a garanzia dei risparmi raccolti dalla “più antica banca del mondo” sono appunto i pascoli della Maremma, mentre lavori di scavo storico hanno messo in luce come la Repubblica senese inviasse periodicamente suoi funzionari nel contado a invogliare, all’occorrenza costringere i giovani più promettenti ad andare a impolpare i ranghi di governo. Col tempo questa terra ha coltivato il proprio disprezzo.
Nei primi anni Cinquanta Bianciardi e Cassola costruirono il piccolo mito della Grosseto “aperta ai venti e ai forestieri”, di un’infaticabile Kansas City in perenne costruzione, dell’anticonformismo degli operai che si comprano a rate la Lambretta per andare al mare, dei camionisti delle Quattro strade. Solo che l’ironia della disillusione descritta da Bianciardi nel Lavoro culturale sbagliava bersaglio: non la degenerazione burocratica del Pci era stata la causa del fallimento, bensì il fatto, ben più grave, che quel momentaneo fervore era l’effetto ottico di un’onda lunga altrove già in risacca. Nel grossetano si trovava uno dei più importanti distretti minerari d’Europa (pirite, carbon fossile, mercurio), con una classe operaia dura e combattiva, tanto che persino Lenin fece cenno alle sue lotte. Ma quella forza, che la Resistenza prima e la nascita dell’Italia repubblicana poi sembravano finalmente far fiorire, aveva già raggiunto il suo apice, come la sostanziale sconfitta dell’eroico sciopero dei cinque mesi del 1951 mostrò e lo scoppio della miniera del 1954 con i suoi quarantatré morti sancì. Il settore, come dicono gli economisti, era diventato obsoleto. Quanto alla campagna, mentre il resto della Toscana, quella ricca, abbandonava la mezzadria per l’industrializzazione e insieme per la nascita di una media proprietà contadina, nel grossetano la rinascita del dopoguerra è stato l’esodo dai paesi verso i minuscoli poderi della legge Stralcio di riforma fondiaria, che dietro lauti compensi smembrava il latifondo autoctono e soprattutto fiorentino.
Per questo in Maremma non c’è stata l’effervescenza della piccola e media industria. Da noi la campagna è campagna. Non vedi l’urbanizzazione diffusa dei capannoni e dei blocchi di prefabbricato delle mille attività manifatturiere. A un certo punto, dopo la crisi dei primi Settanta, quella ‘arretratezza’ divenne una risorsa. È nato il territorio del Parco regionale della Maremma e degli agriturismi. Ma il ‘nuovo’ non è stata la trasformazione del millenario fondo contadino. Questo si è piegato, forse pensando di usarla facendola propria, alla visione feriale, vacanziera che ne ha la propria clientela. La città ha continuato ad essere priva di luoghi di propulsione culturale. Iniziative qua e là nascono, resistono una stagione, poi s’insecchiscono. Non dimentichiamo di disprezzarci. Grosseto è stata la prima in Toscana ad essere conquistata dai berlusconiani, oggi Casa Pound lancia le sue campagne dalla sala consiliare, mentre in questi giorni ha avuto qui il suo raduno nazionale.
I migliori non cessano di emigrare, lo scadente e spesso cialtronesco personale politico, amministrativo e professionale si dedica a coltivare la rendita della sua subalternità. Da qualche tempo i campi della collina e della pianura vanno assumendo il profilo ordinato della campagna senese o chiantigiana. Anche i nomi e i capitali sono gli stessi.
Ricevo da Maria Vittoria De Filippis questo commento che accolgo volentieri. v.a. 3 aprile 2018
Maria Vittoria De Filippis
La Croazia di Velio Abati
Da tempo leggo quello che l’amico Velio viene scrivendo ora in versi, ora in prosa e ogni volta vengo sorpresa dalla lingua, dall’andatura, dai paesaggi. Se si confrontano due scritti di Velio, anche se quasi coevi, si nota come la scrittura sia diversa, dissimile come dissimili sono i soggetti. È una caratteristica molto particolare: una lingua moderna ma anche antica, per uno stile insolito. Ma l’“inattualità” che possiamo incontrare nella scrittura parte, a mio avviso, da uno sguardo sul reale che non è, come si dice, di moda. Ed è così anche per l’ultimo scritto al ritorno dalla Croazia.
Il narrante è presente con discrezione, sembra camminare in punta di piedi. Il racconto è uno schizzo a matita, un disegno leggero, delicato, triste, melanconico. Come sempre, è uno scritto politico nella sostanza. L’attenzione e la tensione politica sono tanto più forti quanto meno l’argomento trattato è direttamente politico. Qui emerge con forza allorché si è in presenza dell’altro. L’altro in cui ci si rispecchia è un altro noi. Non vi è un argomentare filosofico, ma intravediamo un lungo percorso, una fedeltà politica al riconoscimento dell’altro, del diverso. In altri tempi si difendevano le “Altre Ragioni” con orgoglio, ora si deve essere grati a Velio per allontanarci dal frastuono odierno, dalle chiacchere moralistiche. E torno volentieri sulla chiusa del breve racconto: “Esco all’aperto, respiro. Contemplo ancora, in alto, la matassa irta dei sette nidi, il turchino limpido del cielo.” Lo sguardo è lì, sul presente, un’annotazione triste ed una di limpidezza, poi lo zoom della mente va oltre, si è nella lontana e ravvicinata terra australe. “- Chissà, se sono già nell’Africa del sud?” E di nuovo lo sguardo poggia lì, per terra.
Ĉigoĉ
Malgrado vi fossimo passati davanti, abbiamo faticato un po’, ricevute le indicazioni, a scorgere la tavola imporrita che portava scritto, con caratteri incerti, l’insegna. Tanti decenni prima, giù in mezzo al Mediterraneo, in tutt’altra lingua, ci eravamo trovati a inventare una tecnica gemella. Io scaldavo un punteruolo di ferro, poi mia sorella anneriva le lettere che sfrigolavano nella tavola lucida. Oltrepassato il piccolo cancello aperto, ci siamo guardati indecisi. La corte, il breve stradello erboso, la casa in legno propria di quella regione profonda del Paese, il silenzio tranquillo ci hanno fermati. Sul lato opposto, nell’angolo assolato del mattino due o tre galline e il gallo sorvegliatico, nero come il carbone, razzolavano tranquille. Da un’altra casa poco distante, abbaiava non visto un cane. Eppure nel cartello una parola si lasciava riconoscere. Se tornati indietro, non avremmo saputo dove altro cercare.
Comparve una vecchia, alta, pallida, camminava con qualche inciampo, ma senza bastoni. Non manifestò sorpresa, così M. le mostrò, come ci era stato indicato, i biglietti d’ingresso. Il gesto a mezz’aria del pollice e dell’indice che accompagnava qualche parola incomprensibile, ci rese chiaro lo sprezzo. S’incamminò davanti a noi. Voltato il cantone, apparve l’entrata alla casetta. Alla sua sinistra, facendo angolo si allungava perpendicolarmente una breve fila di tre portoni in ferro, che segnava il margine orientale della corte. Ci guardava senza sorridere. Dopo qualche difficoltà, comprendemmo che voleva spiegarci il suo passo incerto: digiabetes.
Di colpo, muovendomi per le strade del mondo, mi capita di scoprirmi a osservare con meraviglia che il volto, le movenze, il corpo di fronte, per il gioco imperscrutabile dei numeri, si trova a percorrere proprio il mio cammino nella sequela delle generazioni. La persona è qui, al mio fianco, vede i miei stessi fatti della terra, forse anch’essa si sofferma a volte a guardare i comuni rami trascorsi, eppure di quello sguardo, che per un attimo incrocio, non so, non saprò nulla. I brevissimi istanti del mio incontro casuale è tutto ciò che ho e avrò di lei. È lo stesso sgomento che mi assale quando vedo i poveri corpi abbandonati sotto i portoni o nei marciapiedi. Una minuscola manciata di decenni addietro eravamo il medesimo bambino, allattato dallo stesso seno. Quale abisso di circostanze, di eventi voluti dagli uomini sono intervenuti a scaraventarci in distanze oramai così incolmabili? Che cosa sono, per lui, quelle stesse pianure e stagioni, la durata medesima della vita, quegli stessi fatti umani che chiamiamo società e che io credo di sapere?
La vecchia avanza alcuni passi e in mezzo alla corte, ci mostra orgogliosa uno, due, tre, sette nidi di cicogne sopra tetti e pali che contornano lo spiazzo. Fa un gesto con le mani aperte. Sono vuoti, perché da poco partite per l’Africa australe, ci ha detto l’uomo dei biglietti. Le galline non si turbano. Si avvicina al primo portone che apre con qualche fatica. Da questo e dall’altro appaiono accatastati decine e decine di attrezzi agricoli grandi e minuscoli, ammassati in terra, appesi a colonne, pendenti dal tetto. Si sofferma su qualcuno, additandolo. Molti li conosco, qualcuno l’ho persino usato nella mia infanzia, a mille e mille chilometri di distanza. Lo descrivo a M. La vecchia mi guarda orgogliosa, sicura delle sue parole-frase in cui qua e là riconosciamo dei suoni, o crediamo di farlo. S’infervora nei gesti dimostrativi. Ma è soprattutto nel terzo portone accanto la casetta, custodia del povero arredo di cucina, delle tre foto del padre e del nonno in divisa militare, del quaderno minutamente scritto dal primo, che comprendiamo come tutto, lì, sia il museo di sé. Ci mostra una sedia e un tavolo di legno minuscoli per bambini. Ci spiega, a segni, che proprio per questo non sono assemblati con chiodi, ma solo con la tecnica dell’incastro. Scova, da un mucchio di oggetti vecchi, una lavagnetta. Ha le dimensioni di un moderno tablet: šcola. Ci viene in mente la latina schola, dove i ragazzi si portavano le proprie tabulae.
Potrei tentare di addentrarmi di un passo, prendere quell’astuccio di legno con il cassettino scorrevole per la penna e i pennini che, ci giurerei, odora di grembiuli, d’inchiostro, di raffreddori della mia infanzia, o girare ancora la grande ruota del trinciaforaggi, lo stesso che a zio Davide bambino fece saltare mezza falange, subito agguantata dalla gallina ghiotta di grilli. Guardo la vecchia, il suo fervore paziente ha rotto ogni cautela, la voce oramai ci è incomprensibile, ogni nostro sforzo è sopraffatto.
Lei ora è qui, forse con suo marito vive di pensione. Da ultimo c’introduce nella casetta, ci ferma nella prima stanza. Esposti, sotto la protezione semplice di un cellophane mondo da qualunque granello di polvere, un vestito da cerimonia, e, in ordinata successione, le coperte nuziali della nonna, della madre, la sua, tutte tessute al telaio, come il proprio capolavoro dev’essere. Il telaio è ancora lì, in mezzo alla stanza. Si siede, ci mostra, con due o tre passate, il funzionamento. M. si rammenta della nonna e degli zii di montagna. Non sappiamo come siano le brevi stanze oltre la soglia. E, prima della loro raccolta, di chi era quella pur povera congerie di attrezzi? Se il nonno ha combattuto per l’impero centrale, per chi lo ha fatto il padre? Vedo tutta la fatica della vecchia, l’ansia amorosa che forse per anni l’ha spinta alla raccolta, nella convinzione opposta di Mazzarò: non è la roba a essersi mangiata la vita, ma è la vita - la sua vita – a diventar carne con gli oggetti, dov’essa trova il proprio senso, si perpetua negli occhi e nell’animo degli altri che arrivano e che verranno.
Anche se sapessi, non oserei dirle l’illusione, la mia impotenza. Quegli strumenti, prima della loro postura cimiteriale, attraverso quali relazioni umane davano pane? In che misura, con quali quozienti tra le fatiche? Chi erano, in nome di quale futuro parlavano i maestri che dettavano alle lavagnette? Quali poste di gioiosi riconoscimenti inseguivano le prove dei capolavori? Le invidie di chi, volevano suscitare?
Rimiro la fiamma breve della sua nostalgia, oramai impigliato nel mutismo delle mie domande. Vorrei sentire da lei quanto profondo è stato il mutamento vissuto nel pieno della sua consapevolezza, qual è l’eco nel suo animo, che cosa non ha più della relazione con gli altri e con gli strumenti del vivere che la occupavano nella cura quotidiana; che cosa ha invece raggiunto, dopo la non remota, feroce trincea del sangue, che una stampa, tra poche cianfrusaglie di turistico amor loci, ritualizza ai nostri occhi. Mi chiedo chi siano i vincitori, chi gli sconfitti alle spalle di quei generali che piegano o sono piegati alla firma della resa. Misuro tutto il peso del frastorno dei tempi. Vorrei sapere se davvero ognuno di noi due, allora, guardava all’altro come il proprio futuro. E, ora, quale futuro ci sveglia, entrambi, al mattino?
Credo, per maggiore esperienza, di conoscere più di lei la verità di ciò che forse essa ha voluto guadagnare. Ma non è vero. C’è un grumo, un impasto di slanci luminosi e di orrore, nella parte migliore della sua vita, nell’evocazione di quegli oggetti che sono e non sono i miei, essi covano un dolore che non abbiamo ancora avuto il coraggio di riconoscere nostro. Per questo non so ora parlare alla vecchia, né sapere più il nostro mondo, nominarne gli strazi.
Esco all’aperto, respiro. Contemplo ancora, in alto, la matassa irta dei sette nidi, il turchino limpido del cielo.
- Chissà, se sono già nell’Africa del sud?
Le galline beccano tranquille, intorno al crocchiolìo del gallo diffidente.
29 agosto 2018
Cene
a W.
C’è bisogno di decenni, a volte, per vedere la tenacia dei legami stretti nei luoghi di potere; almeno nel nostro tempo, quando tutto ha un prezzo, la merce trabocca negli scaffali e da ogni angolo dell’esperienza quotidiana ti si proclama che la vita è nelle tue mani. Sospetto una continuità – non dico di sangue, ma di meccanica sociale, nel territorio italiano – tra i circoli famigliari evidenti nella struttura capitalistica moderna e quelli, insieme ristretti e diffusi, della borghesia comunale, i gruppi di eruditi seicenteschi, fino ai salotti illuministi. Non sorprende che originariamente fossero di clan, vista la loro recente origine feudale; degna invece di studio è la resilienza di siffatto automatismo fino ai nostri giorni, tanto che allo storico suggerisce per analogia la lettura delle ere umane trascorse e della loro attuale forza nelle forme del paesaggio agrario intorno a noi.
Che con l’invito sorridente “nel mio giardino viene l’autore tale per un incontro” mi si dica molto di più di quanto s’intende comunicarmi, l’ho capito quando a mille chilometri di distanza ho trovato una condizione identica. Due gli elementi in esso compresenti come il recto e il verso: la natura strettamente privata, di famiglia persino e quella elitaria. Non si chiamano, forse, cenacoli? Certamente le circostanze danno allo stesso elemento significati differenti. Se i palazzi di signoria erano palesemente anche di governo, le accademie riserve signorili di eruditi, i salotti erano élite insofferenti di un potere oscurantista e parassitario, dunque protesi a farsi governo. Che cosa sono oggi gl’inviti a casa propria?
Miei giovani amici spesso non prendono per spostarsi le ferrovie dello stato, ma passaggi in auto di privati sconosciuti che si trovano a percorrere il tratto di strada interessato. Non è la gentilezza fortuita della mia generazione, ma contratto formale, per quanto privato, con prezzi convenuti. Ugualmente, con certi programmi elettronici, altri fanno diventare la propria modesta pratica culinaria un invito a ignoti paganti. Di sicuro, nella casistica facilmente ampliabile vediamo l’opera dell’imperiosa lusinga che da ultimo anche la scuola pubblica somministra ai bambini, insieme con le prime parole scritte: sii imprenditore di te stesso.
Un conoscente dal profondo Nord mi confida d’aver principiato ad aprire il proprio appartamentino in riparazione di un incontro con cinque persone organizzato da lui in libreria: “in casa furono esaurite le stanze”. Gli ambienti pubblici, quando non siano straniti spazi di consumo, sono desertificati non-luoghi.
Un amico si accalora nel raccontarmi come l’idea di aprire la propria casa sia stata la reazione alla cacciata subita dal potere pubblico, perché chi comandava non sopportava più che quanto si produceva non fosse direttamente utile al suo potere personale.
Se il senso del tuo esistere è fare della tua vita il guadagno, nessuna tua azione e nessun luogo in cui tu ti trovi possono, in forza del principio borghese di proprietà, prevedere anche l’altro, essere con-divisione, essere, in senso proprio, pubblici e comuni. L’eccedenza del principio di piacere, che pur preme oltre la prestazione, può essere inclusa dalla legge ferrea del profitto tutt’al più nella gratuità del sadismo, dell’aggressione persecutoria, che certo non esclude l’autoaggressione. D’altra parte una così tragica radicalizzazione del principio proprietario borghese, per il quale un bene, e in questo caso se stessi, esclude in assoluto qualsiasi altro che non sia il suo possessore, apre una ferita tanto immedicabile quanto invisibile nell’individuo che sente, senza più saperlo, che nessuno può nascere e vivere solo per se stesso. È precisamente dall’abisso di tale muraglia cinese, e culturale e pratica, che pullulano i risarcimenti maniaci dell’identificazione acclamatoria con il superindividuo-noi, della costruzione fantasmatica di io-popolo: sinuose ripugnanze la cui gratificazione narcisistica legittima e potenzia le più gelide crudeltà o borghesemente delegate ad altri – le Autorità, gli Stati – o plebeisticamente agite in proprio: i razzismi, i massacri.
È dunque avvertibile, nell’odierno spuntare dei cenacoli, la ricerca di un argine, il bisogno d’aria, un’aspirazione agli dei del mattino. Eppure la loro oppositività, fattuale se non cercata, non è la volontà illuminista di abbandonare la propria natura privata per farsi pubblici. Un’ulteriore scaturigine li precede, che ora ne nutre la freschezza antagonistica, ora ambiguamente rafforza la loro sottomissione al delirio. Negl’imponenti rivolgimenti dell’antropocene delineatosi a partire dal secolo scorso è riemersa dalle profondità dei secoli l’affermarsi dell’individualità come insegna liberatoria dei subalterni. Non appropriazione signorile, arma d’esclusione e sfruttamento, in obbedienza alla legge del più forte, ma avveramento di una promessa antica secondo la quale il libero sviluppo di ciascun individuo è possibile solo nel libero sviluppo di tutti, ovvero in un salto di paradigma che metta a nudo e tolga la falsa individualità dei pochi, la loro fraudolenta libertà, proprio come ingannatrici risultano le attuali e antiche divisioni tra pubblico e privato. La voce subalterna che forse con più energia ha segnato la coscienza umana, che meglio ha saputo difendere gli spazi conquistati è stata quella femminile. Io sono mia non è l’ennesimo gesto di enclosures che le classi dei padroni ripetono nei millenni, ma un assalto alla bastiglia nelle innumeri cellule della vita quotidiana; il privato è pubblico non è lo sguardo bigotto sui vizi domestici per oscurare i misfatti pubblici, ma la messa a nudo della voluta incomponibilità tra utile e bene, il disvelamento dell’alienazione, il bisogno insopprimibile di uno sviluppo integrale dell’essere umano.
La devastazione che da oltre trent’anni sloga continenti, inabissa coscienze e vite umane ricorda, a chi se ne fosse dimenticato, che nessun’isola è data sulla terra, tuttavia chi, o il quanto di ciascuno è buttato da parte sa sempre portare con sé, anche senza saperlo, la parola di verità che altri, oramai morti hanno saputo additare. Da tempo stilo la mia lista d’inviti.
20 luglio 2018
Per Luisa Gastaldo, Della tua voce
Ho letto con emozione, raccolto nel silenzio mattutino, Della tua voce. Il monologo ininterrotto, che la scansione delle pagine mostra di ritagliare dal rumore quotidiano della vita e dalle necessità pratiche, conduce il lettore in una zona fonda dell’esistenza. Lì, in quel terreno primigenio della vita umana, dove hai avuto la forza di giungere e di schiuderne la porta, ci rapisce l’intensità con cui, nella mutilazione immedicabile dell’assenza, tu, donna, fai vivere il tremore fecondo della tua relazione con l’altro. Il monologo prende le forme dell’evocazione, non però segnato dalla pietas; diviene bensì tessuto di un sé capace di donarsi nella relazione senza riserve o timori, in serena reciprocità, resa più densa dalla ferita della perdita. Così, senza apparire, doni al tuo lettore la consapevolezza che la relazione con l’altro è una questione di vita o di morte e insieme il desiderio – che si spera non ipocrita - di relazioni autentiche, dunque la spinta a renderle reali.
17 luglio 2018
Raffaela
Sebbene fossi molto attento alle persone e ai loro volti, non la notai. Era per me un tempo denso; non so, non l’ho accertato, se è stato accidentale, dovuto al carattere o alle circostanze, oppure un comune fatto anagrafico. Mentre i miei gesti e talvolta le mie parole si adattavano alle necessità del momento, la mia mente si appostava a scrutare, assetata dei gesti, delle movenze, dei volti di chi mi si muoveva intorno, meglio se non si rivolgesse a me. Soprattutto, certo, delle ragazze. Vagavo poi a lungo, dietro quelle immagini rubate, nei vuoti del giorno e della notte. Conservo, da qualche parte, quaderni interi, minutamente rigati: ritratti brevi, di sguardi, di voci, di gazzarre. Era, credo, la fame del mondo, il pulsare del marzo.
Eppure Raffaela la notai appena. Magrolina, pareva cresciuta all’improvviso, come il fistuco del tarassaco prima di fiorire, dopo che l’erba è stata tagliata. Portava i capelli corti, con una zazzerina, forse a coprire in parte una fronte che credo ritenesse troppo alta, due occhi rotondi, chiari. Si muoveva sempre, nel gruppo delle ragazze, si sentiva a distanza con la sua voce stridula e scherzosa. Ma, ripeto, io a quel tempo credo di non averci mai parlato. Forse mi ero soffermato su quel nome, che appare familiare epperò dissonante, come uno sbrego, oppure, all’opposto, un ornamento esotico. Ma a quel tempo non avevo ancora imparato la pazienza dei nomi.
Spinto poi, dalle vicende che seguirono, a conoscere di più sulla sua condizione, seppi ch’era la prima di cinque sorelle. Probabilmente il padre, avventizio in un paesino dell’entroterra, dopo la prima, aveva cercato con ostinazione il maschio, fino a che per la forza della natura o per rassegnazione non si fermò. Più che un paesino, erano quattro case dietro una macchia, che tuttavia avevano la fortuna di essere in fila lungo una strada che vedeva regolarmente la corriera andare la mattina alla città, per poi tornarsene indietro nel primo pomeriggio. Non c’era bisogno di discorsi per capire che qualcosa, anzi, tutto doveva essere fatto per dare alle figlie una possibilità migliore di cercare un’opera da questo o da quello: bastava la memoria fattasi carne e stenti di generazioni perse nella notte dei tempi. Era occorso invece un salto recente, origine stessa della modernità, che Raffaela, più tardi, poté con sicurezza nominare, perché il capo di casa delle sei donne sperasse di far salire una dopo l’altra le figlie sulla corriera per tentare non il lavoro, ma la scuola. Uno scarto che, contro ogni odierna parola e azione, è irreversibile, come l’invenzione della ruota. Non parlo qui dell’erudizione. Intendo la scoperta che la conoscenza può, deve diventare un’arma di chi sta in basso e non solo essere, come sempre, strumento di dominio. Impugna il libro non è fantasia di poeta, se i reclusi hanno rischiato la tortura e la vita, se la cronaca del mattino racconta dei bulldozer notturni contro “la scuola di gomme”, dentro la quale i bambini non cessano di cantare.
Raffaela, prima della famiglia e delle quattro case, prese tutti i giorni quella corriera, mattina e pomeriggio, per cinque anni. Certo non sarebbero stati sufficienti a consentirlo – come i fatti avevano in precedenza provato e torneranno poi a ribadirlo – né l’insopprimibile speranza di migliorare, né l’intuita necessità dello studio, se non fosse intervenuto lo spiraglio materiale e morale che seguì alle devastazioni più grandi del secolo. Raffaela rispose con grande energia, alla consapevolezza di avere sulle spalle il rischio gravissimo del fallimento, perché triplo: di figlia, di maggiore, di donna. Fu in quella strettoia dura che maturò la sua educazione sentimentale. L’incontro con le compagne, ogni mattino, era una festosa conquista. E mi dispiace oggi, tra i tanti possibili a suo tempo da me mancati, non averla cercata, per capire dalla sua diretta voce come in quel tempo cruciale affinò la tenacia, allenò la resistenza e la dedizione, coltivò, per il dovere dell’esempio, l’esercizio del comando. Una dopo l’altra, tutt’e quattro le sorelle presero la corriera, per cinque anni.
Arrivarono poi, splendidi, i fertili temporali di marzo, imprevisti ai più, per quanto l’aria elettrica e impaziente andasse raccogliendosi e gonfiando nell’incrinarsi degl’inverni. L’acqua che si riversò copiosa sollecitò e fecondò campi assai distanti, s’insinuò nei terreni più martoriati dalle gelide stagioni trascorse, svegliò quelli impigriti dalla breve luce invernale e i ruscelli, i rigagnoli aprirono nuove strade, s’allontanarono in orizzonti inesplorati, come se mai venisse meno in loro la certezza del grande fiume, che sentivano vicino, trionfante. Così, con la medesima fugacità con cui un giorno m’era apparsa, persi di vista Raffaela, per non so quanto tempo. Ma non mi mancarono notizie su di lei. Fu quello un periodo di giorni febbrili, faticosi anche, ma non distratti, non ottusi. Non erano affatto giorni senza più confini tra dentro e fuori, buio e giorno, veglia e sonno, non giorni senza cesure, boccate d’aria, perché ti è tolta la possibilità, la forza di pensare; né di te, né degli altri. Le notizie circolavano, vedevi oltre il tuo sguardo. Di Raffaela sapevo. Frequentava un giro di amicizie che come noi preparavano i giorni, impegnavano la vita seri e irridenti, agguantavano avidi e gratuiti nuove esistenze, perché innamorati – ci pareva per sempre - del senso e del bene; un senso e un bene che, per quanto risultassero al momento negletti oppure irrisi, sfregiati in quanto rapina e dominio di pochi - alimento di un mondo di vittime o di carnefici - fossero invece di tutti, per tutti: comuni. Proprio perché, in quella breve stagione, robuste minoranze furono le Raffaele che irruppero nelle stanze vecchissime, accuratamente protette, la richiesta più avvertita non fu solo di leggere e scrivere libri, ma ci si scontrò su quali libri, quali maestri, quali stanze. La furia fu tale che in alcuni casi si arrivò a teorizzare e a praticare la permanente distruzione delle stanze e dei maestri. Il fatto è che risultava intollerabile e immorale ogni separazione tra dire e fare, tra mano destra e mano sinistra, tra mezzi e fini, tra utile e bene. Feroce fu l’ironia contro chi con solerzia grottesca teneva ordinate le stanze del proprio lavoro e companatico, riservando al dopolavoro il tempo della critica e della politica. Per questo, nello stesso periodo, riprese vigore con asprezza nuova il rifiuto delle donne di ogni paratia tra casa e lavoro, pubblico e privato. Si potrà dire che vi fu un eccesso di euforia, che troppo si premette sull’immediatezza; la sconfitta sta lì a mostrarlo. Ma, proprio perché nessuna vittoria è definitiva, mai lo scacco può annullare la verità che a una generazione sia capitato di additare. Di Raffaela sapevo dunque che, con spensierata severità, v’investiva tutta l’energia fervida dell’età e quella immemore della sua gente.
Ora non so dove Raffaela viva. Non voglio saperlo. Dimitte mortuos sepelire mortuos suos. Eppure, spina malvoluta, torna, imprevista, fastidiosa.
La ritrovai sorpreso dopo un periodo, che non saprei più misurare, di autentico silenzio. Aveva qualche capello bianco, la voce, divenuta profonda, la riconoscevi nelle intermittenti increspature di testa. Era seduta con noi a un tavolo di responsabilità. L’incontro fu festoso, come tra chi si conosce da anni. Interveniva poco, attendendo il suo turno, misurava le parole assennate. Notai che occupava uno spazio minimo del tavolo, in un gesto di composta modestia o di superbia rattenuta. I gomiti non riposavano sul ripiano, ma le braccia parallele, strette a sé, poggiavano sullo spigolo muovendosi sospese sul foglio davanti. Il busto stesso non si lasciava sulla spalliera, la testa leggermente piegata sul mento. Ma fu un passaggio fugace, in cui si bruciarono – anche se non potevamo saperlo - gli ultimi scampoli della primavera e già ben altro si preparava alla terra.
Così quando poi nel terzo tempo rividi Raffaela, ci salutammo con quella riservatezza che i giorni dolorosi portano nelle conoscenze. Ella veniva da non so quale percorso, io vi ero approdato prima di lei, trascinandomi non pochi ammacchi, ancora non del tutto ammutolito, certo non rassegnato. Cominciava a chiarirsi che ogni singola legnata non era momentanea. Prendeva forma la rovina. Quei luoghi dove erano nate coscienze, confronti fervidi, scontri autentici e appassionati vennero investiti da ventate gelide le quali a rese individuali, rassegnate stanchezze, reviviscenza del farsi i fatti propri assommavano la forza delle idee dominanti, la sottrazione dall’alto del potere di decidere e perfino il ricatto della razione di pane a ogni mancata adesione fattiva, pur rimanendo – beffa somma e strazio – i nomi perfettamente immutati. Ogni volta ne vengo via distrutto. Mi chiudo veloce nel bagno e mi sforzo a lungo, inutilmente, di vomitare.
Raffaela cominciò a proporsi, volenterosa, per qualche piccolo compito. Non era sola. Con lei si erano fatti avanti alcuni tra quelli che in altri tempi le nostre convinzioni avevano allenato al valore comune del nostro compito, soprattutto per i più deboli, alla moralità dell’ascolto. Guardai con comprensione, per quanto non convinto, perché intimamente persuaso della forza delle ossature che perimetrano il nostro vivere, della necessità, dunque, di una lunga guerriglia interna, di una distanza via via ragionata: ogni vero lo è nella storia. Non so che successe a quel tempo. Semplicemente mi trovai che tra tutti, in forza di comandi oramai privi di qualche argine, si era distinto un piccolo gruppo di zelanti, sempre più agguerrito nelle maglie tecniche, sempre più indispensabile, sempre meno avvicinabile. Passava, questo gruppo, ore interminabili del giorno e della notte ad addentrarsi nelle raffinatezze dei moduli, a impossessarsi di esotismi, a destreggiarsi tra sottili tassonomie. In esso primeggiava Raffaela. Non c’era impegno in cui non fosse indispensabile, la sua voce si levava autorevole, fino a che i luoghi un tempo anche nostri divennero deserti. Se qualche voce provava a obbiettare o a dire altro, era Raffaela a mettere a tacere. Nel frattempo, il nostro lavoro smarriva il senso, costretti a dar conto a domande in una lingua che nessuno aveva voluto o conosciuto, sempre più affannati a riempir carte e moduli e prontuari che precedevano, accompagnavano, seguivano il lavoro che sapevamo nostro. Non solo, il tempo stesso veniva ad arbitrio slabbrato, sottratto quando non di fatto deriso. Ma libero e d’importanza senza pari, si affermava solenni, era il nostro lavoro.
Bisogna essere realisti, disse sorridendo uno accanto a me, è già una frattura antropologica.
Sempre più spesso, da allora, m’imbatto lungo le mie strade negli uomini e nelle donne delle quattro case, sono legione. Così, appena posso, torno a quei muri. È un posticino illuminato bene, mi seggo sulla panchina e aspetto che qualcuno venga a interrogarmi. Scrutiamo il vento, il volo degli uccelli. Ragioniamo del mondo, perché non ci si scordi di domani.
L’ultima volta che sentii Raffaela, ripeteva la sua frase recente. “Non condivido affatto i comandi che ci arrivano, spero anch’io che cambino. Ma qui è nostro dovere applicarli. Nostro impegno morale è farlo il meglio possibile”.
10 luglio 2018
Quanto segue è il testo dell'intervento al convegno di Officina dei Saperi, Scuola. Aprire le porte. Creazione sociale e pedagogia del mercato. Per una scuola e una università inclusive, ecologiche e cooperative, Roma,16 marzo 2018. v.a.
Finanz-capitalismo e scolarizzazione di massa
1. Per una riflessione sulla scuola e sull’istruzione ritengo vantaggioso partire da fuori. Precisamente, dalla nominazione del particolare capitalismo in cui la nostra vita di uomini e donne è presa, dove dunque hanno origine e trovano significato le nostre azioni, i nostri pensieri, le nostre scelte e le nostre impotenze.
Per indicare la forma di capitale della nostra epoca comunemente chiamata neoliberista, ricorro alla definizione dataci, tra gli altri, da Luciano Gallino. Tale fase, come sappiamo, prende corpo dai primi anni Ottanta, con i due genitori putativi, Margaret Thatcher e Ronald Reagan.
2. Se io oggi sono qui a parlarvi, se in questi anni ho potuto parlare da una cattedra, se cioè è avvenuta la scolarizzazione di massa è perché un’altra epoca è esistita: quella del compromesso keynesiano, che nel settore di cui ora parliamo è andata dall’istituzione della Scuola media unificata del 1962 alla liberalizzazione dell’accesso all’università con la legge Codignola del 1969. “Liberalizzazione” 1969, “liberalizzazione” oggi: stessa parola, concetti opposti. Il significato delle parole, lo decide chi comanda.
Si avverte – assai giustamente – di non mitizzare, che l’ammonimento della Lettera a una professoressa di dare di più a chi ha di meno sta lì a ricordarci come quell’obbiettivo sia stato lontano dall’essere realizzato. Eppure oggi, nella nostra miseria, è utile richiamare quel passato recente per meglio comprendere i contorni e la profondità della distruzione in atto.
3. Potrei sbagliarmi – e in fondo me lo auguro –, ma credo che un futuro studioso che andasse a riguardarsi il dibattito culturale e politico che ha generato e accompagnato l’attuale profonda inversione di tendenza negli indirizzi dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a differenza del fervore politico e culturale della stagione riformatrice precedente, troverebbe solo chiacchiericcio.
Il fatto è che le ragioni che hanno determinato le controriforme – parola desueta –sono semplicemente estranee al loro oggetto, ossia istruzione, università e ricerca. Emblema grottesco ne è la coppia Gelmini – Tremonti, cioè la ministra di paglia e il ministro facente funzione, dei quali imperiture rimarranno le parole della prima, “chi ha detto che per migliorare l’istruzione bisogna investire di più”, e del secondo “con la cultura non si mangia”. Verrebbe da gridare aridateci la Falcucci.
4. Indicavo prima l’arco temporale ’62-’69. Ci sono qui storici che assai meglio di me hanno titolo a parlare di quella stagione arrivata fino a metà degli anni Settanta. Ricordo solo che in quell’epoca la riforma della scuola e dell’università si affiancò a conquiste fondamentali nel campo della previdenza, della sanità e in altri settori dello stato sociale. Voglio dire che l’emancipazione promossa dalla scolarità e dall’istruzione universitaria si è accompagnata alla crescita del potere del cittadino lavoratore, per dirlo con la Costituzione.
5. Al tornante del secolo, dopo che la globalizzazione neoliberista aveva riportato ordine destrutturando molecolarmente il precedente tessuto del lavoro e della vita quotidiana, si produce anche lo snodo del nuovo corso dell’istruzione – riforma Berlinguer – e dell’università – riforma Zecchino – di cui oggi, passaggio dopo passaggio, vediamo dispiegarsi gli effetti profondi. Al primo posto è ora il risparmio, la “razionalizzazione” - come si è usato dire - della macchina, ovvero il disinvestimento pubblico, non il cittadino e l’uomo in formazione per il quale la macchina è istituita.
Questa inversione logica, che sembra paradossalmente concordare con le tesi della deistituzionalizzazione anarchica di Ivan Illich, è coperta dalla motivazione ‘democratica’, anzi libertaria, di affrancare le energie, l’inventiva della società civile, delle iniziative locali, degli individui, contro il parassitismo, la pigrizia burocratica, l’oppressione centralistica. Ma chi, meglio della scuola monetarista di Chicago, aveva già con efficacia sintetizzato questi concetti e con uno sguardo generale? Il capitalismo è la libertà.
6. La storia, meglio le società umane hanno la loro viscosità, il loro attrito. E gli uomini, dopotutto, hanno un difetto: possono pensare. Così, se non si sono potute azzerare le istituzioni e le casematte di resistenza alla completa riduzione di tutto a merce, sedimentatesi nel corso di un paio di secoli e rafforzate nel periodo del compromesso keynesiano, si è passati alla tattica dell’aggiramento, della trasformazione interna, del riorientamento: è l’uso privato del pubblico.
Parlo qui della macchina dell’istituzione. Quando dico “uso privato” intendo riferirmi a tutti i suoi ambiti: del capitale che possa e voglia investirvi per il profitto; dei dirigenti che ne traggono poteri e vantaggi personali; degl’insegnanti spinti o attirati dall’idea di vendere meglio il proprio istituto contro i concorrenti, per non perdere il posto o per strappare qualche prebenda aggiuntiva; dei genitori che cercano e impongono il vantaggio per il proprio figlio contro quello del vicino. È vero, gli uomini possono pensare, ma questo è il campo delle loro mosse.
7. Se, com’è stato detto a metà degli anni Settanta dalla Commissione Trilaterale, le democrazie soffrivano di un “sovraccarico dei sistemi decisionali”, si è trattato di procedere a una semplificazione: meno persone decidono, meglio è. Mi correggo: più vitale è il sistema democratico. È stato questo ed è un processo lungo, che richiede di agire dall’alto – sui parlamenti, sulle leggi elettorali, ecc. – come, contemporaneamente, dal basso.
Basta dare un’occhiata alla cronologia, per capire che la scolarizzazione di massa, con l’esplodere dei movimenti studenteschi e operai, ha contribuito non poco al “sovraccarico” di domande di partecipazione: il fine per il quale la macchina istituzionale è creata, gli studenti, non è stato trascurato. Il rinvigorirsi della selezione di classe – altro che merito! – agisce sia con la buona vecchia esclusione ed espulsione dei più deboli, sia con il più sexy dirottamento in percorsi di serie B o C, dove B o C, nella scuola, non necessariamente significano istituti diversi, perché l’anima del commercio è la diversificazione del prodotto, l’individualizzazione dell’offerta.
8. Il passaggio progressivo dalla formazione all’addestramento è un ulteriore passo coerente con il medesimo scopo. Questa volta l’ideologia che l’accompagna ha per lo meno il pudore di non pretendere panni progressisti. È il naturale, buon senso economico: l’istruzione deve addestrare bene a un lavoro oggi possibile. Con la cultura non si mangia.
Dico “addestramento”, perché questo è il risultato del profondo smantellamento dell’orario dedicato all’insegnamento disciplinare, del tempo dell’apprendimento e della riflessione, dei modi e del tempo della relazione nel gruppo dei pari e con il docente. Dico “addestramento”, perché la valutazione delle “competenze”, per definizione sia decentra il sapere disciplinare, sia sposta l’accento dal sapere all’abilità pratica del fare. C’è una novità, tra le tante, che mi pare illuminante. Da quest’anno i ragazzi e le ragazze, ottenuta la licenza media, riceveranno questa documentazione: il voto complessivo dell’esame, la certificazione delle otto competenze chiave europee e il risultato dei test INVALSI, eseguiti ad Aprile, totalmente somministrati e corretti centralmente per via telematica, che vertono su Italiano, Matematica e Inglese. In altre parole, la valutazione della disciplina residua solo per le tre testate dall’INVALSI, quindi sottratte alla valutazione dei loro insegnanti e, quel ch’è più grave, agli elementi di giudizio relativi ai progressi, all’impegno, alla condizione di partenza che, com’è noto, costituiscono una parte fondamentale del lavoro didattico e della sua valutazione.
9. Basterebbe guardare lo sberleffo del paradosso che pretende di assegnare all’istruzione il compito di preparare al lavoro chiesto dal sistema economico esistente, quando il sistema economico esistente non chiede più lavoro, per capire che il re è nudo. Mi correggo. Il lavoro lo chiede: poco, malpagato, precario, con il cappello in mano, pronto alla chiamata, senza idee se non quelle utili al profitto.
Se ora qualcuno osserva che questo in fin dei conti è una enorme svalorizzazione del lavoro, che al contempo è lo smantellamento di interi campi del sapere, che la mostruosa massa finanziaria al comando del mondo, intenta a moltiplicarsi di bolla in bolla, del tutto disinteressata della vita di miliardi di persone e degli equilibri naturali della terra, alimenta giorno dopo giorno i rischi di disastri irreversibili, non sappiamo contraddirlo.
10. Il capitalismo, diceva un grande borghese che conosceva bene il proprio mondo, non si preoccupa del lungo periodo, perché nel medio saremo tutti morti.
Il futuro, dunque, è nelle nostre mani. Si tratta di allargare lo sguardo, compiendo una duplice, contraddittoria rottura: rompere le paratie del sapere, coltivare gli approfondimenti disciplinari. È tempo d’invertire la rotta.
Leggo La traversata del Gobi, di Stefano Carrai
Trovo la voce di un uomo del mio giorno. Chi scrive non dimentica che da qualche parte, ignota, germina la Siberia, o il Congo… In tenace sorveglianza, discreto, mi ricorda l’oblio tanto più ottuso di chi, per il companatico, si affatica sui ritratti, i cappelli, le note di ordinati testi e poeti.
Per questo, credo, la voce si affanna a segnalarli, come i cartelli stradali di Zanzotto, in cima alle pagine, mentre è occupata nelle necessità quotidiane, negli affetti, che il pungolo sotterraneo distanzia: viventi reliquie. Dalla sprezzatura gozzaniana, che il poeta evoca, non l’ironia viene, ma ritrosia per lo scavo ungarettiano, mascherato, alluso dall’ariosità della disposizione grafica, che è anche accenno di danza e canto di un’incerta catabasi. Senti, si raddensa, nel presentimento, in meditazioni severe.
“E si va per ossari”.
9 aprile 2018
Franamenti
“Siamo di fronte a una catastrofe della soggettività solidale”, mi scrive l’amico. Il giudizio non solamente è tanto vero da apparire semplice denotazione, ma ha un’altrettanto evidente valenza generale. Non è appunto di questo che ci parla per un verso la drammatica svalorizzazione del lavoro fino al ritorno alla schiavitù e alla corvée, per l’altro la desertificazione di ogni progetto politico anticapitalistico? Se dunque le cose stanno così, il “furto del tempo” che strozza il nostro giorno è l’esperienza immediata di quella che David Harvey chiamerebbe “egemonia ideologica”, il cui motore agente e agito è propriamente l’assoggettamento odierno (i rapporti e le forme dell’assoggettamento) del lavoro al finanz-capitalismo.
Penso però che nelle cause del franamento della soggettività collettiva vada annoverato anche altro, più ampio, attinente alle trasformazioni della mentalità, che hanno una loro complessità, insieme progressiva e regressiva. Mi sembra di vedere che la ‘rivoluzione culturale’ del Sessantotto ha dato qui uno scossone forse irrerversibile. La rivendicazione femminista – il personale è politico –, che ha fatto da catalizzatrice, ha abbattuto la vecchia distinzione tra gli obblighi pubblici e i piaceri privati, distinzione da ultimo borghese ma certamente, come ha additato il pensiero femminista, propria del plurimillenario habitus del dominio maschile. Sappiamo quanto essa sia stata e sia fonte di ipocrisie, sopraffazioni, espropriazioni e alienazioni. Ma io credo che al contempo essa sia stata la forma in cui si è storicamente determinata la condizione dell’agire in perdita. Intendo il sacrificio dell’agire in vista di un fine che ha un’alta o altissima probabilità di essere al di là della vita di chi agisce. È la situazione di Ettore sulle porte Scee, di fronte ad Astianatte e ad Andromaca supplice. Ma è anche l’eroismo del gracile gigante sardo, che dal buio definitivo del suo carcere scrive le pagine più straordinarie e lucide sulla storia nazionale italiana e sui compiti del proletariato. Non intendo dire che dal pensiero femminile sia escluso l’agire in vista di una meta che ci trascende, né che il partire dal sé precluda la diversa dimensione del noi. Credo invece che essi richiedano altre strade, altre mediazioni ancora in gran parte da esplorare.
“Catastrofe della soggettività solidale”. Me lo si scrive da un ambito sociale particolare: della cultura e dei saperi. Nell’Allarme del presente ho cercato di fornire qualche prova della scomparsa dell’intellettuale, sostituito in basso da una vasta area di lavoratori della conoscenza e in alto dalle elevatissime e ristrettissime specializzazioni tecniche: tutti – seppure in forme e con poteri assai diversi – ugualmente espropriati dello sguardo e dell’interesse generale, ossia politico. Non parlo qui della coscienza, né in senso marxiano, né in senso morale. Mi riferisco proprio alle catene e alle cecità determinate dalle concretissime divisioni sociali del lavoro. Dunque il ragionamento rinvia di necessità sia alle organizzazioni politiche, sia agli altri corpi intermedi che, in loro assenza, com’è della situazione odierna, rinforzano quella riduzione tecnica del ruolo culturale e impediscono la ripresa di una, sia pur diversa, funzione intellettuale.
Questa è la notte in cui ci è dato di lavorare, in gran parte – almeno per quanto mi concerne – senza sapere e quasi scommettendo su qualche verità che ci sembra d’intravedere. Anch’io, fin che posso, ripeto con le parole dell’amico di non appendere le scarpe al chiodo. Per questo sono ancora in cerca di nuovi compagni, contemporaneamente resistendo – da figlio di millenni contadini – all’entropia degli abbandoni di quanti della nostra parte abbiamo incontrato.
27 dicembre 2017
Il presente saggio è la rielaborazione della comunicazione orale tenuta ai Colloqui del Tonale dedicati al centenario fortiniano. v.a.
L’allarme del presente
Aforismi
Insieme con l’atto intimidatorio della sua assertività, l’aforisma porta con sé una straordinaria forza mnemonica, proverbiale appunto, che benissimo si presta a ciò che Fortini indicava essere necessario alla comunicazione sociale oppositiva e critica: il riuso. “Poca favilla gran fiamma seconda”[1]: la straordinaria energia della Divina commedia ne offre, si può dire, a ogni canto. D’altra parte, chi ha lavorato da addetto alla pubblicità alla Olivetti conosceva per esperienza la forza del linguaggio formulare, anche, si capisce, nella sua carica negativa, sotterraneamente mefistofelica. Negava però che da tale duplicità discendesse la condanna di questa modalità[2]. Né tanto meno credeva nella ‘spontaneità’ e autenticità del dire: “ogni comunicazione (e tanto più quanto più è di massa) non è né immediata né spontanea né naturale, ma sempre non naturale, non spontanea, mediata, storicamente determinata”[3].
Citavo l’endecasillabo dantesco e subito, credo con non pochi della mia biografia, la memoria corre alla massima spavalda d’altri tempi: una scintilla incendia la pianura. Fortini ha praticato con assiduità tale registro, anche nel suo versante poetico, basta pensare agli epigrammi dell’Ospite ingrato[4] o all’esperienza dei testi per tre film, dove ha potuto mettere alla prova la sua convinzione in un mezzo davvero di massa, raggiungendo talvolta risultati di grande intensità emotiva e insieme di acuminata denuncia politica[5]. Certo non è stata acqua la frequentazione della pagina brechtiana per il proprio lavoro di traduttore.
Una volta, in uno dei lunghi monologhi del dopo lezione al nostro minuscolo gruppo di studenti, ci recitò uno slogan proposto al quotidiano “Il Manifesto” cui a quel tempo collaborava. Il giornale soleva allora inserire qua e là nelle sue severe colonne brevissimi slogan per raccogliere abbonamenti. Quello proposto da Fortini e – ci disse – non accettato suonava così: “metti sabbia sotto i denti del padrone / abbonati al Manifesto”.
Da dove ci si parla? Da dove si ascolta?
Una delle ragioni dell’avversione di Fortini al “mito dell’autenticità” è certamente nel suo rifiuto di certi cascami neoromantici, la cui radice è identificabile con l’immediatezza, rifiuto per altro parallelo alle pretese scientiste[6], tant’è che non si lascia sfuggire l’occasione di raccomandare “non troppo genio”[7].
“Due persone che dicono la stessa cosa non dicono la stessa cosa”[8]. “Che cosa significhi una parola, lo decide chi ha il potere”[9]. L’intervallo di trentun anni e la reciproca estraneità letterale non ingannano sul comune significato profondo da cui sgorgano le due massime. Per Fortini, la lingua e più ancora i testi e i generi del discorso sono prodotti sociali, nel senso che il significato di cui essi sono portatori deriva sia dal loro codice che dal contesto sociale in cui sono prodotti. Se questo è vero dal lato e dal tempo della produzione, ciò non è meno vero dal tempo e dal lato della ricezione: il detto non è mai detto – se non per chi ha parlato – una volta per sempre. Il testo non solo è lettera morta se nessuno lo legge, ma sempre il suo lettore contribuisce al suo senso. E Fortini non dimentica che le idee dominanti sono in ogni epoca quelle della classe dominante.
Si tratta dunque di portare alla consapevolezza che interrogarci su un autore è ogni volta un’operazione complessa, che comporta simultaneamente un giudizio sull’autore e uno su di noi, in rapporto a due epoche.
Indizi
Io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri” e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato[10].
A quel tempo non compresi nulla, né ricordo il contesto del discorso, ma mi sono rimasti impressi la voce e le parole di un inciso della sua lezione: essere poeti è così importante che, anche esserlo di seconda fila, è già un onore. C’è dunque in Fortini una considerazione alta della poesia e altrettanto certamente ha sofferto di sentirsi collocato dalla critica nelle file di mezzo. Eppure qualcosa non convince nell’odierna sottolineatura di Fortini poeta. Si sospetta che tale evidenza parli soprattutto di noi, oltre il nostro senso di colpa.
Una mossa permanente del carattere, prima ancora che della morale e del pensiero fortiniani, è l’imperativo di un ordine di precedenze, altro modo d’intendere l’aut aut della scelta: “La parola che più mi stava dinanzi, in quei tempi – così rammenta del sé ventiduenne – era: decidere”[11]. La poesia non è al primo posto nel 1946, “quando da noi si riteneva possibile una soluzione rivoluzionaria”[12], né nel 1982, quando l’intellettuale trova “mirabile” la priorità data da Manzoni alla “pace dell’anima” sul “godimento estetico”[13], né nel 1989: “Perché il problema non è di dare Kafka a tutti, ma a tutti una scuola decente. Ci sono priorità culturali, c'è il problema dell'istruzione”[14]. Si tratta, in sostanza, del prevalere in Fortini dell’urgenza delle relazioni concrete tra gli uomini, ossia - per ricorrere a un vocabolo oggi infrequentabile, tanto è sfregiato e irriconoscibile – della politica. Una passione costante e allarmata, che lo porta, a pochi mesi dalla sua morte, a una conclusione estrema: “quello che di te rimane, che di tutti rimane, non è rappresentato da quei quattro, venti, cento libri che puoi avere scritto […] ma è una quantità di modificazioni che la tua vita, come quella degli altri, ha introdotto nei rapporti fra gli uomini”[15].
Eppure Fortini ha scritto decine di libri, tra cui certamente, per tutta la vita, libri di poesia: di questo noi possiamo e dobbiamo parlare. Se la filologia è inseparabile dalla critica, ciò che di sé e dell’operato intellettuale egli ha detto costituisce l’accesso più agevole.
L’allarme del presente
“Se l’artista ha da essere democratico, arte e letteratura, invece, sono aristocratiche”[16]. L’affermazione, come sempre avviene nei punti più alti della prosa fortiniana, sedimenta faglie, tensioni molteplici che sfidano il lettore alla complicità di un esercizio di pazienza analitica, acume connettivo, integrazione creativa. Il precetto qui in esame, dietro l’ovvia distinzione tra dire e fare, intenzione e opera, istituisce due campi separati dell’agire storico umano, con leggi e istituzioni proprie, addirittura - come vedremo più avanti - con tempi propri, sebbene unica sia la finalità.
Innanzi tutto va precisato che, nella frase, “arte” e “letteratura” indicano parti di uno stesso campo semantico, usate in forma sineddotica: un modo breve per dire ‘le opere che appartengono al campo estetico’. Sull’altro lato della definizione, va osservato che il dover essere democratico dell’“artista” non riguarda, strictu sensu, il momento – la ‘poetica’ – della sua produzione artistica, bensì l’insieme della sua attività e del suo pensiero umano e civile, ossia il suo essere intellettuale.
Nei decenni del proprio impegno intellettuale, Fortini non ha mai traguardato le vicende a partire dalle creste della storia: né le classi, né la cultura dominanti sono stati la sua parte. Si è sempre posto di lato, posizione che gli ha permesso di mettere a nudo la funzione di dominio - non solo nei luoghi sociali che esplicitamente lo esercitano, ma anche in quella parte di ognuno di noi che ne partecipa - di smascherarne con costante impazienza la risorgente pretesa di naturalità.
“Non resisto alla tentazione delle notizie, dell’annunzio imprevisto”, dice Fortini, “quando ero giovane pensavo che le notizie dovessero arrivare non dal lattaio, ma dalla polizia. L’eccesso di speranza”[17]. Questa ininterrotta vigilia, questa allarmata speranza sono la mossa costante della reattività intellettuale, politica e poetica di Fortini, che spiegano al contempo la sua attenzione a scandire in fasi politico-culturali distinte gli avvenimenti vissuti, il continuo riposizionamento e il costante ripensamento delle proprie scelte precedenti. Non si deve però pensare che tale disponibilità agli eventi si risolva in semplice sommatoria di posizioni, di giudizi: se i singoli avvenimenti erano sorprendenti “è certo che l’insieme era previsto”[18]. Né si tratta solo di una presunzione soggettiva, se c’è chi ha potuto accusare Fortini proprio d’incapacità a mutar posizione nel cambiar dei tempi[19].
Nel cinquantennio che va dalla Resistenza alla sua morte, avvenuta nel novembre del 1994, si possono distinguere tre diverse stagioni: l’espansione capitalistica con il relativo compromesso keynesiano, che include e travalica i fortiniani “dieci inverni”; la ripresa neo-marxista con la ‘contestazione’ del Sessantotto fino al ripiegamento degli anni Settanta; la restaurazione neoliberista del capitalismo finanziario che prende avvio proprio nel chiudersi di quel decennio.
Il due e l’uno
Fortini ha esercitato e discusso la categoria di intellettuale che il marxismo, dopo averla ereditata dall’illuminismo e dal romanticismo, ha rideterminato. La formula più stringente, che certo meglio si attaglia alla posizione fortiniana, è quella gramsciana di ‘specialismo più visione politica del mondo’, in relazione con soggetti e istituti collettivi. Si può dire che egli si è mosso nell’onda lunga e per certi versi finale dell’intellettuale novecentesco, perché ne ha vissuto due diverse modalità, sino alla scomparsa delle condizioni sociali concrete, rappresentate da quelli che oggi si usa chiamare ‘corpi intermedi’, i quali avevano precedentemente reso possibile ciò che Gramsci chiama “mescolarsi attivamente alla vita pratica” [20]. Dice nel 1990: “non esiste più la figura dell’intellettuale […] oggi la fine del ceto degli intellettuali non è data soltanto dall’accrescersi del materiale, magari del tritume, dell’informazione ma anche da un fenomeno opposto (e tragico) ossia il sistema della specializzazione”[21]. È proprio in tale scomparsa dell’intellettuale che va ricercata una delle motivazioni dell’attuale rimozione di un certo Fortini, cui sopra si è fatto cenno. Rimozione che meglio di altro ci indica da quale luogo oggi noi osserviamo.
Il Sessantotto – si usa l’indicazione cronologica nel suo valore antonomasico di un movimento mondiale assai più ampio – era animato da uno spirito ribelle, anticonformista che lo portò generalmente a sottolineare, contro il sonno dogmatico in cui sentiva essere caduta la sinistra comunista e socialista, il valore della rottura soggettiva, tanto che riscoprì opere e pensatori marxisti degli anni Venti, da tempo accantonati quando non esplicitamente condannati. Da tale spinta nacque un’espressione, uno slogan che la riassume: rifiuto della delega. Non ricordo che Fortini l’abbia mai impiegata, anche perché nel contesto politico-culturale concreto in cui veniva agita, essa apriva troppo a impazienze sbrigativamente soggettive, che tagliavano fuori una categoria teorica e politica per Fortini irrinunciabile: la mediazione. Eppure, guardando a ritroso e nel suo insieme l’opera fortiniana, scorgiamo che i due lati di quella frase – nella negazione del primo e in quanto afferma, per antitesi, il secondo - aggrumano un carattere profondo della ricerca di Fortini, sul quale poggiano tre snodi fondamentali della sua concezione come della sua pratica intellettuale.
8 settembre. Per Fortini, è un coagulo allegorico, una ferita personale e storica che fissa e orienta per sempre. Tutto l’arco della produzione fortiniana è infatti segnato dalle sue occorrenze. Una riflessione, tra le altre, illumina le molteplici diffrazioni filosofiche, pratico-politiche, morali e persino religiose: “L'«aut-aut» di Kierkegaard su cui mi ero formato dai diciott'anni si è concretizzato nella guerra. Un momento, in particolare, è stato per molti decisivo: quello successivo all'armistizio dell'8 settembre 1943. Quando uno si trova senza poter comunicare con nessuno, senza alcuna informazione sicura, costretto a dover prendere decisioni da cui dipenderà la sua pelle, oltre a quella di altri, allora esperimenta a che si deve obbedienza. Ti trovi a compiere un atto supremo di vanità e nello stesso tempo di umiltà totale: «la mia coscienza mi dice che devo fare questo». Quando si passa attraverso un'esperienza del genere non la si dimentica più”[22]. Si tratta naturalmente, come lo stesso intellettuale avverte, di un fenomeno collettivo che ha segnato un’intera generazione e anzi un’intera fase storica nei suoi vari aspetti politici, filosofici, morali, come, per esempio, illustra la monumentale ricerca di Claudio Pavone[23]. L’8 settembre è la chiamata insieme indeclinabile e verticale, in quanto non delegabile ad altri, della scelta.
Spirito di scissione. Fortini, sulle orme del miglior pensiero critico, cui il marxismo appartiene, pratica la strategia del sospetto. Ora, rivendicare il diritto del giudizio implica, inseparabilmente, la responsabilità della presa di distanza, del mettersi di lato, di scindersi, anche da quella parte di sé che partecipa del banchetto dei signori della terra e degli uomini: “Oggi […] la condizione di ‘emigrato interno’ è l’unica condizione possibile dell’intellettuale che non abbia rinunciato alla prospettiva socialista”[24] Quel gesto di vanità e di tremore origina appunto sempre da un “no”.
Orizzonte della totalità. Non si tratta mai, per Fortini, di sommare la verità di un campo del sapere con la verità di un altro campo, quella di un agire pratico con quella di un differente versante dell’agire pratico. Se la verità è sempre di parte, essa non è mai di una parte. Opera qui la convinzione che la realtà storicosociale dell’uomo costituisce non una somma ma una totalità, per cui è la relazione istituita da questa a orientare e dar senso alle parti. Se invece ci fermiamo al puro dato empirico, come esso immediatamente si presenta, accediamo solo a una somma cieca, che genera per un verso l’illusione di una libertà privata e individuale, per l’altro un’opacità impenetrabile circa le forze sotterranee che l’insieme muovono e circa i meccanismi per cui da questo esse traggono profitto e dominio. È questa la ragione della ferma condanna della mancanza di mediazione: “qualunque immediatezza è, senza possibilità di dubbio, reazionaria”[25]. Quanto detto a parte obiecti, dell’oggetto, vale ugualmente a parte subiecti, dell’agente: la complessità ricca del primo, da decifrare oltre l’evidenza immediata falsamente nitida del dato, sta di fronte alla responsabilità del secondo. “La verità di un giudizio politico può essere scritta parlando di Proust, e un consiglio di poetica può nascondersi in una valutazione del dissenso dell’Est”[26]. Di nuovo un’assunzione di responsabilità oltre ogni divisione[27].
L’uno e il due
L’agire consapevole nella polis, ovvero la politica, che costituisce la linea di condotta di Fortini, ha una traiettoria sorretta da due polarità equivalenti: lo spirito di scissione e l’orizzonte di totalità.
La prima è la mossa che permette il disvelamento: dello sfruttamento, dell’alienazione e della riduzione a strumento tecnico degli specialismi, sia del sapere che dei ruoli sociali. La seconda è invece la condizione gnoseologica della prima e insieme l’energia che muove l’azione. Si tratta insomma di una struttura dialettica.
È necessario però guardare più a fondo in questa relazione, altrimenti risulterebbero inspiegabili le numerose nette condanne, tanto sul versante culturale che su quello politico, della pretesa di una totalità agita ora come imposizione dogmatica[28], ora come estremismo soggettivistico[29]. La totalità, in Fortini, non è un dato, ma un orizzonte e una possibilità, che fa sentire i suoi effetti su almeno tre differenti livelli. Innanzi tutto come bisogno antropologico, parzialmente interpretato dal marxismo, di superare i limiti della propria condizione naturale, nella consapevolezza dell’impossibilità reale di farlo: si tratta di “soffrire più in alto”[30]. Poi come fine che chiede e orienta l’attività politica, ossia la pratica per realizzarla. Infine in quanto ‘come se’ che consente l’accesso alla verità storica.
Se dunque la totalità è un orizzonte, un ‘come se’, insieme futuro e condizione già attiva, impossibile eppure necessario, l’accento è costantemente posto sulla sua scissione. La mediazione è la posta dello scontro storicosociale: per un verso, in quanto risultato e strumento del dominio, si sottrae allo sguardo perché, pretendendosi ultima ossia fine della storia, si mostra come autosoppressa, fatto naturale; per l’altro, in quanto conflitto in atto che dal futuro possibile e necessario prende senso, è insieme la negazione pratica e la verità della prima. L’uno si divide in due. Quella di Fortini è sempre una totalità scissa.
Generi
“Scrivere chiaro”, nelle condizioni date, è un’impostura o un autoinganno, perché fa soggiacere alle settorialità degli specialismi, senza che si osi attraversarli. La nostalgia inestinguibile che ne prende il posto è lì a rammentarci, quando le si resista, il futuro, l’orizzonte necessario della totalità[31]. “Bisogna sfidare il lettore a trovare nella pagina che legge altro da quello che il titolo della pagina sembra promettergli”[32]., si devono “assumere gli argomenti di sbieco”[33], dice Fortini. Scrivere difficile, necessità e strategia, è dunque la lotta dell’intellettuale per oltrepassare la falsa concretezza delle parti, degli specialismi, della datità, per far affiorare l’orizzonte di senso che ne detiene la verità. Contemporaneamente è un’azione politica verso il lettore – “Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!”[34] – che lo costringe a fare i conti con la condizione ideologica in cui è ‘naturalmente’ immerso. Tre sono, riassuntivamente, le valenze in questo modo attivate: attraversamento della settorialità dei linguaggi; uso allegorico della singolarità, ivi compresa quella di chi scrive; il ricondurre il rilievo tecnico-scientifico a un orizzonte di senso.
Si tratta di una ardua strategia di pensiero e di scrittura che contemporaneamente si oppone tanto alla sbrigativa, volontaristica negazione della determinatezza e dei generi, quanto alla loro dogmatica e progressista obbedienza. Una scrittura nutrita dunque da una costitutiva spinta filosofica che, in certi passaggi, ricorda la dignità delle pagine adorniane di Minima moralia[35]. Fortini ha costantemente rivendicato la sua adesione al genere saggistico. Una forma ibrida, dai confini piuttosto elastici, che per certi aspetti affonda le sue radici nell’antichità classica, ma che nella modernità ha mostrato la vitalità maggiore, per la sua disponibilità a unire il rigore argomentativo con la sollecitazione emotiva e morale, la scienza con la letteratura. Il saggio, con le sue asprezze che terremotano il già noto, con i suoi echi che schiudono nuove prospettive, con i suoi vuoti che costringono a interrompere la lettura, ad alzare gli occhi, a contribuire al senso della pagina è propriamente la messa in atto non della totalità, ma del suo orizzonte[36].
Partiti
L’adolescente fiorentino, figlio di un tormentato ebreo antifascista, dal padre eredita, esasperata, l’ansia piccolo borghese di riconoscimento e l’orgoglio della propria diversità[37], una drammatica conflittualità intellettuale ed emotiva che lo porta, con l’esperienza della Resistenza, ad aderire definitivamente alla forza culturale e politica anticapitalistica più importante, il marxismo. La conquista teorica rappresentata dallo spirito di scissione, in obbedienza all’attenzione tattica o, per dir meglio, alla concreta determinazione delle circostanze storiche, trova diretta applicazione nel diverso mettersi di lato nelle stagioni che segnano, come sopra rilevato, il cinquantennio dell’impegno fortiniano.
Nel 1944, a Zurigo, riceve da Silone la tessera del partito socialista, nelle cui fila rimane fino al 1958. È la formazione politica minore della sinistra, che gli permetteva però, come riconosce esplicitamente, di parlare a chi veramente gli premeva, i comunisti, mantenendo la libertà di criticarli[38]. Basta ricordare che in questo periodo, dalla Resistenza alla pubblicazione di Verifica dei poteri, che coincide con l’apertura della cultura del Sessantotto, le collaborazioni più importanti di Fortini sono state il “Politecnico” di Vittorini, “Officina” di Roversi, “Quaderni rossi” di Panzieri, “Quaderni Piacentini” di Bellocchio. La raccolta di saggi fondamentale di questo periodo, Dieci inverni, si chiude assai significativamente con la Lettera a un comunista, che a sua volta termina con queste parole: “Perché ti racconto queste cose, che tu sai benissimo? Perché voglio esser certo che tu esisti e che non ti ho immaginato; e che altri esistono fin d’ora come me e come te; e parlano come noi cominciamo a parlare”[39].
La raccolta Verifica dei poteri, del 1965, pur presentando una scelta di saggi usciti dopo Dieci inverni, per il taglio e per il fondamentale, ampio Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo già inaugura la seconda stagione fortiniana, quella del Sessantotto. Un volume con cui il suo autore diventa uno dei principali maestri di quella stagione[40]. In questo saggio si conduce allo sviluppo forse più compiuto sia la critica al tatticismo riformista del Pci e delle sinistre storiche europee – è questo il senso della reclamata “fine dell’antifascismo”[41] – sia con la maggior energia si denuncia la costitutiva stretta dogmatica del partito principe e quindi la necessità del rifiuto della delega a proposito del “mandato degli scrittori”: “il Partito è l’ente che con la propria presenza allude al superamento delle ‘specialità’, il Principe e il Filosofo collettivi in potenza, l’organo del Sapere; ora, nella misura in cui conservano – col potere sul verbo – il potere spirituale ‘di sciogliere e di legare’, gli intellettuali e, per essi, gli scrittori e gli artisti come quelli che sono irriducibili ad una ‘specialità’, negano di fatto e al presente quella unicità di potere cui il Partito si richiama”[42].
Questioni di frontiera, che, come recita il sottotitolo, raccoglie “scritti di politica e di letteratura” dal 1965 al 1977, segna un riposizionamento dell’autore. In questa stagione il riferimento sono i fermenti culturali e politici del Sessantotto, si trattava dunque di porsi di lato rispetto ad essi. Il punto di caduta, questa volta, non è il dogmatismo, bensì l’opposta frenesia ribellistica, l’illusione – anche questa piccolo borghese, seppure simmetrica a quella riformista – del tutto e subito: se la mancanza di mediazione denunciata in Verifica dei poteri era la pretesa del partito principe di essere già la totalità solo futura, nei movimenti neomarxisti e contestativi del Sessantotto la mancanza di mediazione si manifestava nel convincimento che la totalità fosse già data non nel partito ma nel movimento, nella società in rivolta. Non fu facile comprendere per chi si trovò ora accanto, ora sotto il suo dito. Ricordo di avergli domandato perché non prendesse la tessera: bisogna che il calice sia prima svuotato interamente, mi rispose.
Contro tendenze dominanti in questa stagione non solo denunciò, come sopra si ricordava, il radicalismo totalizzante che pretendeva di ascrivere “la felicità” al marxismo, ma aggredì una radice importante di quella fase politico-culturale, l’antiautoritarismo, per evidenziare la falsità dell’atteggiamento liquidatorio che verso l’autorità era stato tenuto: “L’autorità sembra fondare la diseguaglianza; e viceversa. Ma in una prospettiva comunista rinnovata l’esigenza di eguaglianza non ci chiede solo l’eguaglianza delle condizioni; ossia del punto di partenza. Anche una società capitalistica può darla e finirà col darla, almeno in alcuni paesi. Chiede l’eguaglianza delle conclusioni, invece: la più terribile, oggi, la più spaventosa anche al progressista, quella che viene presentata e sentita da ognuno di noi come livellamento, ottundimento, massificazione, regresso. Eguaglianza delle conclusioni vuol dire massima omogeneità dei destini e dei comportamenti”[43].
Un altro aspetto dello stesso rifiuto della mediazione, proprio del soggettivismo, è criticato con forza da Fortini. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1974 che rendeva possibili ai privati le trasmissioni via cavo e soprattutto dopo la pronuncia del 1976, che liberalizzava anche quelle via etere, proliferarono in Italia le “radio libere”, nelle quali parte importante ebbero, inizialmente, i movimenti e le associazioni di giovani, che ne fecero una bandiera e un’arma. Fortini, approfittando delle domande dell’inchiesta di una rivista, scrisse un duro attacco intitolato Il mito dell’immediatezza: “In via di principio non posso essere contrario a dilatare l’accesso alla comunicazione, a condizione che non si abbia inutile rispetto ‘democratico’ per la imbecillità. Non abbiamo forse ascoltato, in riunioni o trasmissioni, il periodico richiamo a ‘lasciar parlare tutti’? Ci siamo accorti che non sappiamo, in nome della democrazia, come fare per togliere la parola agli idioti e ai provocatori?”[44].
Diari, indizi
Se qui dove siamo giunti chiediamo una sosta, qui nel travolgente giro d’anni che nel 1978, entro il piccolo orizzonte italiano, vede il rapimento Moro a chiudere dissennatamente una stagione, e che poi, in crescendo, registra nel 1979 la prima nomina di Margaret Thatcher, nel 1981 la prima presidenza di Ronald Reagan, dai quali prende avvio la drammatica reazione capitalistica neoliberista che tuttora squassa vite, popoli e continenti, se da qui, dicevo, ci volgiamo indietro, scorgiamo nella solida coerenza di Fortini tra analisi teorica e attività intellettuale un’emergenza che ci affida un insegnamento e ci obbliga a nuove domande.
Nel tumulto di eventi grandi e terribili, Fortini, sulla scorta di certo marxismo, è approdato a un difficile paradigma teorico, cui si è attenuto con grande acume per il profilo dei tempi e con animo generoso, traendone una militanza intellettuale coerente e straordinarie pagine di analisi e di critica. La categoria della totalità gli ha permesso di stabilire nessi sotterranei tra i diversi aspetti sociali, capaci di spiegarne cause, dinamiche e possibili rovesciamenti. D’altra parte, la rinuncia a una totalità posseduta, la cura di tenerne aperta una scissura, gli ha reso possibile, insieme con l’assunzione personale della responsabilità, di fare spazio, resistendo al ricatto del consenso, alla critica ai veli dell’ideologia e del dominio.
La risorgenza nei tornanti delle fasi politico-sociali di tale coppia antinomica si radicava, come abbiamo visto, nell’esistenza di una pratica conflittuale orientata alla totalità. Una pratica resa possibile prima di tutto dalla presenza politica, sociale e culturale del partito comunista italiano – e dalle varie organizzazioni associative della sinistra che strutturavano la società - poi, in subordine, dai movimenti del Sessantotto. Essi costituivano la leva materiale e il riferimento teorico su cui l’azione critica di Fortini poteva poggiare. Egli ne è del tutto consapevole, tanto che in un’intervista del 1981 osserva, a proposito delle riviste cui ha partecipato negli anni Cinquanta e Sessanta, che il motivo per cui esse “non erano del tutto assurde o ridicole risiede nel loro ossequio alle forze politiche esistenti. Sebbene non fosse soltanto una questione di ossequio, ma l'assunzione, giusta o non giusta, reale o immaginaria, di un referente costituito dai militanti e dagli iscritti dei partiti della sinistra, dalla gente socialmente appartenente all'area della sinistra. Questi gruppi sapevano che i militanti della sinistra pur non pensando le stesse cose che essi scrivevano nelle loro centinaia di foglietti, e ai quali mediatamente si rivolgevano, non erano tutt'altro, non erano un mondo molecolare ridotto alla dispersione”[45]. Quindi con la consueta reattività annota il cambio di paradigma in corso proprio in quegli anni: “Oggi non si può contare su questo” e pensare che il lavoro politico-culturale necessario “possa essere frutto di volenterose minoranze intellettuali, oggi mi sembra veramente assurdo”[46].
Fortini, tenendosi saldamente a quella pratica che l’orizzonte della totalità rendeva operativo, ha nel contempo messo a nudo come le organizzazioni che la agivano pretendevano – contro la ragione stessa per la quale erano sorte – di essere già la città futura. In questo modo ha contribuito a illuminare i termini teorici e politici di una questione fondamentale nel passaggio da una società capitalistica matura a una diversa formazione economico-sociale, la quale si prefigga di abolire lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e della sua alienazione. Lo ha fatto a partire dal ricorso critico al proprio ruolo intellettuale così come si è configurato nella fase di massima espansione capitalistica del secondo Novecento. I fatti sono lì a mostrarci che le condizioni politiche e sociali, che quel tentativo avevano reso possibile, sono venute meno a partire dall’ultimo ventennio del secolo scorso. Ma le dinamiche storiche non si esauriscono nei tempi brevi e comunque sappiamo, anche sulla scorta dell’insegnamento di Fortini, che non necessariamente chi vince ha ragione, che gli argomenti di chi ha perso non possano diventare armi future. È semmai da osservare come la condizione attuale risulti simmetrica rispetto a quella di Fortini. Se egli aveva potuto dare per acquisito per una lunga fase il partito, per cui si trattava di praticarne la scissura, oggi ci troviamo immersi in un contesto che si presenta immediatamente come la più grande frammentazione, dove anche gli elementi associativi vivono nella momentaneità e nella singolarità.
Lo sviluppo potente del capitalismo nei “trenta gloriosi” ha tuttavia lasciato un resto nella pur sorvegliata ricerca fortiniana, che non possiamo sottacere in sede di bilancio complessivo. Per un verso, come già accennato, egli ha prontamente registrato la diversa collocazione dell’intellettuale indicandone la fine e descritto in modo fertile la nuova realtà sociale e culturale, per l’altro non ha avvertito il movimento di vasta regressione che il neoliberismo iniziava a produrre sull’insieme della società, dei popoli e del pianeta, fatto che a quasi quarant’anni da quell’avvio siamo costretti a saggiare sulle nostre piaghe. È come se, per dirlo sbrigativamente, egli avesse ben presente la permanente produzione di barbarie da parte del capitalismo, ma non avvertisse che quella non necessariamente si accompagnava a una corrispondente crescita da qualche altra parte del pianeta.
Il quindicennio finale della vita di Fortini è segnato, come già visto, dalla fine dell’intellettuale, determinata appunto dal venir meno della condizione che rendeva possibile l’attraversamento politico degli specialismi: la centralizzazione teorico-pratica del partito e la dialettica dei corpi intermedi. Fortini descrive una società di frammenti[47] e quindi vive nella solitudine. Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, s’intitola, per esempio, il volume del 1990, costruito come flusso di pagine di diario intellettuale, dove, nel Saluto, sorta di postfazione in forma di poème en prose al lettore, quasi incidentalmente pronuncia l’assillo fondamentale: “Rispondere così vuol dire ironizzare e l’ironia non è concessa alla solitudine”[48].
Le pagine saggistiche più dense di questo periodo sono quelle che descrivono la polverizzazione sociale, la destrutturazione culturale allora iniziata. Di grande interesse, per esempio, la denuncia di come il consumismo estremo dell’industria culturale, mentre appiattisce tutti verso il basso, venda paradossalmente l’illusione di dare a ciascuno qualcosa di esclusivamente personale, in obbedienza all’individualismo estremo dell’ideologia dominante[49]. Fortini osserva che tale dinamica produce deprivazione, analfabetismo di ritorno, allontanamento dalla stessa cultura di massa, anche nel cuore delle società capitalistiche, come gli stessi Usa, ma giudica che esso interessi “una frangia della popolazione, i cosiddetti esclusi, i marginali”[50]. Tant’è vero che la nota dominante gli appare essere, appunto, come recita il titolo del saggio in questione “lo snobismo di massa”. D’altra parte le “estati romane”, che dal 1977 l’assessore alla cultura del Pci, Renato Nicolini, aveva organizzato fino al 1985, avevano diffuso in Italia, in quelli che Fortini in una conversazione privata m’indicava come Assessorati Turismo & Spettacolo, la ‘cultura dell’effimero’, ossia del consumismo edonistico, costituita da eventi culturali ai quali accorrevano migliaia di giovani e meno giovani. “Quello che è successo” dice Fortini “mi ha dato torto”[51]. Dal momento che l’intellettuale è stato sostituito dall’esperto, il saggio è diventato pagina di diario[52]. E persino la produzione letteraria è ora possibile “in tutte quelle forme letterarie che il nostro secolo ha trascurate, il diario, le lettere, la mescolanza di autobiografia e poesia, le forme della discrezione”[53].
Lenin e Beethoven
Per Fortini, se l’agire consapevole nella polis, quindi anche quello dell’intellettuale come ceto, è orientato dalla possibile totalità, la poesia e in genere l’arte è totalità. Se il compito dell’intellettuale è giocato sui tempi brevi della politica e delle variazioni economico-sociali, l’arte è invece alle prese con i tempi lunghi e lunghissimi, forse antropologici. Se l’autore del saggio è pienamente responsabile, il poeta, l’artista è in buona misura ir-responsabile. In altre parole, non solo un’opera d’arte non è un’opera critica, ma anche il critico è una persona diversa dall’artista, perché costituiscono due diverse istanze del soggetto: la prima attiene alla sfera etico-razionale della coscienza; la seconda a quella in gran parte irrazionale della pulsionalità inconsapevole[54]. Anzi, precisa Fortini: “nell’atto di scrivere versi […] rischio ed espongo alla prova non solo qualcosa di diverso, ma di più di quanto faccia con l’atto di scrivere prose critiche”[55]. Tant’è vero che nei due piani è del tutto diversa la figura dei destinatari polemici: “Parlare di nemici o di avversari nella poesia non si può. La stessa cosa non la posso dire di Agnelli”[56].
Eppure medesima è l’energia, la direzione e la causa finale: la totalità. In questo concetto, Fortini si rifà esplicitamente alla concezione dell’opera d’arte come organismo, di Schiller[57]. Questi, nel saggio Sull’educazione estetica dell’uomo, descrive l’opera artistica come un organismo nel quale è abolita la casualità per la sottomissione delle parti a un finalismo interno. È agevole osservare, con un’ottica storico-politica marxista, che tale organismo, se paragonato alla vita storica reale, descrive la dis-alienazione, ovvero la riappropriazione della vita e del destino comune, mentre il piacere estetico procurato dall’opera d’arte è la gioia e il piacere della totalità concreta. Ma l’adesione di Fortini alla proposta estetica schilleriana è determinata da un ulteriore aspetto, altrettanto energicamente sottolineato dal poeta romantico: l’uomo “possiede tale diritto di sovranità solo nel mondo dell’apparenza e dell’immaginazione e solo finché si astiene scrupolosamente […] dal voler produrre da esso un’effettiva esistenza”. Tale posizione si attaglia perfettamente alla ferma convinzione di Fortini circa l’inconciliabilità di arte e vita, radice teorica, estetica e culturale della sua avversione tanto delle poetiche ermetiche[58], quanto delle neoavaguardie, con le quali ampia è stata la polemica.
Fortini vede dunque nell’opera d’arte non un orizzonte di totalità, ma, pena l’assenza del suo valore, una totalità effettiva che, in una società divisa in classi, può essere solo dei signori degli uomini. Di qui la costante convinzione che il poeta si siede sempre alla tavola dei padroni, che non si dà “un Petrarca per tutti”[59] e la constatazione dell’impossibilità, per i rivoluzionari, di sopportare la bellezza artistica[60]. Di qui, insomma, la sottolineatura dell’ineliminabile commistione tra appello al futuro, sprone all’imitazione verso il fruitore e insieme nascondimento ideologico, che la fascinazione estetica possiede, di presentare come reale la propria finzione. Solo se e fintanto che il fruitore tiene desta la consapevolezza dell’essere quella totalità solo in figura, egli può sottrarsi alla falsa realtà e nutrirsi invece della nostalgia di un’integrità che solo la sua azione storica reale potrà avvicinare. Risulta così più chiara anche la personale poetica ‘manierista’, la sua obbedienza al canone e il ricorso al falsetto, mentre sul piano teorico il ‘come se’, che nel ruolo intellettuale si attuava attraverso la scissione della totalità, spostando questa in un orizzonte futuro, nel campo estetico assume la forma della sospensione dal piano della realtà e quindi di prefigurazione di un reale tanto più possibile e necessario, quanto più alto è il valore artistico dell’opera.
[1] Dante, Paradiso, I,34.
[2] Si veda, tra le tante, la seguente affermazione: “Un buon esempio di quanto dico è nel grande documentario sulla Cina, girato da Ivens. Parlando con Edoarda Masi e con una cinese mia conoscente ho saputo che i discorsi dei personaggi intervistati, delle contadine, dei tramvieri, sono quasi esclusivamente degli elenchi di stereotipi: tutti parlano come libri stampati, anche quelli che meno si sospetterebbe. È una prova della straordinaria bravura di attori dei cinesi, i quali spontaneamente recitano l'autenticità? Certo. Ma, con ciò, dobbiamo considerare tali messaggi come menzogne? Niente affatto. Essi possono veicolare la menzogna, ma sono la forma con la quale è stato possibile dare a queste persone la parola”, Franco Fortini, Il mito dell’immediatezza, in “Aut Aut”, n.s., 1963, gennaio-febbraio 1978, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-94, a cura di Velio Abati, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p.210.
[3] Ibidem.
[4] L’autore ne ha pubblicate due edizioni: L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici, Bari, De Donato, 1966 e L’ospite ingrato. Primo e secondo, Casale Monferrato, Marietti, 1985.
[5] Cfr. Franco Fortini, Tre testi per film. “All’armi siam fascisti” (1961), Scioperi a Torino (1962) La statua di Stalin (1963), Milano, Edizioni Avanti!, 1963. Si veda, per esempio, la straordinaria sequenza “…Eccoli dire / di sì, di sì perché lo fanno tutti, / di sì perché lo ha detto monsignor vescovo…” di “All’armi siam fascisti!”, p.30.
[6] “Il mito della spontaneità e dell'autenticità ha impedito a sinistra qualsiasi organizzazione in questo senso sistematico di una educazione o di una resistenza. Eco ha scritto molto e spesso saggiamente su questi temi, salvo credere di poter giocare d'astuzia col sistema dominante e diventarne così un pregevolissimo collaboratore. Ad esempio la stampa ed anche i mezzi radiotelevisivi di sinistra non si pongono mai il problema della ripetizione, ma solo quello della variatio: hanno scelto questa, tra le possibilità retoriche, perché credono che promuoverebbe al massimo l'autenticità, mentre la ripetizione sarebbe autoritaria, dittatoriale e deprimente”, Franco Fortini, Il mito dell’immediatezza, cit., p.212.
[7] S. Palumbo, Quel busto romano di una dea, in “Poesia”, XI, 118, giugno 1998, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.737: “Se dovessi fare un augurio per il nostro Paese, vedrei meglio, anziché una figura come Pasolini, una leva di storici, filologi, sociologi, pedagoghi orientata, soprattutto, a trasformare la scuola. La formula? Per favore, non troppo genio”.
[8] Otto domande sulla critica letteraria in Italia, in “Nuovi Argomenti”, VII, 44-45, maggio-agosto 1960, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.19, dove la frase suona esattamente così: “due persone (tanto più due critici) che dicono la stessa cosa non dicono la stessa cosa”.
[9] Alberto Papuzzi, Fortini sempre antiamericano, in “La Stampa”, 13 settembre 1991, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., pp.622-3.
[10] Dante, Pugatorio, III,43-5.
[11] Franco Fortini, I cani del Sinai, Macerata, Quodlibet, 2002, p.48.
[12] Laura Lilli, Solo il Vangelo è un libro per tutti, in “La Repubblica”, 30 marzo 1989, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.537, che così continua: “Immaginiamo – dissi a Vittorini e Balbo – che domani noi tre formiamo un comitato incaricato di assegnare la carta all’editoria nazionale, e la carta sia il cinquanta per cento di quella che avevamo l’anno scorso. Cosa facciamo? Stampiamo Proust o manuali d’igiene?”.
[13] Ferdinando Camon, Il mestiere di poeta, Milano, Lerici, 1982, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.78: “Manzoni, discutendo con un personaggio immaginario sull’amore nelle opere letterarie, esce a dire che qualora Racine, per ragioni di scrupolo religioso, gli fosse venuto a richiedere l’ultima copia delle sue tragedie ancora esistente al mondo, per bruciarla, egli, Manzoni, gliel’avrebbe data, di tutto cuore, e immediatamente; perché riteneva più importante, in assoluto, la pace dell’anima di Jean Racine che non il godimento estetico quale tutta l’umanità avrebbe potuto ricavare, nei secoli dei secoli, dalle sue opere poetiche”.
[14] Laura Lilli, cit., p.537.
[15] Claudio Altarocca, Fortini. Italia orribile ti dico addio, “Tuttolibri” supplemento di “La Stampa”, 5 marzo 1994, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.699.
[16] Laura Lilli, cit., p.538.
[17] Francesco Gambaro, Un fiero narciso con “il vizio della speranza”, in “L’Ora”, 29 marzo 1992, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.636.
[18] Ibidem.
[19] Cfr. Claudio Altarocca, cit., p.701: “Un giorno incontro Adriano Sofri, che mi dice: ‘Non sei cambiato. Sei una pietra’. ‘Non credo di essere un fossile di Rifondazione’, gli ho risposto. Non si tratta di fedeltà al passato, ma di rigore nella ricerca. Non si può rimanere fedeli, nostalgici, contenti della propria coerenza. Bisogna invece rischiare, rimettere ogni giorno in discussione la propria biografia”.
[20] Antonio Gramsci, La formazione degli intellettuali, in I quaderni del carcere. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, a cura di Valentino Gerratana, Roma, Editori Riuniti, 1996, p.22: l’intellettuale nuovo deve “mescolarsi attivamente alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, ‘persuasore permanentemente’ perché non puro oratore – e tuttavia superiore allo spirito astratto matematico; dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla concezione umanistica storica, senza la quale si rimane ‘specialista’ e non si diventa ‘dirigente’ (specialista + politico)”.
[21] Mavì De Filippis, Intervista a Franco Fortini, in “La Ragione Possibile”, I, 1, maggio 1990, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., pp.582-3.
[22] Lorenzo Prezzi, Morale, il nome privato della politica, in “Il Regno”, 15 maggio 1983, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.330.
[23] Cfr. Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati-Boringhieri, 1994, p.23: “Eventi grandi, eccezionali, catastrofici pongono i popoli e gli uomini davanti a drastiche opzioni e fanno quasi di colpo prendere coscienza di verità che operavano senza essere ben conosciute o la cui piena conoscenza era riservata a pochi iniziati. Il vuoto istituzionale creato dall’8 settembre caratterizza in questo senso il contesto in cui gli italiani furono chiamati a scelte alle quali molti di loro mai pensavano che la vita potesse chiamarli”.
[24] Franco Fortini, Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, in Franco Fortini, Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1974, p.170.
[25] Mauro Mauruzj e Donatello Santarone, Franco Fortini: le catene che danno le ali, in “I Giorni Cantati”, I, 2-3, luglio-dicembre 1981, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.301.
[26] Vicino agli Sposi promessi, in “La Repubblica”, 27-28 novembre 1977, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.195.
[27] Cfr. Franco Fortini, Quale arte? Quale comunismo?, in Dieci inverni. 1947-1957 contributi ad un discorso socialista, Bari, De Donato, 1973, p.135: “I politici sono avvezzi a non ascoltare i tecnici della cultura, questi a non farsi ascoltare; e così vivono benissimo gli uni e gli altri, raccomandandosi scrupolosamente la divisione dei poteri e delle impotenze”.
[28] Cfr. Franco Fortini, Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, cit., p.149: “Il Partito pretende di esercitare subito quella funzione che assolverà solo quando si dissolverà in quanto Partito nella società senza classi e nella circolazione omeostatica delle sue parti”.
[29]Cfr. Franco Fortini, Il dissenso e l’autorità, in Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977, p.55: “Il discorso marxista […] non ha niente a che fare con la ‘felicità’, non può proporre altro che una interpretazione parziale del mondo e saper di proporla. E quando si dice parziale, cominciamo a prendere questo termine anzitutto nel suo senso più forte e corrente, non facilmente dialettico – come invece si fa di solito quando ‘parzialità proletaria’ viene identificata alla volenterosa Negazione della Negazione, sì che ti prendi con una mano quel che avevi lasciato sfuggire dall’altra”.
[30] Cfr. Mavì De Filippis, cit., p.577: “Si tratta cioè di spostare il livello, non di togliere la contraddizione; di cambiare la qualità della contraddizione”.
[31] Cfr. Franco Fortini, Scrivere chiaro (III), in Disobbedienze I. Gli anni dei movimenti. Scritti sul manifesto 1972-1995, Roma, Manifestolibri, 1997, p.61: “La nostalgia del discorso quotidiano, pratico, diretto e ‘chiaro’ è anche, o dovrebb’essere, augurio e lotta per un’unità, per una restituzione dell’uomo a se stesso; la medesima che è scritta tradizionalmente sulle bandiere del socialismo e che oggi, sembra, fa ridere, come umanesimo prescientifico, gli avventati ammiratori di un noto filosofo del Pcf. Ma non si lotta con i linguaggi settoriali e contro ciò che ci divide, restando prima di quei linguaggi e non oltrepassandoli”.
[32] Vicino agli sposi promessi, cit., ora in Franco Fortini, cit., p.195.
[33] Cfr. Gianni Turchetta, Vale ancora la pena. Incontro con Cesare Cases e Franco Fortini, in “Linea d’Ombra”, V, 20, ottobre 1987, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.489: “Di qui viene al tendenza ad assumere gli argomenti di sbieco o puntando su un particolare, aumentando il tasso di pretestuosità, e usando i tesi come pretesti per altri discorsi”.
[34] Charles Baudelaire, Au Lecteur, in Les fleurs du mal, a cura Luigi de Nardis, saggio introduttivo di Erich Auerbach, Milano, Feltrinelli, 1965, p.6.
[35] Per la posizione di Fortini verso questo aspetto della prosa di Adorno cfr. Alfonso Berardinelli, Franco Fortini, Firenze, La Nuova Italia, 1973, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.143: “posso aver scritto e scrivere torbido e oscuro perché non so pensare con ordine o, più schiettamente ancora, perché ho pensieri torbidi e oscuri. Ma certo. Non basta pretendere alla dialettica per scrivere come Adorno, grazie tante”.
[36] Cfr. Alfonso Berardinelli, cit., p.142: “La difficoltà, l’oscurità, il fumo si accompagnano necessariamente ad ogni discorso che si rifiuta a dispiegarsi perché ha come proprio centro una proposta o una allusione di totalità. Hanno parlato di mistica. Un corno, come diceva Vittorini. Essere verso il comunismo, per me, ha voluto dire indicare, con uno stesso gesto, l'assenza di unità umana (o l’alienazione, come si dice) e l'ipotesi di quella unità (o la fine dell’alienazione). Ebbene, pensare e scrivere voleva dire, per me, vuol dire, un equivalente di quel gesto”.
[37] Cfr. Franco Fortini, I cani del Sinai, cit., in particolare la lassa 17, pp.45-50: intenso ritratto del padre, che è, in controluce, uno straordinario autoritratto.
[38] Cfr. Arnaldo Nesti e Pietro De Marco, “Fare diversa questa realtà, non farne un’altra (con un inedito), in “Religione e Società”, IV, 8, luglio-dicembre, 1989, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.561: “Non ero tenuto alla disciplina di partito che loro [sc. i comunisti] avevano, mentre erano solo essi i miei interlocutori; non avevo in realtà nessun interlocutore nel Psi eccetto Riccardo Lombardi. Questo faceva sì che continuamente e in modo insistente agitavo, presentavo dei caveat ai comunisti, contro l'ottimismo gramsciano, l'ottimismo ufficiale togliattiano, l'ottimismo crocio-gramsciano degli Alicata e dei Muscetta, ricevendone in cambio insulti di vario genere”.
[39] Franco Fortini, Dieci inverni, cit., p.299.
[40] Cfr. Renato Minore, Rabbie e speranze, in “Il Messaggero”, 7 gennaio 1984, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.345: “Nel '64, a quarantasette anni, sono stato licenziato quasi contemporaneamente da Olivetti e da Einaudi. Avevo debiti, una bambina piccolissima. È stato un brusco declassamento. Mi ricordai che molti anni prima avevo vinto un concorso come professore, feci la scuoletta a Lecco […] Mi trovai a contatto di gomito con tanti giovani che si occultavano nell'insegnamento: era la generazione del '68”.
[41] Cfr. Franco Fortini, Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, cit., p.158: “Se il fascismo è collegato bensì al capitale ma da caratteri patologici, mostruosi, da nemico del genere umano; se fin dal 1935 appare così evidente la preoccupazione di ‘non spaventare’ con le parole del marxismo gli intellettuali e gli scrittori ‘ben disposti’ (e, dieci e quindici anni dopo, quella preoccupazione sarà ancora di corrente circolazione nel nostro paese) – allora la sola zona nella quale sarà dato incontrarsi sarà quella del più fiacco e socialradicale ‘umanesimo’”.
[42] Ivi, pp.148-9.
[43] Franco Fortini, Il dissenso e l’autorità, cit., p.58.
[44] Franco Fortini, Il mito dell’immediatezza, cit., p.215.
[45] Mauro Mauruzj e Donatello Santarone, cit., pp.303-4.
[46] Ibidem.
[47] Cfr. Bruna Miorelli, L’”autentico” è un’illusione, in Invisibile lo stato della cultura oggi in Italia, in “Azimut”, VI, 27, gennaio-febbraio 1987, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.449: “Abbiamo avuto, a Milano, nei tardi anni cinquanta e negli anni sessanta, un grandissimo sviluppo di centri di attività culturale […] Quel tipo di sedi di dibattito non sono più esistite. Oggi la città è ricchissima di sedi «culturali» ma tutte tendono a diventare omogeneizzate, come lo sono, ad esempio, i periodici. È molto difficile, oggi, immaginare un luogo, dove si dibattano delle questioni che non siano solo molto particolari, limitate”.
[48] Franco Fortini, Saluto, in Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Milano, Garzanti, 1990, p.127.
[49] Cfr. Contro lo snobismo di massa, “Laboratorio Samizdat”, IV, 7, novembre 1989, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.549: “La tendenza di quello che conviene chiamare ‘tardo capitalismo’ è oggi rivolta a queste due mete solo apparentemente contraddittorie. Per un verso, dunque, ci vogliono tutti simili o uguali: consumiamo gli stessi prodotti, tendiamo a leggere gli stessi libri (o a non leggerli) consumiamo gli stessi elaborati. È quella che chiamiamo ‘cultura di massa’, al suo livello inferiore. Ma, per un altro verso ‑ e basta guardare la pubblicità dei prodotti che riempiono i settimanali e le trasmissioni televisive ‑ si tende a proporre un modello di individuazione estrema: non essere come gli altri, sii diverso, più bello, più forte, ecc.; mettiti nella condizione di gestire il tuo tempo libero in modo originale, fatti una ‘cultura’…”
[50] Ibidem.
[51] Rocco Capozzi, Di scrittori, di critici, oggi. Franco Fortini, in “L’immaginazione”, VII, 81, settembre 1990, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.596.
[52] Cfr. ivi, p.597: “siamo divisi fra la possibilità di un saggismo (che quasi tende a coincidere col diario intellettuale) e un sapere specialistico che va, diciamo così, tanto più benedetto e protetto quanto più è insufficiente”.
[53] Franco Brioschi, Vent’anni sprecati?, in “L’Unità”, 23 ottobre 1983, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.342.
[54] Cfr. Renato Minore, Rabbie e speranze, cit., p.344: “Ho l'impressione che quello che scrivo appartenga a un altro che mi sfugge. Se devo difendere un articolo sono disposto a tutto. Se devo difendere una poesia non ne sono capace se non nella forma generica, dicendo "però è bella". Insomma, c'è una situazione di divisione schizoide per cui la mano che scrive versi non è la stessa che scrive in prosa”.
[55] Franco Palmieri, La crisi dell’ideologia? Un’invenzione di chi rinuncia, in “Avanti!”, 17 febbraio 1966, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.89.
[56] Giorgio Fabre, Letteratura ti assolvo, in “L’Unità”, 18 agosto 1987, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.482.
[57] Cfr. Mavì De Filippis, cit., p.579: “Ho usato la formula secondo la quale la forma letteraria o artistica è, non direi, metafora quanto piuttosto anticipazione, promessa e modello. Proporrebbe con la sua ‘astanza’ un modello di come la vita potrebbe essere nel tempo. Ossia una proposta di coerenza. Ora è chiaro che questa non è certo una mia invenzione. È già presente nel pensiero schilleriano”.
[58] Cfr. uno dei più secchi epigrammi, in Franco Fortini, L’ospite ingrato, cit., p.141: “Carlo Bo. / No”.
[59] Laura Lilli, cit., p.538.
[60] Cfr. Franco Fortini, Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, cit., p.186: “Lenin (come l’aneddoto racconta) non potrà rimanere a lungo ad ascoltare Beethoven che dice inutilmente agli uomini quel che essi possono diventare”.
10 dicembre 2017
Il testo qui di seguito presentato è comparso sull' "Indice" di ottobre 2017. v.a.
Su Da che mondo di Giorgio Luzzi
La prova più recente di Giorgio Luzzi non delude il lettore che conosca le prove della sua “usuale mania / di astratta perfezione”: Da che mondo non è né nuova raccolta, né autoantologia con liriche nuove. Costituisce invece un libro, frutto di meditata costruzione. I quattro decenni della poesia luzziana, presentati in campionature per la parte edita, disegnano un percorso di trasformazione e di crescita. Dallo sguardo d’insieme meglio traspare l’energia che da sempre muove la parola poetica di Luzzi, la necessità di un orizzonte di senso del “mondo”, nella convinzione strenua che esso lo si trovi o lo si manchi nella poesia. Le raccolte antologizzate seguono una disposizione inversa alla loro cronologia, per cui coerentemente l’opera si apre con la parte inedita. Questa, tripartita, recante al centro la sezione eponima, per un verso è il naturale sviluppo stilistico delle ultime pubblicazioni, per l’altro, nei temi e nei moti dell’animo, continuamente si piega verso gl’inizi. L’opera dispiega una catabasi, esaltando in questo modo la condizione di ‘parola ultima’ che appunto costituisce il tratto costitutivo della ricerca di Luzzi.
Nelle opere degli anni Novanta la “mania di perfezione” veste ancora la forma dei vittoriniani ‘astratti furori’. Lì, il grado massimo dei due procedimenti fondamentali della poesia luzziana, la densità analogica e il montaggio sintattico, talvolta abraso dei segni interpuntivi, conducono il lettore in una dimensione straniata e metafisica. La tensione etica di quell’operato si avvertiva in certi grumi crudi, o in certi urti della storia.
A partire dalla fine degli anni Novanta, con Predario, e poi con Sciame di pietra, del 2009, allorché agli slanci del “secolo breve” si sono sostituite le violenze di una quotidianità immemore e smarrita, dove il dominio di quello che è stato chiamato finanz-capitalismo acquista il volto inattingibile del dato di natura, la ricerca di Luzzi avverte il rischio delle lusinghe della parola orfica, si obbliga a tenersi più a ridosso delle asprezze degli eventi. Basta vedere, tra i testi scelti da quest’ultima raccolta, l’ampia Guernicana. La spinta all’oltranza sintattica è più raffrenata, la strutturazione strofica e del verso tende a una regolarità, si affacciano il sonetto e la terzina ‘all’occhio’, si ricorre talvolta alle misure brevi. Si assiste insomma a una contromossa: la responsabilità etica e gnoseologica della poesia, a fronte dei frantumi violenti che ottundono la quotidianità, propone al suo lettore l’esperienza necessaria di un ordine.
5 ottobre 2017
Livia
Chi ha conosciuto Livia? Compagna di banco, no. A quel tempo nessuno di noi poteva averne, obbligate com’erano a indossare ancora grembiuli neri. Qualcuna, più orgogliosa, lo lasciava all’attaccapanni, per indossarlo in fretta appena entrata.
Rotondetta, con una voce esile e lunga coda castana, la sentivo sorridere tutta la mattina. Nella pausa della ricreazione, poi, si esaltava. Si girava spesso, in particolare verso uno di noi diventato, per questo, bersaglio nel nostro piccolo gruppo. Ma amiche non rammento che ne avesse. Mi accorgo di scriverne per la prima volta il nome. Nome solenne. La nostra terra appartata ha coltivato a lungo la passione per nomi imponenti, portati però con naturale trascuratezza e che, solo con fatica, ho potuto in seguito riconoscere: impronte, talvolta appena velate, delle ere antichissime. Non saprei dire se quel costume era un moto inconsapevole di rivalsa, oppure se è da leggervi la persistenza di un altro tempo. Enos, credo dicano lettere sbilenche giù, nella casa degli avi, enos lases iuvate. Molto tardi, ho dovuto apprendere che il tempo non è l’esattezza degli orologi, ma, come lo spazio, il dominio, fattosi carne e respiro, di chi, nelle varie epoche, decide la vita e la morte.
A essere sincero, non so neppure se Livia abbia concluso con noi il corso di studi. Quelli erano tuttavia per me giorni affannosi, appena ricordo le levate nelle ore buie. Mio padre veniva lieve dietro la porta, mi chiamava sottovoce. Certe volte, già sveglio, attendevo fino al richiamo. Poi la persi di vista, come il volo corto della potazzina fra le siepi di novembre.
Talvolta mi sono trovato a considerare, e immagino che sia una riflessione diffusa, come capiti di vivere condizioni che mai avrei immaginato mie. Nella parabola di una curva non puoi né rallentare, né deviare a tuo arbitrio, pena essere travolto. In quei momenti, quando ti volgi indietro, cerchi il punto d’inizio e l’origine delle incidenze, ti dici che avresti dovuto, ti spieghi con il caso. Ma la nausea, che presto puntualmente ti dà quel tentativo, ti ammaestra sulla presenza, per quanto invisibile, di padroni della vita e della morte, che lasciano te senza occhi e senza orecchi. Ho poi imparato che quello spossessamento non è immutabile, ma varia il suo grado da una generazione all’altra, da un luogo all’altro. Potente si è fatta negli ultimi tempi la sua spinta. Così mi guadagnavo a quel tempo il pane vagando di luogo in luogo, ogni volta cambiando volti e sguardi, che m’imparavo poi la sera, prima d’addormentarmi.
Ogni tanto ti sorprende il falso riconoscimento di qualcuno, per corrispondenze indefinite di espressioni o gesti, coincidenze che ti mettono alla prova e ti rassicurano. Mi salutò, infatti, un volto tra gli altri. Dopo qualche giorno incontrai lo stesso breve sorriso. Allora, per prudenza, chiesi a chi già meglio conoscevo, a più d’uno, senza esito, finché nella mia discreta inchiesta ricomparve un nome, Livia.
Nella donna che in mezzo alla corrente camminava vicino la parete, solo la pelle chiara del volto e delle mani, riuscivo a riconoscere. E forse gli occhi. Nello sguardo pacato, ma non severo, nel movimento della testa non fervido, ma di un’intima confidenza preclusa agli altri, che poteva apparire rassegnazione, intravedevo la Livia d’altri tempi.
Dovetti imparare come ogni discorso, con lei, presto diventasse franto. Restio, sembrava. Forse per timore di sentirsi impropriamente in mezzo alla scena, o semplicemente per disinteresse; non saprei dire. Negl’impegni comuni che capitarono, la osservavo starsene silenziosa e paziente. Non si tirava mai indietro da qualunque dovere le fosse presentato, con la medesima naturalezza. Poiché non mancò chi se ne approfittasse, una volta non potei non dirglielo con calore. Sollevò lo sguardo dal suo libro appena sorpresa. Mi sorrise, non so se di gratitudine o per consolarmene.
Qualcosa, lo vedo ora, di quel suo modo risuonava dentro di me. Sempre, nella mia vita, mi ha accompagnato un istinto di lontananza da quello che i cristiani chiamano “mondo”, il desiderio della meditazione profonda, del profumo dei boschi. Epperò, come una spina, m’assale il conoscere di quanto sudore e strazio sia quel profumo di terra e foglie. So, ed è stato per sempre, che nel condursi semplice della vita ogni meditazione è negata, perché qui si è costretti a renderla possibile per pochi altri. Così ho compreso l’impasto crudele e a tratti feroce in cui, in questo tempo buio, è chi vuole che quella moltitudine anonima si prenda i suoi diritti, ma per farlo deve trarsene fuori. Scrivo e vi scopro lo sgambetto dell’ottimismo. Me ne risveglia la truce morte per acqua e di sabbia - invisibile, anzi invocata -, la dolente umanità abbandonata sulle nostre scale. Me ne rammenta la beffarda condizione nelle nostre stanze: l’odierna liberazione del tempo si capovolge nel legame servile di chi cerca lavoro e dei pochi aggiogati a ritmi disumani. Radice terragna questa della celeste ricchezza di pochissimi, cime dove essa risale sempre più rigogliosa dalle mille contrade della terra.
Nulla potei chiedere a Livia di sé, se avesse famiglia, con chi e dove vivesse, né da altri, cui ogni tanto domandavo, seppi. Il giorno del suo congedo, fu altra persona ad annunciarlo. Livia, che sempre aveva voluto esserci il meno possibile, era rimasta altrove.
Nessuno se ne era accorto.
29 agosto 2017
Il testo qui di seguito presentato è comparso sull’ “Indice” di luglio-agosto 2017. v.a.
Dall’oscurità del senso
Su Reificar di Tommaso di Francesco
Forse l’accesso migliore all’ultima raccolta di Tommaso Di Francesco è il sottotitolo: Vicenda silente. Perché indica discretamente due verità. Mostra che la voce pubblica dell’autore, condirettore del manifesto per di più dalla responsabilità della pagina internazionale, trascina con sé un ‘resto’, un’eccedenza e insieme registra che la poesia di Di Francesco germina in una zona notturna.
Se guardiamo alla materia, i testi compongono frammenti di memoria familiare, schegge di fatti di cronaca, tessuti della cultura. Intense le figure della madre alla morte del padre (Quando nella lamiera il padre fu ferito), dell’“edile dolce zio Santino”, che l’incidente sul lavoro “da parte lo faceva e pazzo”. Straziata e bellissima quella della figlia, che ha imparato “a non truccare il taglio lacerato / di lame l’amore nelle carni”. Niente, tuttavia, d’intimistico. Di Francesco è spinto alla pagina poetica dallo stesso furore morale, dalla stessa energia interrogativa che detta quella, circostanziata e vigile, del giornalista.
Il fatto è che il lavoro diuturno di cercare per poi portare allo scoperto i legami sotterranei e, peggio, occultati, contraffatti, rimossi nello spolverio apparente di mille morti e violenze, deposita nell’animo del poeta tutto il dolore del non riuscito, dell’inerte, dell’incomponibile, dell’impotenza. È esattamente da questo terreno oscuro e fermentante che muove il secondo scatto, quello poetico, perché la forma propria della parola poetica soccorra, nella sua strada obliqua, verso un orizzonte di senso, conceda il suo pharmakon ai cancellati, tenga viva, nella sua finzione, l’azione necessaria quanto non ancora, o non più, possibile. Si vuol dire che la difficoltà interpretativa di questa poesia non è né programmatica, né discende da qualche sacralità della parola o del poeta: è bensì un dato bruto e brutale, l’origine della sofferenza (“sogno che sia il sogno / dentro di noi incarnato / a reificar condannato”). Reificar è appunto il titolo preposto, sul quale Giorgio Luzzi apre la sua Prefazione: “può ricordare Trasumanar e organizzar di Pier Paolo Pasolini, con quel dantismo che li accomuna nel suono”, autore che Luzzi non lascia cadere per caso, essendo di Pasolini l’avallo all’esordio del giovane Di Francesco.
Il frequente procedere per accumulo di variazioni lessicali intorno a uno stesso grumo semantico, variazioni niente affatto sinonimiche, ma slogate in ardue relazioni analogiche (si veda, tra i tanti: “male”, “derma”, “ombre”, “innesto”, “timbro”, in È derma il male dei versi e mille) ha un che di ansioso, è il segno della fatica, è pura espressione del corpo a corpo ingaggiato nel tentativo di arginare, se non vincere l’oscurità del senso, essendo quest’ultima il punto di partenza subito, non l’arrivo cercato. D’altra parte, che la voce poetica miri alla concretezza soda (a questo vuole piegare il titolo, la nota d’Autore: “i versi hanno avuto per me l’urgenza di farsi cose, di inverarsi, da qui reificar”), è testimoniato dalla lingua di tutti i giorni, persino non sdegnosa di venature romane, irta però di consonantismi e forzata qua e là dai neologismi. Non è di diverso segno la compostezza ritmica, spesso disposta in partiture endecasillabiche o ricondotta a misure doppie.
In Reificar compare, infine, sotto forma di omaggio al poeta Attilio Lolini, l’altro versante della poesia che Di Francesco ha frequentato assiduamente, dove l’autore sospinge la sua urgenza morale e l’esercizio critico alla brevità gnomica dell’epigramma, ora severa, ora giocosa.
14 luglio 2017
MATTINO
La lista è compilata
le stanze sono in ordine.
Dalla luce della terrazza
solo il brusio folto del pioppo: urta
il fragore irto di strada.
Il mare è lontano.
Nella cura mattutina, mentre ti attendo
scruto, non visto, il breve tremore.
E ascolto, amore, come fosse stamane
i decenni passati
stringendoci per mano.
17 giugno 2017
CONGEDO
Alla 5^ B
Insegnare è un lavoro stupendo, che a volte, senza saperlo e volerlo, miracolosamente diventa reciproco. In quei momenti, come accade all’arte, accenna a un bisogno antropologico che da qualche parte attende ancora di diventare realtà. Una spinta confusa ma caparbia che nemmeno la società barbarica assegnata in sorte al nostro vivere riesce a annichilire, per quanto questa ci voglia tutti vittime o carnefici. Ascoltatelo sempre, ragazzi, perché, come dice un canto glorioso e dimenticato, è quello il futuro dell’umanità.
Fate quello che potete, rubate spazio all’impossibile.
Vi abbraccio forte
9 giugno 2017
Questo testo, intervento al convengo Attraverso Fortini. Poesia educazione mondo, Roma – Dipartimento di Scienze della formazione, Roma Tre, 9 maggio 2017, è apparso anche in Officina dei Saperi v.a
http://www.officinadeisaperi.it/antologia/dopo-fortini-diario-di-un-insegnante/
DOPO FORTINI
Diario di un insegnante
Giustificazione
Come dichiara il titolo, il mio intervento ha un’ambizione particolare: non vuole chiudersi in uno sguardo approfondito sull’operato intellettuale di Fortini, ma gioca le sue carte nel tentativo, magari spericolato, di verificare quanto, non dico del mio, ma del mestiere d’insegnante, così come si è andato configurando negli ultimi trent’anni, si discosta dalle riflessioni fortiniane o si rapporta con esse. Proverò a procedere in maniera obliqua. Attraverserò l’opera di Fortini per rintracciarvi le postazioni da cui traguardare alla mia esperienza pluridecennale, avvalendomi anche della testimonianza di suo studente. Se qualcuno ora mi obbiettasse l’intrinseca debolezza di uno sguardo così soggettivo, non saprei che replicare. Potrei solo allegargli, a mio parziale conforto, un’antica pagina del nostro autore, ribadita per altro in decenni successivi, fino alla vigilia della sua scomparsa:
"La pagina e l'intenzione critica, mossa dapprima verso l'Oggetto, il pubblico, il discorso (come si usa dire) «verificabile», piegano verso il diario, la confessione; il pretesto dunque. Le memorie nel manoscritto, l'oltretomba nella bottiglia. […] Non rimane se non la speranza, davvero non infondata, che malgrado tutto alcune delle nostre lettere di prigionieri, scarabocchiate sul retro di falliti piani d'operazioni o di progetti di fortificazioni travolte, qualora siano lette da tutt’e due le parti del foglio, testimoniano d’una verità obiettiva che non si sapeva, o quasi solo in sogno si sapeva, di possedere" [1].
La scuola è meglio della merda
L’attenzione di Fortini è stata costantemente rivolta ai temi letterari, politici e culturali – nei loro aspetti teorici e pratico-organizzativi – in forte presa con le emergenze del presente, da cui traeva le domande che sentiva perentorie. Era da tale allarme del presente – confessato come ossessione minacciosa [2] - che egli guardava i suoi vasti interessi culturali europei. Si tratta di una disposizione che declina da un’assai illustre genealogia illuminista e romantica, dal marxismo affinata e rinnovata. Il lettore del nostro intellettuale sa che in lui permanente è stato lo “spirito di scissione”, per dirla con Gramsci, insieme con, anzi consustanziale alla spinta pedagogica e parenetica, tanto nella produzione saggistica, quanto in quella poetica, in vista dell’abolizione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Per cui lungamente si è occupato dei temi della diffusione, oltre che della produzione, della cultura, tanto che forse uno dei suoi ultimissimi scritti, sul letto di morte, si può dire, essendo una lettera datata 5 novembre 1994, a ventitré giorni dalla scomparsa, è una dura dichiarazione che addita nel giornalista lo strumento del dominio e il soggetto possibile della ribellione:
"Chi finge di non vedere il ben coltivato degrado di qualità informativa, di grammatica e persino di tecnica giornalistica nella stampa e sui video, è complice di quelli che lo sanno, gemono e vi si lasciano dirigere. Come lo fu nel 1922 e nel 1925. […] Lungo canali di storica vigliaccheria mascherata di bello spirito i colleghi della comunicazione stanno giorno dopo giorno cambiando o lasciando cambiare i connotati dei quotidiani; in attesa che se ne vadano quei pochissimi direttori che non hanno già concordato o “conciliato”. […] Anni fa scrissi, enfaticamente, che il luogo del prossimo scontro sarebbero state le redazioni. Quel momento è venuto, il luogo è questo".
Dico cifra “permanente” della produzione fortiniana, perché essa è ben presente tanto nella poetica, in cui campeggia l’affermazione che “la poesia, anche quella della rivolta, canta sempre alla tavola dei potenti” [3], quanto nel contrappuntismo in cui vive la sua parola poetica; quanto infine nel versante critico e saggistico: “oggi – scriveva a metà degli anni Sessanta - la condizione di ‘emigrato interno’ è l’unica condizione possibile dell’intellettuale che non abbia rinunciato alla prospettiva socialista” [4]. Per tutto l’arco del percorso di Fortini, la mossa d’avvio è stata tenere aperta la strada della negazione: ora, quando le circostanze storiche erano o sembravano più favorevoli alla dialettica sociale, rivendicando “il conflitto tra intellettuali-politici e politici-intellettuali”[5], ora, allorché la critica è sentita “pressoché inesistente e impossibile”, opponendo comunque un saggismo “che quasi tende a coincidere col diario intellettuale”[6].
Proprio perché il nostro autore si muove nella marxiana prospettiva comunista, la sua azione antiborghese non ha mai escluso né la spinta ad un agire collettivo, né l’intento, come si diceva, pedagogico e parenetico. Anche in tali aspetti l’assillo del presente sospinge Fortini a una continua loro verifica, magari amara, ma non a una sconfessione. Scrive nel 1951:
"La meta ci pare che sia quella della preparazione di un nucleo di scrittori-critici, capaci di mediare le opere letterarie fino alle più remote parti del corpo culturale della nazione e di ritrasmettere quegli impulsi che sono la replica creatrice dei pubblici" [7].
Nel 1981, a Mirella Serri che gli chiede a chi egli parlasse a quel tempo, risponde:
"Francamento non te lo so dire […] uno come me che si trova davanti alla questione di sapere che cosa è stato, che cosa ha fatto, corre il rischio di ritrovarsi nel proprio piagnisteo, cioè di dire guarda un po’ forse quello che tu avresti voluto era di essere inserito in un gruppo, di non essere da solo" [8].
Dico subito che la sottolineatura inquieta ed esplicita, compiuta da Fortini, del valore pedagogico di chiunque parli a qualcun altro ma al grado più alto in chi parli da qualche ruolo, assume particolare funzione disvelatrice oggi che le massime autorità, coloro che decidono la vita e la morte di milioni di persone, fingono di parlarci come l’uomo della porta accanto.
Risulta chiaro, dunque, che al nostro assunto, nella sua forma più ampia, si offre, si può dire, l’insieme della produzione fortiniana. Sceglierò pertanto solo dal materiale più direttamente didattico-pedagogico e, aggiungo, in modo rapsodico, costretto da ovvi motivi di spazio.
Nel 1965 esce un’antologia divulgativa con un’ampia selezione di filosofi, storici, economisti, politici europei, asiatici, africani, americani. Due elementi sono in essa rilevanti. Sul versante del discorso condotto da Fortini, ossia nella scelta e nella presentazione del materiale, è ben visibile la spinta contrappuntistica con l’intento, francamente indicato al lettore, di tenere aperta la porta al conflitto, alla negazione del discorso dominante:
"Questa antologia non parla – o solo indirettamente – delle forme aperte del conflitto storico: ma su quel conflitto è tutta imperniata. Contro il cinismo, pretende già compiuta una scelta che non si usa quasi più compiere o rinnovare. L’obiettività eventuale è nella sua parzialità" [9].
Sul versante del destinatario, è sottolineata altrettanto esplicitamente l’appartenenza di autore e lettore alla medesima condizione sociale e culturale:
"Questa antologia si rivolge a quella parte di ciascuno di noi che nella ricerca e serietà specialistica ama la serietà della ricerca senza credere all’ideologia dello specialismo […] l’antologia usa i testi (e, in una certa misura, li interpreta) avendo di mira come lettore quel medio uomo europeo e italiano cresciuto nella media civiltà capitalistica e mediamente informato; quella parte di ciascuno di noi che è sotto l’intimidazione capitalistica" [10].
In altre parole, la funzione pedagogica di Fortini non comporta affatto e, direi, da subito il recupero di una posizione privilegiata dell’intellettuale -posizione che il comunismo terzointernazionalista aveva invece mantenuto- ma si esercita prima di tutto su se stesso accomunato agli altri. Si noterà di passaggio che questo è il nucleo fermentante del celebre Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, di due anni più tardi: il punto profondo di divergenza di tanta parte del cosiddetto marxismo critico postbellico, la ragione del ritiro della delega ad altri, ovvero al partito, del giudizio politico.
Ventitré anni più tardi, il ricco materiale fortiniano ci consegna, nella forma negativa, un’affermazione identica, per quanto paia contraddirla relativamente al passato:
"Oggi non puoi avere verso l’incolto, il negoziante senza cultura, l’operaio senza studi, l’atteggiamento di venti anni fa, di quello che va a portare i lumi, perché consumi anche tu gli stessi prodotti, la stessa spazzatura" [11].
Spostando lo sguardo dal lettore extra e postscolastico a quello scolastico, troviamo non sorprendentemente le medesime coordinate. È del 1968, quando Fortini insegnava da cinque anni negl’istituti secondari, un’antologia per il biennio delle scuole, allestita con Augusto Vegezzi. Nella brevissima presentazione ci si attribuisce il medesimo compito di sollecitare insegnanti e alunni a una posizione critica, conflittiva:
"Si è inteso soprattutto fornire la possibilità di intendere […] come i temi del presente investano drammaticamente la vita dei popoli e non consentano rifugi o evasioni; come la voce dei poeti, la rappresentazione dei narratori, l’argomentazione dei pensatori e degli uomini di scienza convergano da due secoli, attraverso conflitti e lotte […] la dichiarata prospettiva ideologica preferisce, quando necessario, far ascoltare la voce severa, magari dura, di un autore “difficile” piuttosto che cullare il discepolo (e l’insegnante) in fantasie di facile concordia progressista." [12]
L’approccio non cambia se dal campo dei propositi, ci portiamo nella descrizione fortiniana della scuola, intesa nella sua molteplice realtà. Si veda, per esempio, il giudizio, datato 1976, sull’editoria scolastica e sulla qualità della manualistica, di cui si denuncia con asprezza l’insipido ecumenismo:
"L’editoria scolastica sfrutta la vena interdisciplinare e i temi dell’attualità […] In luogo di informare sull’esistenza e funzione delle maggiori discipline che a scuola non s’insegnano, si dispongono assaggi da Freud, Einstein, Lévi-Strauss o Chomsky; non le pagine dove hanno scritto il meglio, ché per intenderle si vuole aver dimestichezza con le loro materie, ma quelle di sintesi o di idee generali. Del sapere così omogeneizzato e senza fibre residuerà nella testa dello studente la ciarla culturale" [13].
In una precedente lettera ai propri studenti, del 1971, documento straordinario per la testimonianza di un clima generale oltre che per lo sguardo in presa diretta sul Fortini insegnante, scrive: “La scuola nella quale vivete non vi dà quasi nulla di quello di cui avete bisogno e diritto” [14]. Di grande interesse è comunque il giudizio ivi contenuto sulla scuola di massa nata con la riforma della Scuola media unica del primo governo di centro sinistra nel 1962. Leggiamolo per intero:
"La contestazione globale ha condotto soltanto ad aprire il terreno, a fornire la giustificazione politica alla riforma guidata dal moderno capitalismo e gestita dalla Democrazia Cristiana e dai suoi alleati, con l’appoggio del Pci. Oggi appare chiaro che il movimento degli studenti ha solo accelerato un movimento di dissoluzione che era cominciato senza di loro e che -come in Usa e altrove- rientra perfettamente nei piani dello sviluppo capitalistico o almeno ne è la conseguenza. La dissoluzione della vecchia scuola classista, umanista, elitaria, fondata sullo studio e sulla disciplina (una scuola che voi non avete conosciuto) era già prevista dalla istituzione della Media Unica, era già scritta nell’aumento della popolazione. Gli studenti sono stati gli enzimi necessari alla velocità della dissoluzione. La prova sta nel fatto che la distanza fra chi studia o può studiare, chi sa o può sapere, chi dirige e dirigerà, chi sarà incluso nella riproduzione dell’insegnamento e chi meno è aumentata [15].
Due sono gli elementi rilevanti del passo: il giudizio sulla nascita della scuola di massa che, in termini gramsciani, potremmo definire di “rivoluzione passiva” e il connesso effetto omologante dell’istruzione. Si tratta, come si diceva, di un aspetto fondamentale dello sguardo di Fortini, da cui nasce la necessità di ciò che ho sopra indicato con l’espressione “spirito di scissione”. Va detto, per non indurre nell’equivoco, che nel nostro autore l’apertura al negativo non approda mai alla sua separatezza -genesi della depressione nichilista o del cinismo maniacale-: la negazione è sempre determinata. Per questo può senz’altro proclamare che “qualunque immediatezza è, senza possibilità di dubbio, reazionaria”[16]. In una noticina a uno scritto dello stesso periodo, leggiamo un appunto fulminante contro la figura oggi sbandierata con orgoglio da governi e gazzette ufficiali:
"Si è visto quale naufragio gli apologeti della immediatezza abbiano fatto là dove la questione si è posta come problema della scuola e dell’insegnamento, della parola e della ratio studiorum. E come miseramente abbiano ripiegato sull’estremo opposto, d’altronde perfettamente coincidente con tanta didattica americana e sovietica e con non poche aspirazioni ministeriali italiane: il docente come ‘esperto’"[17].
Ma è necessario tornare al passo citato dalla lettera ai suoi studenti e precisamente là dove Fortini sottolinea che la scuola di massa ha portato non, come vorrebbe apparire, all’emancipazione, bensì all’aggravamento della distanza tra chi sa e chi non sa, tra dirigenti e diretti, tra classe dominante e classi subalterne. Ebbene, che le dicotomie (“chi studia o può studiare”, ecc.) vadano intese come dicotomie interne alla scolarizzazione e non tra inclusi ed esclusi da essa è confermato, tra i tanti passi, da un’assai esplicita dichiarazione del medesimo periodo:
"L’ordine tardocapitalistico vuole bensì la scuola per tutti ma perché tutti, convenientemente sottoeducati, possano essere consegnati alla selezione extrascolastica e al sottoimpiego nella produzione". [18]
Che posizione prende allora di fronte a chi, don Milani, nel pieno del ribollire degli anni Sessanta, mette energicamente a fuoco la frattura tra coloro che padroneggiano la cultura e chi ne è espulso? Intendo quella Lettera a una professoressa, accolta da Fortini e Vegezzi nella loro antologia, nel cui “cappello” introduttivo a due brevi passi si legge “libro provocatorio e polemico […] che esamina criticamente la scuola […] dal punto di vista dei bocciati a scuola, cioè degli esclusi, dei subalterni nella vita” [19].
Su questo libro Fortini interviene con due scritti dedicati -uno a caldo, un altro a distanza di oltre vent’anni- e un passaggio in un’intervista ancora più tarda. Ai fini del nostro discorso, è sufficiente prendere in considerazione il primo intervento, perché quanto lì espresso non viene successivamente modificato.
"Il primo fatto significativo della recensione è lo scarto dal tema della selezione classista. Il fulcro del ragionamento di Fortini è la natura religiosa e im-mediata dello scritto, piuttosto che l’espulsione classista da esso denunciata. Rivelatore diventa poi il passaggio sulle due opposte figure sociali del pluribocciato e del Pierino. L’insegnante Fortini assume entrambe le posizioni dell’ambivalenza. Ora della colpa: “è difficile valutare questo libro e l’opera di don Milani perché è difficile parlare sotto un indice teso” [20]. Ora della sfida:
"E non ho da vergognarmi del vecchio privilegio di Pierino che sa chi era quella ragazza greca [Antigone]: se per un verso gli esclusi, gli oppressi, oggi, proprio perché partecipano, non perché non partecipano delle conoscenze della borghesia, per l’altro verso i Pierini cresciuti, noi, insomma, non scontiamo solo la nostra colpa storica nei confronti del mondo ‘muto’ dei contadini con la cecità verso più della metà del mondo ma subiamo la strangolazione, l’immiserimento caotico, la falsificazione" [21].
Per quanto l’affermazione sia lasciata cadere sulla pagina quasi di sfuggita e quindi non ulteriormente argomentata, la lettera del discorso non lascia dubbi: “gli esclusi, gli oppressi” sono tali “proprio perché partecipano, non perché non partecipano delle conoscenze della borghesia”. Così liquidata la denuncia centrale della Lettera a una professoressa, il ragionamento torna all’argomento caro a Fortini, ovvero quello interno alla cultura e agli acculturati: “noi … subiamo la strangolazione, l’immiserimento caotico, la falsificazione”. Mentre il tema milaniano degli esclusi, “il mondo ‘muto’ dei contadini” è ricollocato nel sud del mondo.
Recinzioni
Il mio primo ricordo di Fortini insegnante universitario è la sua lettura della poesia, perché in quel modo ho compreso che cosa è il verso, il ritmo. Ho sentito come la parola possa caricarsi di forza emotiva dentro e oltre il suo tessuto, diciamo così, dicibile. Con lui ho cominciato a capire la complessità della comunicazione umana e perché l’opera letteraria possa essere avvicinata o addirittura, da alcuni, identificata con la vita.
Quando sono arrivato a Lettere, nella piccola città di Siena, la facoltà era nata da due anni. I pochi studenti non avevano tradizioni radicali, in compenso i docenti erano in gran parte giovani studiosi agguerriti, cosicché l’insegnamento che il campo culturale è, come altri, il campo dei conflitti politici, che inoltre e proprio per questo lo studioso non dovesse delegare ad altri il giudizio e l’azione politica non lo ricevetti per prima da Fortini. Né, in quell’onda lunga della scolarizzazione di massa da cui come un pesce fortunato ero condotto, ebbi davvero consapevolezza che essa potesse essere passeggera. D’altra parte, per sapere che la scuola è meglio della merda, non dovevo leggere Lettera a una professoressa, perché me l’avevano insegnato mio nonno e mio padre, fin da quando questi mi aiutava nel fango invernale verso la scuoletta delle elementari.
Per più di un decennio, considerato anche il precariato, il mio insegnamento ha cercato di praticare quanto avevo imparato negli studi universitari. I miei alunni erano i miei fratelli minori, che accompagnavo in quel processo ampio di emancipazione. Sentivo, o credevo di sentire, che il serio lavoro sul sapere e sulla critica del sapere fosse la forma specifica della politica dell’insegnante, dell’intellettuale-politico, per dirlo con Fortini, ovvero la messa in pratica di quel rifiuto della delega e degli specialismi che erano al fondo della mia educazione sentimentale. Del resto, né il mio insegnamento avveniva nel vuoto, potendo beneficiare dell’azione di movimenti politici, di organizzazioni sindacali nei quali gl’insegnanti trovavano modo di confrontarsi e di agire su temi e terreni non settoriali; né, analogamente, i miei studenti erano privi di loro sedi collettive. In altre parole, in quegli anni l’asse della mia pratica d’insegnante rimaneva quella osservata sopra nel discorso fortiniano.
L’orientamento culturale principiò a cambiare già agl’inizi degli anni Novanta, allorché le sinistre storiche europee, compresi gli eredi del partito comunista italiano, presero a farsi sostenitrici della necessità di diminuire –“razionalizzare”, si usava dire– l’intervento dello Stato nei servizi, oltre che in generale nell’economa. La sconfitta politica e culturale della sinistra emerse in quegli anni in modo violento. Nel dibattito culturale la critica al sapere fu sostituita dalla critica al costo del sistema pubblico dell’istruzione e della ricerca. Il brusco salto verso una posizione solo difensiva dette nuovo rilievo a voci come quella di Tullio De Mauro, che sempre aveva domandato attenzione prima alla mancata scolarità, poi al grave tasso di analfabetismo funzionale. È diventato via via più evidente, sebbene non necessariamente osservato, che il “mondo muto” degli esclusi non è solo quello contadino del sud del mondo, ma quello che cresce ogni giorno nelle nostre regioni. Sono i lavoratori precari, i giovani che non studiano né lavorano, è la massa ingente di chi è costretto alle mille forme delle moderne corvées, quando non alla semplice schiavitù.
La vera svolta pratica, per quanto riguarda il sistema dell’istruzione, è costituita dalla legge sull’autonomia scolastica di Luigi Berlinguer, ministro dal 1996 al 2000. Il furore ideologico, proprio dei ‘convertiti’, con cui gli eredi del Pci accusarono di statalismo –usato come sinonimo di dogmatismo e parassitismo– la scuola pubblica non fu altro che l’applicazione specifica del generale processo di appropriazione privata e di sottomissione al profitto con cui il capitale si svincolò in quegli anni dal compromesso keynesiano del secondo dopoguerra. Nella mia pratica d’insegnante mi è via via divenuto sempre più chiaro sia che i miei fratelli minori restavano fuori della porta, sia che gli alunni rimasti in classe parlavano un’altra lingua e non per ragioni anagrafiche. Tale situazione si era venuta creando tanto per il deperire, all’esterno della scuola, delle forme associative che consentivano uno sguardo complessivo, quanto per lo sbriciolarsi negl’insegnanti – in conseguenza delle nuove condizioni materiali e ideologiche - della spinta ideale e della forza contrattuale che consentivano uno sguardo critico sulla cultura e sul proprio insegnamento. Ma più ancora ha contato il consumarsi del tempo scuola e persino del semplice tempo dell’insegnamento, cui si è assistito con moto accelerato fino agli ultimi, dirompenti esiti della riforma renziana. Si pensi che la cosiddetta alternanza scuola-lavoro comporta obbligatoriamente una sottrazione di 200 ore nel triennio, ovvero circa 40 giorni scolastici, cui vanno aggiunti orientamenti, progetti, uscite: il tempo della lezione, interrotto e frastagliato, diventa in certe situazioni semplicemente un sostrato.
Naturalmente, allo sbriciolarsi dell’azione didattico-pedagogica dell’insegnante, non corrisponde una qualche altra continuità d’intervento, bensì il sedimentarsi pulviscolare di mille altre suggestioni ed estemporaneità, con la conseguenza di produrre due diversi esiti connessi. Al velocizzarsi delle procedure dell’insegnare, che mutilano irreparabilmente il tempo d’apprendere –per non parlare della relazione discente-insegnante, con ciò che a essa è connesso in termini di interiorità dell’adolescente in formazione-, risulta razionale ed efficiente la riduzione dell’insegnamento ad addestramento. Tutto il polverone pedagoghese sull’insegnamento per competenze ne è frutto e manifesto ideologico, cosicché la trasformazione dell’insegnante in “esperto”, che Fortini vedeva nel 1971, oggi è perseguita con forza dalla politica sia comunitaria che italiana e brandita dai gazzettieri.
Ovviamente tutto ciò obbedisce a una logica ben più ampia, dalla quale in buona misura la trasformazione scolastica dipende. Chi, come David Harvey, ha indagato con acume la determinazione storico-sociale delle coordinate spazio-temporali ci fornisce una sintesi feconda delle loro trasformazioni secondonovecentesche:
"È stimolante, per esempio, pensare al 1968 come a un tempo «esplosivo» (in cui comportamenti assolutamente diversi furono improvvisamente considerati accettabili) che emerse dal tempo «ingannevole» del sistema fordista-keynesiano e lasciò poi il posto alla fine degli anni Settanta al mondo del «tempo in anticipo su se stesso», popolato da speculatori, imprenditori e capitalisti che fanno commercio di debiti" [22].
E ancora più interessante la conclusione cui la sua ampia indagine arriva sulla tendenza di lungo periodo del sistema economico-sociale del capitalismo:
"La storia del capitalismo è stata caratterizzata da un’accelerazione nel ritmo della vita, con relativo superamento delle barriere spaziali che il mondo a volte sembra far precipitare sopra di noi […] Mentre lo spazio sembra rimpicciolirsi fino a diventare un «villaggio globale» delle telecomunicazioni e una «terra-navicella» di interdipendenze economiche ed ecologiche […] e mentre gli orizzonti temporali si accorciano fino al punto in cui il presente è tutto ciò che c’è (il mondo dello schizofrenico), dobbiamo imparare a venire a patti con un travolgente senso di compressione dei nostri mondi spaziali e temporali". [23].
Vandana Shiwa, assumendo a paradigma l’appropriazione privata delle terre comuni nell’Inghilterra dei secoli XVI-XVII, ha parlato di “recinzione” per indicare la modalità permanente del capitalismo nella sussunzione al profitto privato dei beni comuni [24]. Ripensando al mio percorso d’insegnante, mi appare sufficientemente chiaro, perché oggi venuto meno, il presupposto tacito della mia pratica e delle riflessioni fortiniane: la diffusione del mercato culturale e la scolarizzazione di massa erano implicitamente dati per acquisiti. La potente espansione dei “trenta gloriosi” ha giocato un ruolo decisivo in tale nascondimento [25]. Il fatto è che se – per dirla sbrigativamente – la rivoluzione d’Ottobre in Oriente e il compromesso keynesiano in Occidente avevano accresciuto il potere del lavoro, comportandone l’accesso alla scuola e alla cultura, la restaurazione finanz-capitalistica, come l’ha chiamata Gallino[26], ha riportato il lavoro alla condizione ottocentesca di pura merce, per di più in eccesso, date le nuove forme della produzione, tale per cui il capitale giudica spreco inutile e dannoso ogni investimento sociale, ivi compreso quello della scolarizzazione e della cultura di massa.
Quando parlo di “recinzione” della cultura e del sapere, così come delle relative loro istituzioni pubbliche, non intendo semplicisticamente né solo l’espulsione pura e semplice dei ragazzi dalla scuola, né solo il passaggio in mani private delle scuole. Il capitalismo sa percorrere strade più sofisticate, duttili e profittevoli, che vanno dalla perdita di qualità dei processi scolastici, all’uso privato delle strutture pubbliche, con tutte le gradazioni possibili da un’area geografica all’altra, da un ambiente sociale all’altro. Ciò che rimane sostanziale è la divaricazione crescente tra uno strato sempre più esile, dove si concentrano conoscenza e potere, e la grande maggioranza, dove povertà e danno di credere di sapere si fanno sempre più oppressivi. Una dinamica spietata nell’immediato e sciagurata nel medio periodo, che la sbandierata linea politica, di premiare i poli di eccellenza con risorse aggiuntive tolte per ammenda ai mediocri, naturalmente incrementa.
Può essere utile alla comprensione del fenomeno, indicare sommariamente la grammatica che lo alimenta. L’autonomia degli istituti è stata prima di tutto diminuzione drastica della distribuzione delle risorse dal centro ai singoli istituti per un verso e blocco stipendiale del personale scolastico dall’altro. D’altra parte, l’autonomia ha esteso agl’istituti scolastici quel fenomeno generale che ha caratterizzato i processi organizzativi propri del capitalismo negli ultimi decenni. Se l’automazione informatica ha reso possibile la decentralizzazione e la delocalizzazione di intere fasi produttive, l’accentuarsi del comando centralizzato, reso possibile da quelle tecnologie e necessario al controllo capitalistico di pochi, ha comportato un’enorme escrescenza delle procedure burocratiche, in perfetta antitesi con le promesse ideologiche neoliberiste di snellimento e sburocratizzazione che il privato garantirebbe contro l’elefantiasi dello stato [27].
Da queste premesse, ne è derivato non solo un aumento progressivo e diventato considerevole delle procedure burocratiche dell’insegnante e dell’insieme della struttura scolastica, ma anche un impegno aggiuntivo per l’approntamento di “progetti didattici” con lo scopo di recuperare, attraverso di essi, le risorse all’istituto non più garantite e ottenere qualche integrazione, con lavoro aggiuntivo, allo stipendio del personale, rimasto senza contratto dal 2008. Si aggiunga a questo il fatto che uno dei parametri per la distribuzione delle risorse agl’istituti è il numero di iscritti. Ne consegue immediatamente che l’autonomia ha comportato l’apertura della concorrenza tra scuole a tutti i livelli, dall’asilo nido al liceo. Tali semplici fattori hanno reso ‘razionali’ alcune violente distorsioni. Mi limito a indicarne due.
La prima. Il personale insegnante più motivato e dinamico sposta la sua attenzione, le sue energie dall’insegnamento alla organizzazione e al funzionamento dell’istituto (non potendo smette di insegnare, calibra diversamente i suoi impegni). La conseguenza già visibile e certamente destinata ad accentuarsi è che nelle scuole si struttura una massa di ‘solo insegnanti’, meno pagati, di poco prestigio, spesso a disagio con il proprio mestiere, a fronte della quale si separa la ristretta cerchia dello staff, costretto a pagare lo scarso vantaggio economico con un’impressionante saturazione dei tempi di lavoro e con lo stress del comando del capo d’istituto. La mancetta che la riforma di Renzi prevede per gli ‘insegnanti meritevoli’ conferma pienamente la dinamica: i “meritevoli” sono invariabilmente chi fa altro che insegnare. Non è infrequente incontrare dirigenti d’istituto affermare esplicitamente che degl’insegnanti che la mattina vanno in classe e fanno lezione non sanno che farsene.
Secondo. I progetti aggiuntivi – il cosiddetto arricchimento dell’offerta formativa – non seguono l’iter di buon senso: riscontro un bisogno formativo, elaboro un progetto, ottengo il finanziamento. Ma lo capovolgono. Siccome l’istituto deve vendersi nella concorrenza delle iscrizioni e inoltre deve trovare finanziamenti, si mette un insegnante dello staff alla ricerca dell’argomento o della trovata organizzativa più accattivante, che costi poco o abbia suoi finanziamenti, un altro alla costante disamina dei progetti ministeriali ed europei che promettano soldi, si sceglie, si elabora il progetto (fasi queste, tutte molto tecniche e laboriose, di forte specializzazione che non permettono quindi un facile ricambio) e finalmente si scarica sul tempo scolastico. In questo modo i ‘solo insegnanti’ si trovano di fronte a un tempo d’insegnamento sempre più invaso, provvisorio, interrotto. Anche per questa via, la massa dei ‘solo insegnanti’ e la loro opera perdono valore agli occhi e quindi al comportamento pratico di studenti e famiglie.
È questo il tessuto concreto in cui discenti e insegnanti oggi s’incontrano, una trama di attività mordi e fuggi, in cui il vincolo ‘oggettivo’ dei tempi obbliga alla definizione invece che all’approfondimento, alla settorialità minima invece che alla connessione, al test invece che al colloquio, al quesito a domanda singola con risposta su sei righe, invece che all’elaborato. Così non solo si evita che l’insegnante abbia qualcosa da dire sul mondo chiamandolo a una funzione di esperto, ma a forza d’impoverirgli tempi e modi lo si costringe alla posizione dell’addestratore.
Non posso non ricordare che qui si è parlato solo del sistema scolastico, ovvero di quel settore dell’istruzione minimamente essenziale. Assai più grave è la condizione dell’università e della ricerca, come numerose, anche se estemporanee e inascoltate denunce testimoniano, settori dove si assommano sia aspetti strutturali analoghi a quelli qui richiamati, che gli effetti a cascata delle condizioni prodotte dal sistema scolastico.
La linea del conflitto, dunque, come una fatica di Sisifo, pare tornata a essere quella ottocentesca del diritto all’alfabetizzazione, così come del resto, più in generale, ci si trova di nuovo a lottare contro il lavoro servile e contro la disoccupazione di massa, segni estremi e non marginali della riduzione del lavoratore a mero strumento. Ma né la scolarizzazione di massa è passata invano, né la Rivoluzione d’ottobre, malgrado tutte le rimozioni, è stata una parentesi. Si tratta oggi, per riprendere un’espressione da Fortini impiegata per i processi storici, di “soffrire più in alto” [28], ovvero di sapere e praticare una nuova radicalità, che unisca la richiesta che muove dal ‘grado zero’ del non sapere e del non essere con la memoria della pratica costante e immanente della critica, del conflitto. Nel caso del mestiere d’insegnante, si tratta di operare contro l’espropriazione del diritto alla conoscenza -che, come si diceva, colpisce sia il discente che il docente-, al contempo praticando, a ogni tappa, la critica allo stesso sapere acquisito, contro, come ci ha insegnato Fortini, “la strangolazione, l’immiserimento caotico, la falsificazione”. Non si è in grado di dire quando e come una tale ripresa di parola da parte di discenti e docenti avverrà, ma una cosa mi pare di poter affermare con sicurezza: se è un’azione che non può essere compiuta in solitudine, ciascuno deve sapere che è sua responsabilità diretta, nella consapevolezza che nessuna delega è più decentemente esigibile da nessuno, riprendendo il discorso là dove Fortini e il meglio della riflessione teorica degli anni Sessanta l’avevano portato.
[1] Otto domande sulla critica letteraria in Italia, in “Nuovi Argomenti”, VII, 44-45, maggio-agosto 1960, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a cura di Velio Abati, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p.29.
[2] “C’è un altro episodio sconvolgente che ritorna spesso nella mia mente: un incontro avuto a Milano dopo una notte di bombardamenti, mentre ero in servizio di ordine pubblico. Nella strada deserta, tra le case fumanti, una donna, che da lontano era parsa estremamente gradevole, si dirigeva verso di me con un libro in mano, un classico, un greco antico. Era un'intellettuale, una bibliotecaria, e ai miei discorsi proiettati verso quello che stava per accadere (eravamo tra la caduta di Mussolini e l'armistizio), verso il domani, mi rispose con decisione e tranquillità: «Lei è una persona tesa continuamente verso il futuro, ma finché non supererà questo, non farà mai niente». Ci siamo lasciati così e io ho sempre pensato che sia stata una specie di allucinazione, di visione... Io ricado continuamente verso la tentazione o la speranza di dare un senso al presente”, Saveria Chemotti, Fra miele e veleno l’utopia del futuro, in “Il Mattino di Padova”, 5 luglio 1987, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.475.
[3] Francesco Gambaro, Un fiero narciso con” il vizio della speranza”, “L’Ora”, 29 marzo 1992, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.635.
[4] Franco Fortini, Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, in Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1965, p.170.
[5] Franco Fortini, Intellettuali, ruolo e funzione, in Questioni di Frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965-1977, p.73; il testo è datato 1971.
[6] Rocco Capozzi, Di scrittori, di critici, oggi. Franco Fortini, “L’Immaginazione”, VII, 81, settembre-ottobre 1990, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.597.
[7] Franco Fortini, Per una critica come servizio, in Dieci inverni. 1947-1957, Bari, De Donato, 1973, p.91; il testo è datato 1951.
[8] Mirella Serri, Dialogo col profeta di classe, in “Pagina”, II, 13, ottobre 1981, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.295.
[9] Franco Fortini, Introduzione, in Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia di domani, a cura di Franco Fortini, Bari, Laterza, 1965, p.IX.
[10] Franco Fortini, Introduzione, in Profezie e realtà del nostro secolo, cit., p.VII.
[11] Neva Agazzi, Dalla scuola alla piazza. A colloquio con Franco Fortini, in “Cooperazione”, 5 maggio 1988, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit, p.514.
[12] Augusto Vegezzi, Franco Fortini, Ai colleghi e agli studenti, in Passato e Presente. Gli argomenti umani. Antologia per il biennio delle Scuole Medie Superiori, Napoli, Morano, 1969, p.5.
[13] Franco Fortini, Avanguardia e restaurazione, in Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984, Milano, Garzanti, 1985, pp.29-30.
[14] Franco Fortini, Su un caso disciplinare, in Tre testi su educazione e società, “L’ospite ingrato”, Macerata, VIII, 1 (2005), p.163.
[15] Franco Fortini, Su un caso disciplinare, cit., p.161.
[16] Marco Mauruzj e Donatello Santarone, Franco Fortini. Le catene che danno le ali, in “I Giorni Cantati”, I, 2-3, luglio-dicembre 1981, ora in Un dialogo ininterrotto, cit., p.301. Per questa struttura teorico-politica della ricerca fortiniana e per l’orizzonte del suo dispiegarsi nella produzione del medesimo, mi permetto di rinviare al mio “Dopo lungo giro ed erranza”, in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., pp.XIII-LI.
[17] Franco Fortini, Prefazione a questa ristampa, in Dieci inverni 1947-1957. Contributi ad un discorso socialista, Bari, De Donato, 1973, pp.18-9 nota 4.
[18] Franco Fortini, Non si dà vita vera se non nella falsa, in Contro l’industria culturale. Materiali per una strategia socialista, Quaderno CESDI, Bologna, Guaraldi, 1971, p.113.
[19] Augusto Vegezzi, Franco Fortini, Gli argomenti Umani. Antologia italiana per il biennio delle Scuole Medie Superiori, Napoli, Morano, 1969, p.1232.
[20] Tre interventi sul libro di don Milani, “Quaderni Piacentini”, VI, 31, luglio 1967, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.112.
[21] Ibidem.
[22] David Harvey, La crisi della modernità, traduzione di Maurizio Viezzi, Milano, Il Saggiatore, 1993, p.273.
[23] David Harvey, ivi, p.295.
[24] Cfr. Vandana Shiva, Il bene comune della Terra, traduzione di Roberta Scafi, Milano, Feltrinelli, 2005.
[25] Credo che sarebbe interessante riesaminare in quest’ottica anche certi aspetti della critica adorniana all’industria culturale, fonte costante dello stesso Fortini.
[26] Questo, per esempio, è il titolo di una sua opera: Luciano Gallini, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011.
[27] Si veda, tra gli altri, l’interessante lavoro di uno studioso, già militante del movimento Occupy Wall Street, David Graeber, Burocrazia, traduzione di Fabrizio Saulini, Milano, Il Saggiatore, 2016.
[28] Mavì De Filippis, Intervista a Franco Fortini, in “La Ragione Possibile”, I, 1, maggio 1990, ora in Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto, cit., p.577.
22 maggio 2017
Di Fortini, dell'insegnare oggi
Articolo apparso con il titolo Un maestro mai salito in cattedra nell'inserto del Manifesto su Franco Fortini (Il Disobbediente) del 4 maggio 2017.
“Quello che di te rimane, che di tutti rimane, non è rappresentato da quei quattro, venti, cento libri che puoi avere scritto, e neanche dagli affetti e dall’insegnamento, perché basta passare una certa età per accorgersi di quanto questo sia vano, ma è una quantità di modificazioni che la tua vita, come quella degli altri, ha introdotto nei rapporti fra gli uomini”. La semplicità da maestro elementare della frase pronunciata da Fortini sul letto di morte accresce la sua profondità.
Oggi, se guardo ai decenni del mio insegnamento, vedo meglio come essi si dividano in due periodi del tutto diversi e quanto a Fortini debbano. Non parlo ora della sua pratica di docente, neppure delle sue riflessioni, pur numerose e ritornanti in tutto l’arco della sua produzione, sulla scuola, sulle antologie scolastiche, sugli studenti. Nell’autore di Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo la spinta antiborghese, assunta la marxiana prospettiva comunista, sia ha sempre di mira un agire collettivo, sia è inseparabile da una necessità pedagogica, cosicché ogni scritto del saggista e del poeta si muove nello stesso orizzonte. La sottolineatura, inquieta ed esplicita, dell’ineliminabile funzione pedagogica di chiunque parli ad altri è stato un caveat che ha accompagnato la mia pratica d’insegnante e che tanto più assume valore generale oggi, quando le massime autorità, coloro che decidono la vita e la morte di milioni di persone, fingono di parlarci come l’uomo della porta accanto.
Una delle ragioni della grandezza dell’opera fortiniana è nel fatto che tale sottolineatura pedagogica si è da subito accompagnata alla critica radicale della posizione privilegiata dell’intellettuale, dal comunismo terzointernazionalista mantenuta invece per il politico-intellettuale. Tant’è che, scrive Fortini, “quella che chiamiamo rivoluzione è in realtà una presa della parola da parte di tutti, col conseguente atteggiamento pedagogico di tutti a tutti”. Tale ganglio è la sorgente fermentante del rifiuto della delega ad altri - ossia al partito - del giudizio politico, insieme con la rivendicazione del valore politico di un’analisi del testo poetico e viceversa, quindi anche del rigetto degli specialismi.
Proprio a partire da questa angolatura, proviene alla mia educazione sentimentale un altro ammaestramento di Fortini: la necessità vitale, per dirlo con Gramsci, dello “spirito di scissione”, che porta a un permanente sguardo critico sulla cultura. Per un intero periodo ho considerato gli allievi miei fratelli minori, da accompagnare nel processo ampio d393i emancipazione della scolarizzazione di massa. Del resto, né il mio insegnamento avveniva nel vuoto, potendo beneficiare dell’azione di movimenti politici, di organizzazioni sindacali nei quali gl’insegnanti trovavano modo di confrontarsi e di agire su temi e terreni non settoriali; né, analogamente, i miei studenti erano privi di loro sedi collettive.
Tutto è cambiato a partire dagli anni Novanta, quando la critica al sapere è stata sostituita dalla critica al costo del sistema pubblico dell’istruzione e della ricerca. Così sono diventate cruciali, per quanto inascoltate, le denunce circostanziate di Tullio De Mauro sulla mancata scolarità e sul grave tasso di analfabetismo funzionale. La svolta decisiva è stata la legge sull’autonomia scolastica di Luigi Berlinguer, la quale muove dal rifiuto dello “statalismo”, sinonimo di dogmatismo e parassitismo. Essa è stata la forma specifica assunta nella scuola dal generale processo di appropriazione privata e di sottomissione al profitto, con cui il capitale si svincolò in quegli anni dal compromesso keynesiano del secondo dopoguerra. Nella mia pratica d’insegnante mi è divenuto sempre più chiaro sia che i miei fratelli minori restavano fuori della porta, sia che gli alunni rimasti in classe parlavano un’altra lingua e non per ragioni anagrafiche.
Il processo ha ricevuto un’accelerazione dirompente dall’ultima riforma renziana. Si consideri solo che la cosiddetta alternanza scuola-lavoro obbliga alla sottrazione, nel triennio, di circa 40 giorni scolastici. Inoltre, poiché l’autonomia si è accompagnata al taglio delle risorse agl’istituti e al blocco stipendiale, la logica perseguita della concorrenza tra scuole, insieme con il bisogno di risorse aggiuntive, ha spinto alla moltiplicazione di progetti con lo scopo prioritario di procurare iscritti e introiti a discapito dei concorrenti. Conseguenze sono stati lo sbriciolarsi dell’azione didattico-pedagogica e il velocizzarsi delle procedure dell’insegnare, mutilando così irreparabilmente il tempo d’apprendere –per non parlare della relazione discente-insegnante, con ciò che a essa è connesso in termini di interiorità dell’adolescente in formazione. In tale contesto, risulta razionale ed efficiente un insegnamento ridotto ad addestramento. Una ricerca recentissima sull’università (In/disciplinate: soggettività precarie nell’università italiana, a cura di Francesca Coin, Alberta Giori, Annalisa Murgia, Venezia, Ca’ Foscari, 2017) conferma che tale condizione della scuola è parte di una logica ben più ampia e di lungo periodo: “Luogo dell’instabilità e insicurezza lavorativa … coinvolta nei trend economici globali”, l’università è sempre più orientata “alla performance e alla standardizzazione”.
La fortiniana critica alla cultura è stata dunque spiazzata da un’aggressione alle sue spalle, che ha espropriato il suo stesso terreno. Se oggi ci si deve misurare con il ritorno a forme di deprivazione ottocentesche, è vero però che né la scolarizzazione di massa è passata invano, né la Rivoluzione d’ottobre, malgrado tutte le rimozioni, è stata una parentesi. Nel caso del mestiere d’insegnante, si tratta di operare contro l’espropriazione del diritto alla conoscenza - del discente quanto del docente-, al contempo praticando, a ogni tappa, la critica allo stesso sapere acquisito, contro, come dice Fortini, “la strangolazione, l’immiserimento caotico, la falsificazione”.
12 maggio 2015
Cassola o della resilienza della vita
Osservando la lunga e prolifica produzione letteraria di Carlo Cassola, romano di nascita, ma toscano di adozione, appare evidente la fedeltà a una narrativa della vita ‘primigenia’ che potrebbe definirsi pre-politica. Dice nel 1972: “è indubbiamente il nudo fatto dell’esistenza, il fatto che esistano certi luoghi, certe persone … che esistiamo noi, è questo che mi spinge a scrivere”. E Fortini, recensendo “il bellissimo libro” di Cuore arido scrive: “Cassola ha ripreso la sua accanita fatica di riduttore. Non si sa bene se gli eventi si svolgano nel 1933 o nel 1833”.
Ecco perché può risultare sorprendente l’attuale uscita di Cassola e il disarmo. La letteratura non basta. Lettere a Gaccione 1977-1984, nel centenario della nascita, a cura di Federico Migliorati e Angelo Gaccione, Lucca, Tra le righe libri, 2017. Il volume raccoglie il consistente numero di lettere di Cassola al giovane sodale dell’ultima esperienza militante del fondatore e animatore della Lega per il disarmo unilaterale. Accompagnato com’è da un’intervista con Gaccione, da lettere a destinatari diversi (Umberto Terracini, Aldo Natoli, Alfonso Leonetti e Francesco Rutelli) e altri documenti interni all’organizzazione, il volume costituisce una fonte importante, di prima mano per la genesi e l’evoluzione, fino al 1984, della Lega per il disarmo. D’altra parte, proprio una delle ultime lettere qui raccolte, datata 10 ottobre 1979, sembra avvalorare l’idea che l’impegno militante di Cassola sia solo un fatto recente. Nell’ampia e importante riflessione sulla propria opera, afferma che solo da ultimo “ho capito che la spinta sociale non poteva essere unicamente letteraria … mediante un’azione politica da condurre con gli altri”. In realtà, quest’ultima, nel senso stretto del termine, ha segnato con intermittenze l’intero arco della vita di Cassola.
La prima, fondamentale stagione è naturalmente la sua partecipazione alla Resistenza con la 23esima Brigata Garibaldi dal 1943 al 1944, nel territorio di Volterra, luogo delle sue vacanze giovanili e città natale della madre. Formò e guidò il comitato militare del CLN. Un’esperienza dalla quale sono usciti i romanzi che per primi gli hanno dato notorietà: Fausto e Anna (1952), La ragazza di Bube (1960) da cui fu tratto nel 1963 il film omonimo con Claudia Cardinale, diretto da Luigi Comencini.
Nell’autunno del 1952, allorché la Democrazia Cristiana di De Gasperi, in vista delle elezioni politiche per la seconda legislatura, aveva emanato una legge elettorale maggioritaria, Cassola tornò attivamente sulla scena politica. Socialisti e comunisti avevano protestato parlando di “legge truffa” e Cassola, che dal 1951 viveva e insegnava a Grosseto, collaborò energicamente con Luciano Bianciardi alla nascita di una formazione politica, Movimento di Unità Popolare, che con i voti raccolti fece fallire il raggiungimento del quorum necessario a far scattare il premio di maggioranza per la DC. Il Movimento nacque dalla convergenza di due scissioni: quella dal Partito socialdemocratico, guidata da Codignola, e quella dal Partito Repubblicano Italiano, guidata da Marcello Morante, anch’egli operante a Grosseto con Francesco Chioccon. Scritti, lettere, testimonianze su quel periodo, raccolte a suo tempo negli atti di un convegno sul tema (Movimento di Unità popolare e crisi del centrismo, a cura di Adolfo Turbanti, Firenze, Giunti, 1995) mostrano il medesimo fervore, lo stesso spirito pratico e la puntigliosità organizzativa che le lettere di Cassola e il disarmo documentano.
Successivamente e in parte parallelamente a questo, Cassola lavora per un quinquennio con Bianciardi a un’intensa opera pubblicistica su vari aspetti sociali e politici, il cui frutto più importante è l’inchiesta I minatori della Maremma (Bari, Laterza, 1957). Nel 1960-1964, quando il successo editoriale gli permette di congedarsi dall’insegnamento, è eletto consigliere al Comune di Grosseto nelle liste del PSI.
L’ultima stagione politica per il Disarmo unilaterale rappresenta dunque lo sviluppo di una costante tensione morale e pratica, che d’altra parte la tarda testimonianza presentata nel libro ora in uscita indica nascere con la Resistenza: mi “aveva fatto capire che bisogna scrivere per gli altri, in modo innanzi tutto comprensibile”. Tuttavia Cassola, in un’altra lettera dello stesso carteggio, asserisce con nettezza che “la letteratura è più importante di qualsiasi altra forma di espressione artistica ed enormemente superiore a qualsiasi altro tipo di registrazione della vita”. Dunque, l’attività narrativa e quella pratico-politica sono due binari senza contatto? La seconda è abbandonata al solo dovere morale?
Io credo che pagine splendide come quelle del Taglio del bosco e della Visita, o quelle di Ferrovia locale, di un’umanità quasi anonima eppure prorompente nella sua tenace resilienza stiano lì a indicarci che la rappresentazione di quella vitalità è, insieme, il grido del suo valore. Ed è quel valore a segnalare all’autore medesimo che esso va affermato fuori della letteratura, dunque a indicargli che il letterato deve per primo cercare di renderlo reale fuori della pagina. Tale fare è appunto storico e politico. Quando, nel disfacimento della lunga fase espansiva del secondo dopoguerra, anche le forze politiche stavano trasformandosi in quello che oggi sappiamo essere, Cassola ha ‘arretrato’ anche la propria azione politica alla difesa della vita nei suoi stati più semplici. Gli animali, dice nel pieno della sua lotta per il disarmo, “parlano un linguaggio più universale degli uomini: le loro storie sono meno localizzate, potrebbero avvenire in qualsiasi parte del mondo”.
18 marzo 2017
Tre libri su Bianciardi
Michel David, l’autore del monumentale studio sulla Psicoanalisi nella cultura italiana, mi descrisse in un colloquio Luciano Bianciardi nei termini di un “cinghiale selvaggio” della sua Maremma. Per contro, Enzo Jannacci, nell’affettuoso ritratto consegnato al regista Francesco Falaschi, nel cortometraggio della sua biografia bianciardiana, Addio a Kansas City, dice dello scrittore: “sembrava un impiegato di banca”. I due giudizi forse meglio di altro sintetizzano il fuori posto, da cui il grossetano emigrato a Milano si è trovato a vivere. Se all’uomo di spettacolo che cantava degli eroi strampalati della “Banda dell’ortica” appariva troppo ‘borghese’, al fine letterato appariva eccentrico per motivi opposti. La sua condizione di isolato non è separabile dalla sua fedeltà al mondo dei terrazzieri e dei minatori grossetani e insieme dal senso di colpa per la propria impotenza e la propria inadeguatezza, nel travolgimento della vita e dei costumi della intensa innovazione capitalistica del dopoguerra.
È da questa sua posizione che all’uomo derivò presto l’isolamento e poi la disperazione, mentre allo scrittore ne è venuta una fortuna intermittente. La sua bibliografia si arricchisce ora, in brevissimo lasso di tempo, di tre monografie. Arnaldo Bruni raccoglie “scritti nati perlopiù in servizio di convegni e seminari” nel volume “Io mi oppongo”. Luciano Bianciardi garibaldino e ribelle (Aracne, 2016, pp.150). Il volumetto compone un agile ritratto dello scrittore, a partire dal periodo giovanile a Grosseto, con particolare attenzione a Bianciardi e il cinema e al Lavoro culturale. Del periodo milanese, oltre alla Vita agra, viene soprattutto messa a fuoco, come indicato dal titolo stesso del saggio, la passione ‘garibaldina’ di Bianciardi per il Risorgimento visto, dice Bruni, come “premessa della modernità”. Nell’ampio capitolo Bianciardi garibaldino, lo studioso indaga sia le anticipazioni del tema nella narrativa del Lavoro culturale e dell’Integrazione, sia le inclusioni autobiografiche. Inoltre, si sofferma su Da Quarto a Torino per mostrarvi le riprese, che vanno dai garibaldini diventati scrittori Giuseppe Bandi e Giuseppe Cesare Abba, a scrittori come Ippolito Nievo e Alessandro Manzoni.
In quella che forse è stata la prima tesi di laurea su Bianciardi, a tre anni dalla morte, Ermenegildo Saglio raccolse da Carlo Cassola, che per un quinquennio aveva lavorato fianco a fianco con Bianciardi, un’intervista in cui osservò persuasivamente che quando Bianciardi metteva mano alla penna, lo faceva sempre per prendere una posizione critica verso costumi e condizioni del presente. Non sorprende, dunque, che anche Carlo Varotti riproponga fin dal titolo del suo studio questa nota dominante: Luciano Bianciardi, la protesta dello stile (Carocci, 2017, pp. 307). L’ampia monografia offre uno sguardo complessivo e ravvicinato dell’opera dello scrittore. Come indica in modo trasparente lo stesso titolo, il fuoco dell’indagine è ricercare nelle caratteristiche dello stile bianciardiano, nel modus operandi della sua pagina – sia essa narrativa, giornalistica, manualistica o diaristica – lo spazio e l’azione della propria opposizione critica. Per questa ragione, per esempio, dell’enorme mole traduttoria portata a termine da Bianciardi con la collaborazione della compagna Maria Jatosti, lo studioso spiega di far ricorso solo ad alcune opere che abbiano “lasciato tracce individuabili (fatte di temi o di modelli di stile) nei romanzi”. E sempre per questa ragione la stessa ricostruzione del contesto sociale, politico e culturale è da Varotti assunta come materiale convogliato nella pagina bianciardiana. Una scelta netta, una rotta che non manca di marcare la propria linea di confine anche attraverso la polemica aspra contro “il facile entusiasmo di chi ha voluto farne il testimone incorrotto e sventurato di una generazione e di una crisi epocale, l’acuto sociologo che ha capito per primo (anche questo capita di leggere) le dinamiche occultamente persuasive e pericolosamente omologanti del neocapitalismo”. L’indagine di Varotti, collocando Bianciardi tra gli autori del postmoderno, conduce a individuare nel parodismo, ossia nella ri-scrittura deformante, che si dispone in una ricchissima gamma di sfumature, dal grottesco al falsetto, dalle vesti della citazione dissimulata a quelle del falso candore, la cifra specifica dello stile bianciardiano e quindi della sua opposizione critica.
Diversamente, la monografia di Elisabetta Francioni si presenta come studio di un periodo e di un’attività particolari: Luciano Bianciardi bibliotecario a Grosseto (1945-1954) (Associazione Italiana Biblioteche, 2016, pp.175). Tuttavia, robustamente incardinato com’è su una minuta e sistematica ricerca d’archivio e sorretto dalla competenza dell’arte biblioteconomica, lo studio segna una tappa salda negli studi bianciardiani. L’aderenza rigorosa alle fonti, il loro collegamento sicuro al contesto complessivo, nel mentre che sgombrano il terreno da tanti miti fasulli e falsi testimoni, approdano a una diversa e più convincente interpretazione dello scrittore.
L’argomentare pacato e sempre rigoroso della Francioni dimostra che la biblioteca comunale Chelliana, riportata in vita da Bianciardi dopo un’alluvione e i bombardamenti della seconda guerra mondiale, non solo non è stata per lui una sinecura, ma che vi ha intensamente lavorato per farne strumento di crescita culturale e civile a fianco delle classi subalterne grossetane, in collaborazione convinta, non acritica, con i partiti che li rappresentavano: i comunisti e i socialisti. L’amore per lo sberleffo, per la sprezzatura ironica, propri dell’uomo e della sua pagina, erano la faccia esibita dell’infaticabile lavoro quotidiano, dell’impegno intellettuale e della tensione morale per costruire una città più civile e democratica, a partire dalle condizioni dei minatori e dei contadini. Lo studio rende palese perché, ancora nella postfazione del 1964 al Lavoro culturale, l’autore scriva: “eppure Kansas City è una città tremendamente seria, e io ci torno ogni volta con un po’ di magone e parecchio rimorso”. La ricostruzione storica di Elisabetta Francioni contribuisce a chiarire che, per non fraintendere il profilo intellettuale e la voce di Bianciardi, è necessario non perder di vista la scissione tra la sua età di scrittore – dall’abbandono di Grosseto alla morte milanese, da Il lavoro culturale ad Aprire il fuoco – e quella della sua formazione sentimentale del periodo grossetano, il cui lascito più rilevante è la ricostruzione della biblioteca Chelliana e I minatori della Maremma redatti con Cassola l’opera più importante. Di più: tutta la carica corrosiva fino all’iperbole, capace di mettere a nudo gli ottimismi sciocchi, i cinismi aggressivi, le disumanizzazioni nel dispiegarsi della società dei consumi, propri della sua narrativa maggiore, non avrebbe letteralmente potuto prender vita senza il contrappunto del periodo grossetano. Contrappunto con gli anni semmai mitizzato e del tutto consentaneo con l’altro mito della sua infanzia, di suo padre e di nuovo prossimo alla cultura comunista: il Risorgimento mazzinian-garibaldino.
4 marzo 2017
Per la Palestina
Nel viaggio in Palestina dal 28 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017, compiuto con altri quarantadue compagni e organizzato da Assopace Palestina di Luisa Morgantini, da cui è nato Jalla!, abbiamo misurato tutta la nostra responsabilità e la nostra pochezza di italiani e di europei. Così, in un freddo asilo d’inverno, è irrotta nella mia memoria, con la forza della necessità, la fortiniana Lontano lontano…, una delle Sette canzonette del Golfo, dedicate alla Prima Guerra del Golfo fatta combattere dal primo Bush contro l’Iraq e cui, per la prima volta, parteciparono aerei militari della Repubblica italiana. Chiesi subito a Fabian Odeh, conosciuto a Gerusalemme in uno degl’intensi incontri organizzatici da Luisa, di tradurmela, come segno, se non tentativo, di costruire un varco, con l’intento di lasciare un fiore, confessare una verità. Ringrazio dunque della cortesia Fabian, palestinese e italiano.
18 febbraio 2017
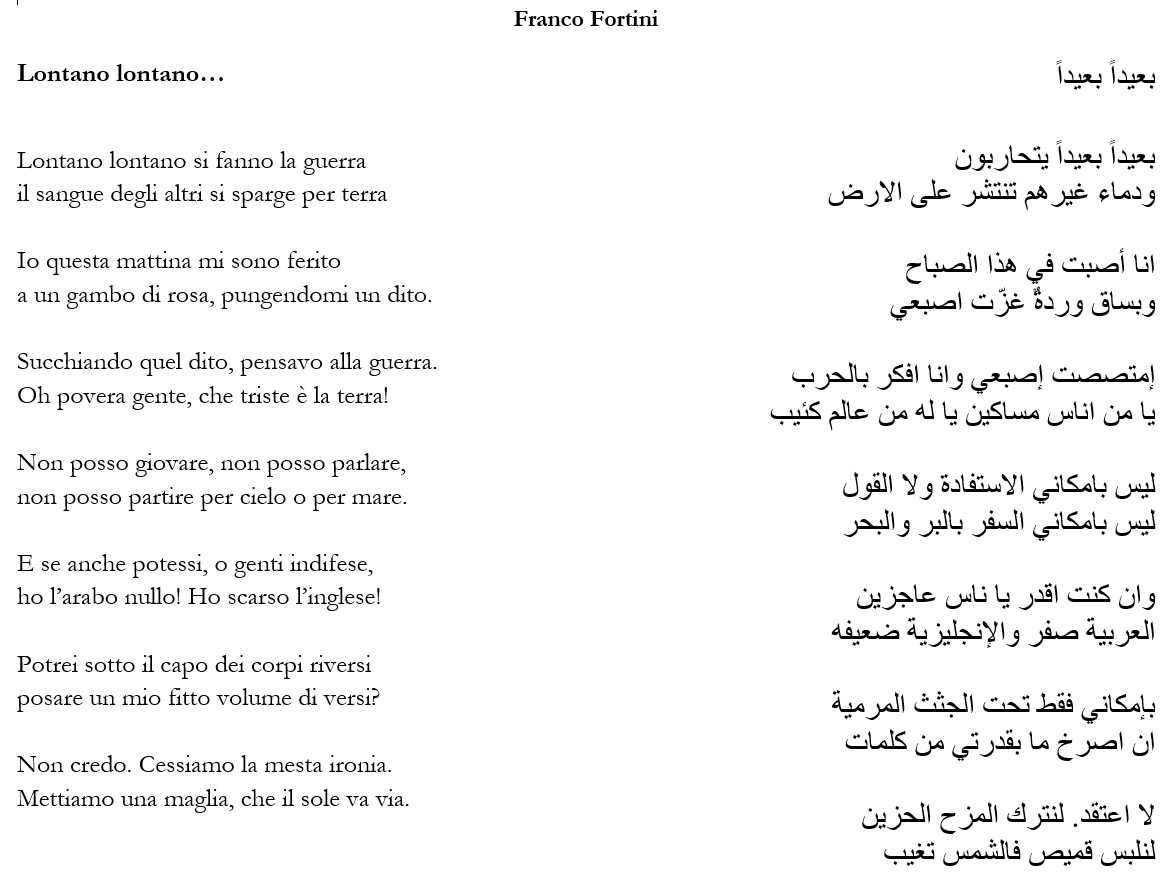
https://ilmanifesto.it/jalla-il-coraggio-di-resistere/
Jalla!
Al Ma’sara
Non sono riuscito a cogliere la luce giusta per uno scatto. L’immagine è solo nella mia memoria. Nella stanza troppo grande, tra la folata dei bambini vestiti leggeri, dalle bocche con le parole uscivano nuvolette dense. Fuori della porta, nel primo sole, sembrava tiepido.
Scarsa terra tra sassi fittagni nella schiena brulla, intorno all’edificio adattato ad asilo. Appena più in basso, tra le chiazze di suolo, a rinforzo degli olivi e di una presetta di radicchio, qualcuno aveva ammontinato carrettate di terrioletta. Ho pensato di rimanere seduto lì, sopra un sasso, in un giorno d’autunno, a guardare il cielo ventoso. Sarebbe venuto alla siepe il pettirosso?
Il paese non si sa dove sia. I bambini più volte hanno visto i grandi insultati, il loro padre picchiato dagli armati. Qualcheduno, poi, è sparito. L’uomo che ci parla avrà forse trent’anni, ma non sorride. I bambini si tengono per mano. A turno, qualcuno è consolato dalle maestre. Volontarie senza compenso, ci dicono. Due o tre avranno quindici anni.
Al Jyflik
Il grande pannello rettangolare rosso è proprio davanti casa: zona di esercitazioni militari. Del pericolo sei avvertito. Per questo, quando le camionette arrivano, si deve lasciare di corsa il lavoro e la casa. Intorno, nella pianura del Giordano, malgrado la polvere di gennaio, resiste qua e là il verde. “Al rientro troviamo sempre danni nei campi e alle case”. Il giovane parla con foga della piccola biblioteca che le donne faranno nascere. I muri profumano d’imbiancatura. Nella stanza le sedie disposte per noi non bastano. “Stiamo attenti ai bambini, ma non sempre ci accorgiamo delle bombe dimenticate”. Oltre la finestra, poco distante, s’impennano le ripe desolate che nascondono Amman.
Al Fasayil
La nostra fila per il bagno principia paziente in mezzo al piazzale interrato dell’unica casa a due piani. Entra in una stanza a pian terreno con pochi mobili di legno, gira in una stanzina buia e sale tre scalini dove termina dietro una tenda di stoffa fiorita, proprio sopra un piccolo balzolo, cui è addossato il fornellino con cui delle donne lessano il riso e cucinano carne di pecora. Ma oramai ci siamo abituati. I bagni sono rari, quasi quanto l’acqua.
La spianata polverosa non ha siepi o confini, entra tra le casupole rabberciate, si ritrae davanti capannette di somari e chiuse di branchetti di pecore. La strada appena vi si distingue. Dove sono i campi?
Ogni tanto, tra i piedi, stecchi spinosi di giuggiolo. Uno di noi si china a raccogliere: “ecco da dove viene la corona di Cristo”.
La costruzione in cui pranziamo, discosto dalla casa, ha un’unica stanza rotonda, con un’entrata e tre finestre, non alta ma non asfissiante. I correnti e i ritti sono stati inchiodati da poco. È l’edificio comune del villaggio. “L’abbiamo tirato su in una notte”, di terra battuta impastata di paglia. Sul ripiano, al centro, riso, salse e carne di pecora che le donne ci scodellano con l’aria della festa. Alle pareti un cartello giallo con un triangolo rosso: pericolo mine, in arabo, ebraico e inglese.
La coppia che ci ha accompagnati è giovanissima, la ragazza mostra una gravidanza appena pronunciata. L’uomo la guarda taciturno. È, ci si dice, di un campo profughi. “Certo, sì, la scuola era abusiva. Ma la strada che portava al villaggio più grande, l’esercito l’aveva tagliata con uno scavo profondo”. Le autorità militari imposero di abbattere quanto era stato costruito. “Allora principiammo a ballare e cantare insieme con i bambini, davanti la fila dei militari”. Se non possiamo costruire, allora ci divertiamo.
Si vela la luce sulla finestretta della stanza, che oramai le donne sparecchiano. Cinque o sei pecore dentro il capanno a due passi dalla porta belano verso di noi. Si ballò per giorni, mentre dietro fu finita la stanza. “I bambini la poterono usare due o tre volte”. Poi arrivarono le autoblindo e una ruspa.
At Tuwani
Ha un viso mite, con una peluria ancora rada. Il berretto di lana è tirato sopra le orecchie, anche se ha un nostro accento montanaro. C’è, tra noi, chi l’assilla, arrancandogli dietro per il crostolo sassoso con scarsa erba. “Si dirà a tutti, più avanti”.
La formalità, nei rapporti umani, non è solo lo strumento del dominio. È anche la misura del rispetto, un esercizio contro l’egotismo. “Olmo!”, qualcuno dei suoi lo chiama.
Per quanto si sia saliti alla fine della costa, sul colle vicino più alto, proprio a ridosso, immancabile si erge il recinto: colonie o avamposti militari. Perché l’Impero Ottomano, spiegano in tribunale, riservava al demanio le cime.
La ragazza incinta aveva raccontato con voce calma del loro viaggio sperato in Giordania, fermati al confine. Solo dopo mesi aveva potuto rivedere il giovane sposo, nell’aula del processo. Sorrideva la ragazza, il marito sedeva a capo chino: signor Giudice, nel giorno e nell’ora della vostra accusa, l’imputato si sposava a mezza giornata di distanza. Il giudice militare, guardato il certificato, prese il capo d’accusa, scrisse qualcosa: “Non è un problema. Ho cambiato data: se avete documenti che attestino che non era presente, mostrateli”.
Il sole è ora più tiepido. Sul colle accosto, proprio sullo sperone è arrivato il militare. Ci guarda in piedi, a braccia incrociate.
Il significato della legge, come delle parole, lo decide chi comanda.
L’uomo davanti a noi ha un volto scavato, dentro il cappuccio della felpa. Vedo il naso aquilino. Fuma, nei brevi intervalli della traduzione dalla lingua dei padroni. È di mezza età, mi sembra. Ha il corpo e le mani dei contadini. Olmo ha lasciato il posto a una ragazza forte, dal viso severo e fermo. Il sole scalda la nostra destra, appena di spalle. L’esile tracciato di strada tra i massi e i ciottoli in basso si fa più nitido: il poggio declina in un falsopiano terroso. Dal punto in cui ci hanno accompagnati, si scorge la strada costeggiare alla sua destra alcune serre, la si vede proseguire per altri duecento metri per poi lambire alla sua sinistra il recinto di rete e filo spinato della colonia.
Gli occhi dell’uomo che ci parla col tono di chi non ha bisogno di scegliere le parole fissano altro. Spesso abbassa la testa. Dietro quelle alture, a più di un’ora, la strada porta ad altri villaggi di grotte e capanne di copertoni. Da lì vengono a piedi i bambini per la scuola elementare. “Ragazzi e uomini sbucano dalla rete di protezione. S’avventano giù a volto coperto, urlando con sassi e bastoni, al loro passaggio”.
L’uomo spenge in terra la sigaretta. Ci guarda uno a uno. I volontari internazionali non accompagnano solo i bambini, perché i pastori vengono circondati e anche le pecore sequestrate dall’esercito e gli olivi aggrediti. “In una notte, duecento sono stati troncati”.
Nablus
La stanza, dai muri in pietra ben ordinati, è lunga, non alta, senza finestre, con volta a botte. Sembra un rifugio. Ci sediamo ai lati, in fila. Le donne che ci ospitano ci accolgono sorridenti. Una bambina passa con un vassoio di dolcetti. A una a una, prima di prendere parola, si alzano in piedi. Si chiamano a turno. Parlano della propria reclusione, della loro cura dei bambini orfani o che hanno sofferto le diverse violenze.
Una donna entra in ritardo, saluta allegra e va a sedersi in fondo alla stanza. Al suo turno, si avvicina con passo energico. Ha un’età matura, folti capelli neri, volto bello e spigliato. “Quando finalmente hanno scarcerato mio fratello e l’ho visto tornare a casa, non stavo dalla contentezza. Non dico della nostra mamma, già in là con gli anni”. Dopo qualche tempo, i militari bussano ancora nel cuore della notte. “Salgono e prendono me. Io sono felice, perché non erano tornati per mio fratello”. Poi chiedono anche di lui e la vecchia madre si aggrappa piangendo al soldato. “No, grida, sono i miei occhi! Non prendeteveli tutti, singhiozzava, prendetemelo uno per volta!”.
Via Shuhada
Incomprensibilmente, là dove la grande via scende un po’, ricevendo la confluenza di un’altra, si forma una ressa. Il gruppo deve fermarsi. “Qui, proprio dietro l’angolo…” il militare di pattuglia è irremovibile. Mentre il suo più giovane compagno paffuto rimane indietro, con aria assente, l’altro è in mezzo a noi, di fronte al giovane che ci guida. “È proprio qui, non più di cinque metri…”. Il militare non parla più, né si volge ad altri che lo interrogano o implorano, non allarga le braccia. Rimane immobile, non perde per un attimo con gli occhi quelli della nostra guida. Quasi sorride. Il giovane che ci guida desiste. “Ora che voi passate avanti, guardate subito a destra. Sulle scalette hanno ammazzato due diciottenni, che avevano preso la scorciatoia per l’università”.
Poco prima, il giovane ci aveva parlato nel breve giardino di casa fra vecchi olivi, appena più in alto. Da un lato e dietro, a cinque metri s’innalzava una scarpata fino al primo piano. Dietro il filo spinato due ragazzini in kippah zappettavano per tutto il tempo lungo la rete. Sorvegliava un uomo in armi. D’un tratto, un plotone in assetto di guerra ha principiato le esercitazioni tra olivi, case, ragazzetti dietro un pallone e mamme con figli in braccio. Il nostro ospite raccontava della fatica per entrare nella casa che aveva affittato. “Un giorno trovai qui, davanti la porta, un uomo che parlava con accento francese”. Distende le braccia a pugno chiuso, per farci vedere. “Gridava. È mia!, diceva, me l’ha data Dio!” si cercò di calmarlo. “No! È scritto nella Bibbia!”.
Che cosa può un povero contratto notarile, di fronte alla parola di dio? E sarebbe stato inutile chiedere in quale versetto si riscontrasse il suo nome.
E che vale dire che quella casa, quegli olivi, fin dalla loro origine erano stati dei padri del giovane che ci parlava? Che quella terra medesima da cinquecento anni o da due millenni mai avevano visto il francese o i suoi antenati? La parola di dio e dio medesimo non hanno, come gli uomini, tempo. Se avete altri argomenti, o miscredenti, portateli!
Lasciata la nostra guida, oltrepassata la confluenza della via, tutti i portoni in ferro sono saldati, inchiodati quelli di legno. Sulla destra, il muro che partiva dalle scalette si apre in una porta stretta. Senza battenti, è cucita da una matassa di filo spinato. Di là, pietre di tombe deserte.
Lungo la via, le finestre sono cieche o orbite vuote. Solo in rari casi, ci si dice, è possibile agli antichi abitanti entrare dal tetto, salendo dalla strada parallela. Sulle facciate silenziose strane gabbie di ferro oramai arrugginito chiudono terrazze e finestre. Incastrato in una di queste, un vecchio cartello sbilenco scritto a mano lascia ancora qualche brandello: apartheid.
Bili’n
Il sole invernale è già basso. La ghiaia dello stretto piazzale pare più calda. La madre, alta e austera, sorride appena con gli occhi. Uno dei figli, di mezza età, zoppica un poco. Per mesi e mesi gli abitanti del villaggio con i loro vicini hanno gridato a mani nude contro il muro che chiudeva agli abitanti campi e olivi. Uomini, donne, bambini e vecchi hanno sfidato con la sola voce bombe lacrimogene e assordanti, proiettili di gomma. Il figlio, che vedeva il pericolo per i bambini e le pecore già morte, fermi!, gridò alzando le braccia verso i soldati.
Ora una grande pietra incisa ricorda il suo nome in un piccolo parco della rimembranza, ricavato sulla scarpata della strada sterrata, in faccia all’alto muro che, spostato più in basso, protegge le case ancora fresche di calce della colonia. Accanto alla lapide, oggi, un virgulto d’olivo ricorda la giovanissima sorella. Nella foto appesa, sopra la bocca ferma, due occhi smarriti.
Qualcuno ci racconta del fratello zoppo. Fermato, con le mani alzate e il volto appoggiato all’autoblindo, gli si avvicinò un giovane militare, lo affiancò e gli sparò dritto nel piede.
Nel nostro gruppo l’uomo si muoveva allegro, scherzava con la madre, c’invitava a entrare. Ma il sole scendeva veloce. Il pullman era fermo sulla strada. La nostra guida più volte ci sollecitava.
“Jalla!”.
23 gennaio 2017
Il testo è uscito anche in Officina dei Saperi: http://www.officinadeisaperi.it/agora/parole/
Parole
“Dio ti fulmini!”: il grido dell’impotente proclama sempre la sconfitta subìta, proprio mentre millanta di negarla. Una postura talmente scoperta, che il realista crede di trovarvi la prova definitiva della sua antica convinzione: nomina sunt consequentia rerum. Eppure qualcosa non convince.
Che cosa induce il parlante secolarizzato da oltre due secoli di capitalismo a ripetere l’ossequio degli albori che nella parola sentivano la folgore divina? Rimane cioè il sospetto che il remoto tremore e l’invettiva moderna non siano semplici finzioni, ma costituiscano dei sintomi, ovvero che le parole in cui si sostanziano segnalino davvero la negazione dell’impotenza, per quanto la sua verità prenda la figura paradossale di un dio che obbedisce al nostro comando. Più volte ho personalmente risposto che quando mi vedo incapace di agire, quando anche il fiato mi manca, allora scrivo. Tuttavia non è questa stessa tensione, il suo risultato un’altra prova che lì esiste e agisce una qualche negazione della negazione?
Dal lato opposto, non da oggi più d’uno ha argomentato che nei pronunciamenti del tipo “L’imputato è condannato” la cosa, anche la più grave in assoluto, nasca dalla parola, non viceversa, esattamente come il sacro precetto asserisce: fiat lux! In questa nostra epoca assistiamo alla mondanizzazione radicale e massificata del fenomeno, perché è esperienza persino dozzinale che le parole sono cose da cui rastrellare lucro. E non dico qui di organismi raffinati, di quell’“opera d’inchiostro” che già al principio dell’età moderna messer Ludovico sapeva di dovere al suo signore Ippolito. Sono proprio le frattaglie della comunicazione, dalla lista della spesa al ciao ciao del mattino al vicino di casa, le cose da vendere e acquistare: è l’attività del parlare, ciò che viene messo a valore e perciò espropriata. Non mi riferisco a chi contratta e vende la propria attività parlante, fatto antico che andrebbe forse meglio indagato, ma alla miriade di occasioni quotidiane che i mezzi informatici mettono a disposizione e di cui, chi se ne serve per salutare l’amico lontano o incontrarne uno nuovo, ignora totalmente che la società di recapito vende il tuo messaggio e, per questa via, la tua persona, la tua vita a chi sa chi e chi sa dove, in una ragnatela dalla mirabile capacità di trasformare il più individuale e intimo gesto, la parola, nel più astratto e anonimo valore di scambio, dove nessuno parla più a nessuno.
Nel punto estremo in cui ci troviamo esposti, dove non ha più senso discutere se è il nome che nasce dalla cosa o viceversa, perché semplicemente le due serie sono una sola, risulta forse più chiaro quanto avremmo dovuto sapere da sempre, ossia che le parole sono medium dei rapporti umani. Ciò comporta delle conseguenze vaste e notevoli. I rapporti sociali umani sono stati e sono il campo, l’energia e la posta del conflitto tra differenze e contraddizioni, dunque le parole – il loro significato e il loro valore – portano impresso il conio di chi, nel conflitto, ha potuto imprimerlo. Si può infatti leggere la raffinatissima codificazione linguistica, che le civiltà umane hanno diversamente sviluppato, come il tentativo di arginare la violenza originaria e permanente della legge del più forte. Un’enorme opera di mediazione, vero codice di Hammurabi. Tuttavia, come il vocabolario di una lingua rimane saldamente storico, così gli atti di parola, se apparentemente obbediscono al principio di uguaglianza formale che il codice loro garantisce, portano impresso il peso sociale del loro conio, tant’è che sia chi li emette, sia chi li riceve lo legge. Il dio ti fulmini odierno non è dunque un flatus vocis, né solo sfogo, ma l’atto pubblico d’insubordinazione, per questo chi lo riceve non ne ride.
Edificanti i casi in cui difetti la lettura del peso di chi parla, inducendo a prendere fischi per fiaschi e a subirne la sanzione. Interessantissimo è l’attuale diffondersi epidemico, anonimo, con considerevoli effetti politico-sociali, delle false notizie credute vere. Non infrequentemente tale fenomeno si accompagna al suo opposto: la falsa notizia è coniata da fonte nota, il cui grande peso sociale garantisce della verità, al punto che quand’anche, dopo qualche tempo, la medesima fonte la riconoscesse falsa – è capitato –, non per questo cessa l’effetto precedente. In entrambi i casi, è con evidenza lo stato di sottomissione sociale causa del danno.
27 dicembre 2016
Il presente testo è stato condotto sul dattiloscritto concessomi dall'amichevole cortesia dell'Autore. L'opera è ora uscita da Castelvecchi (v.a.).
Leggi l'intervento di Mario Marchionne: http://velioabati.altervista.org/discussione-con-fuori-squadra-io-di-enzo-scandurra.html
La Conversazione è presene anche in Officina dei Saperi: http://www.officinadeisaperi.it/wp-content/uploads/2017/01/conversazione_Fuori_squadra_ABATI.pdf
Velio Abati
Conversazione con Fuori squadra io di Enzo Scandurra
Ci sono amici di una vita e ci sono amicizie importanti che nascono in un solo giorno.
Come se ci si fosse frequentati in un'altra vita passata.
E. Scandurra
Biografie.
Alcuni, tra i miei maestri, mi hanno parlato della loro passione per il genere biografico, con il suo sottogenere dell’autobiografia. Genere medico, genere criminologico, genere filosofico… nel secolo scorso il comune campo originario – la letteratura – è esploso. I metri cubi di carta scritti sono oggi proliferati nei milioni di bit dei cosiddetti social, cui il mezzo offre l’ampliamento di foto, autoscatti e filmati.
Osservando il fenomeno dalla coda, non è difficile diagnosticarvi l’angoscia dell’anonimato, il furore esibizionista della desertificazione, gli urli nel vuoto di chi è rimasto senza parola. Tuttavia proprio scrutando questo ribollire apparentemente caotico della condizione umana, è possibile vedervi nuda la ragione intima, necessaria e assolutamente nobile del raccontarsi, che è darsi un senso. Ai mortali di Omero non bastava l’agire, avevano bisogno del riconoscimento degli altri. Noi, più modesti o più ciechi, lo attendiamo dalla nostra coscienza.
Sarà forse per questa lunga pratica – se davvero progresso si dà nella “scienza umana” – che oggi siamo assai prudenti a prestar fede nell’aderenza della memoria ai fatti, dell’autobiografia alla vita. Ciò che Dante dice di sé disceso dal Paradiso vediamo valere per ciascuno di noi in relazione ai fatti e ai pensieri della nostra vita, perché il “trasumanar” è l’atto stesso di dar senso, stabilire relazioni e gerarchie a ciò che è avvenuto e avviene, a ciò che abbiamo agito e detto; perché l’oblio non è l’esorbitanza divina, ma lo scarto necessario – non importa se volontario o meno – per togliere “il troppo e il vano” dalla casualità del nostro agire e subire, almeno quel tanto da rendere sopportabile e augurabile il nostro percorso e il nostro fine, costantemente buttati di fronte al fatto che la materia dell’uno e dell’altro è unica e finita.
Armadillidium vulgaris
“Un giorno, molti anni prima, durante un intervento a un convegno, in un’aula gremita di colleghi e studenti, mi ero inaspettatamente interrotto nel mezzo del discorso e, colto da panico, rinchiuso in un imbarazzante quanto imprevedibile silenzio. Avevo ripreso a parlare diversi minuti dopo, giustificando quell’interruzione con il sopravvento di uno shock emotivo”.
Il lettore deve resistere al rinvio automatico alla Coscienza sveviana, tanto più che tale pressione arriva in altra parte a ostentare il confronto tra l’io narrante e il claudicante Zeno. Per quanto lo Scandurra che si racconta in Fuori squadra io ricorra a una mossa di pensiero che sembra presa di peso da una delle innumeri capriole ironiche della Coscienza (“Non potrebbe essere l’inadeguatezza un efficace antidoto contro la barbarie quotidiana che tutti accettiamo come fosse una condizione naturale?”), un abisso separa le due voci. Per dirlo sbrigativamente, la ferita che Ettore Schmitz si è portato dietro per tutta la vita non è mai arrivata a trafiggere lo schermo tra il giorno e la notte, tra pubblico e privato. Per assicurarsi che la chiusura restasse salda, non solo egli addebita la Coscienza a Zeno Cosini, ma per tener tutto il più possibile alla larga da Ettore, firma il resoconto con un nome de plume: passione per l’argine che aveva oscuramente presto cercato con l’Ettore Samigli degli esordi.
Nessuno pseudonimo, invece, nessuna esibita ‘invenzione’ letteraria nell’opera di Scandurra. Le due facce si sono fuse.
Il racconto prende le mosse dall’oggi, articolandosi in un lungo flash back, per riconnettersi alla fine con l’iniziale tempo della scrittura. In quelle pagine d’avvio l’autore si arma di un omaggio alla Recherche proustiana, solo che la madeleine nella prosa asciutta di Scandurra è diventata il feroce cancro alla prostata. Lo schermo, si diceva, è stracciato.
Tra le punte dello scompiglio libertario che tra i Sessanta e i Settanta irrompe nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro e nelle famiglie, c’è una bandiera per prima impugnata dalle femministe: il privato è pubblico. Non si discute qui se si trattasse, come allora si pretendeva, di una proposizione anti-borghese o meno, anche perché nei fatti sociali nulla è definibile per statuto teorico, fuori dell’agire pratico, storico degli uomini in carne e ossa. Preme semplicemente constatare che la separazione “borghese” lì presa di mira è stata abbattuta nel senso comune – se non nella pratica effettiva – e che la fusione in tal modo ottenuta tra le due facce dura tutt’ora. Uno scompiglio che non solo ha segnato irreversibilmente le generazioni che a quel vento si sono formate, cui Scandurra appartiene, ma in forme e intensità diverse ha modificato anche latitudini sociali e generazioni che poco o nulla di quei fatti lontani sanno. Personalmente sono convinto che assumere tale massima a norma di condotta e di giudizio permetta di spostare più avanti il punto di contraddizione del vivere civile.
I titoli della geometria su cui si struttura il racconto sono trasparenti già nell’indice: Il tempo sepolto, Il tempo sospeso, La città dentro di me, Il tempo fuori squadra, Il tempo ritrovato. La città, centro del lavoro scientifico dell’urbanista che si racconta e centro biografico, è sovrastata dal tema vero dell’opera: il tempo. Scrive nel Tempo ritrovato:
“Mi spendevo fisicamente, senza sosta, per costruire muretti, spianare rilievi, spaccare e demolire le rocce affioranti, attrezzare quei luoghi selvatici per farli diventare accoglienti. Il mio era un tentativo interminabile di dare ordine a quei luoghi sottraendoli al caos delle leggi naturali, ogni piccola vittoria riportata su quella natura selvaggia, ogni piccolo spazio sottratto al caos e diventato praticabile, mi procurava una grande soddisfazione; quello solo avrebbe resistito all’attacco del tempo, quando i miei nipoti, un giorno, avrebbero detto: «Lo ha fatto il nonno!»”.
Il lettore avrà facilmente colto il sentimento prevalente: la nostalgia d’integrità. Marx l’avrebbe chiamato “il sogno di una cosa”. Ci si trova di fronte a uno stato d’animo e a una mossa teorica straordinariamente diffusa nella cultura del Novecento, per quanto diversamente vestita e orientata. A me è capitato d’indagarla nella mirabile prolificità della poesia zanzottiana, dove si presenta sotto forma di spinta orfica, o nella sofferta lotta antiborghese di Franco Fortini, voglio dire nella sua strenua assunzione a norma etica e teorica di una totalità necessaria.
Nella prosa disadorna del passo in esame, molteplici forze sotterranee premono verso una ricomposizione umana, il cui proclamato raggiungimento non riesce a nasconderne l’irrealtà, quanto l’immedicabile bisogno. Ricomposizione di mente – principale strumento di azione personale e sociale del professor Scandurra – e corpo, da cui il piacere fisico della fatica. Ricomposizione di ambiente artificiale – la metropoli romana, dove opera e vita dell’autore si sono svolte – e ambiente naturale della campagna, nella forma dell’antropizzazione mite compiuta sulla natura ostile. Ricomposizione tra il tempo pubblico dell’impegno accademico e tempo privato della vita biologica, nella forma della memoria fidente del lascito familiare.
Vi incontriamo uno snodo delicato, che può oggi essere seriamente travisato, tanto più che lo stesso narratore parrebbe in più punti autorizzarlo. Ma di questo più avanti. Se invece da quel punto ci volgiamo indietro, registriamo lì il precipitare di uno scontro tra posizioni inconciliabili.
Un pomeriggio estivo ero, insieme con il poeta Roberto Bugliani, ospite di Franco Fortini, nella sua villa di Montemarcello, là dove oggi riposano le sue ceneri. Nel mezzo di una discussione, in cui come sempre Fortini straripava, con la timidezza e l’impeto propri della mia condizione di giovane universitario, mi capitò di sostenere che il buon agire politico non poteva non accompagnarsi, per coerenza, a una bontà nell’agire quotidiano e personale. A distanza di tanti decenni, posso arrossire dell’ingenuità utopistica di pensarne immediata la realizzazione, ma nello stesso tempo né rinnego di un grammo quella necessità, né temo la sfrontatezza di affermare che a quella norma ho disperatamente cercato fedeltà, pagandone prezzi salati di contraddizioni, scorni ed emarginazioni.
Fortini, che era ciò che sopra si diceva e tanto ruolo di maestro aveva avuto nei movimenti del Sessantotto, ma che in altra precedente stagione si era formato, rispose con energia che gl’individui sono come quei minuscoli crostacei che vivono nei muri umidi delle case di montagna, i maialini: se si concentrano sul loro io si arrotolano, se però vogliono uscire dall’immobilità, guardare gli altri e procedere devono distendersi.
Tempi
Lo sconvolgimento che, d’improvviso, dalle fondamenta travolge il corpo e l’animo, impone al soggetto Fuori squadra io di riraccontarsi per sopravvivere. La durata e la direzione del tempo prorompono con tutto il furore dell’inevitabile. È necessario un argine, all’istinto del nulla. Nel gravoso lavoro psichico e razionale della narrazione è venuto in soccorso l’habitus dell’ingegnere: la ricomposizione del tempo è assecondata dalla struttura circolare della materia, che a sua volta è forma della ricomposizione della persona che si racconta. Nella nuova condizione segnata dalla catastrofe, emerge il rilievo – sia per la durata, sia per il valore - assunto ora dall’insieme dei gesti, degli sguardi, degli oggetti che potremmo dir appartenere alla condizione primigenia della vita, mentre in altro tempo sfuggivano persino alla percezione. Nella prosa sempre sorvegliata, esplicito è il ribaltamento delle gerarchie tra il presente ricongiunto al lontano passato e il tempo intermedio della maturità.
Si argomentava sopra che la riorganizzazione del senso perseguita dall’io narrante non è – come il pensiero spontaneo potrebbe suggerire – uno spostarsi fuori della storia, ma è un lavoro intimamente segnato dal suo radicamento storico, sia presente che passato. Chi, sul finire dei Sessanta, proclamava che il privato è pubblico, sapeva di compiere la medesima mossa intellettuale e morale di chi criticava la separatezza dell’agire pratico dalla politica, si trattasse della ‘nobiltà’ della ricerca scientifica, o del ‘volgare’ tengo famiglia. Io sono tra coloro che tutt’oggi ritengono che il meglio di quegli anni ricchi e convulsi si trovi nella critica alla neutralità della scienza, della cultura e alla separatezza del ceto politico. Così come l’opera per una società migliore voleva dire tentar di praticare una vita comune migliore, allo stesso modo l’attività politica era prima di tutto la politicizzazione dell’attività che ti dà il pane e del ruolo che ti distingue nella società. Va da sé che quanto qui si dice non vale come giudizio complessivo: non sono mancati infingimenti, paurose illusioni, stupide forzature, contraddizioni madornali denunciate dalle stesse pagine di Fuori squadra io.
Il primo, macroscopico dato è che chi si racconta condanna al silenzio l’intera sua attività scientifica. Fatto tanto più clamoroso se si tiene d’occhio il ruolo di Scandurra nel rompere le ristrettezze settoriali, sia tecniche che accademiche, del suo campo di competenza, l’urbanistica. È vero che quando, in più luoghi, il racconto ne parla, lo fa ricorrendo proprio allo sguardo critico sopra richiamato. Di mira è infatti il cinismo strumentale nei giochi di potere accademico. Ma l’io narrante presenta se stesso come se l’intera sua carriera professionale ne fosse interamente ed esclusivamente segnata. È un fatto che sia l’atteggiamento complessivo, sia giudizi specifici bollano di falsità e imbroglio la propria intera vita scientifica e professionale.
Eppure capita d’incontrare un breve capitolo, quasi un inciso pudico: l’episodio della conferenza al centro sociale dell’ex colorificio di Pisa, dove chi si narra dice di essersi sentito lì a casa propria: “Peccato non aver portato il cagnolino; insieme – pensai – avremmo potuto restare anche la notte”. Appena uno slancio smorzato, quasi una preterizione, tuttavia sufficiente a schiudere un’altra scena, a mettere in sospetto un lettore che troppo si fosse fidato della lettera impegnata a tacere l’esistenza di una diversa pratica e senso del sapere scientifico. Né sfuggirà un’altra pagina di medesimo tenore, per quanto collocata nell’inversa posizione della deprecazione, là dove, parlando della condizione odierna dell’università, essa è definita un enorme laboratorio meccanico dove pezzi analizzati con cura sono oramai senza vita: “avevo abbandonato quel laboratorio dopo che per anni avevo tentato di ricostituire l’unità della creatura smontata e privata della sua anima”.
È proprio questo pertugio, credo, a indicarci che il rifiuto del ruolo accademico e soprattutto il vasto silenzio dell’attività scientifica siano propriamente il disgusto non di ciò che Scandurra ha fatto e scritto – come pure la lettera suggerisce - ma di ciò che il ruolo accademico e l’attività scientifica sono nel frattempo diventati.
Il lavoro di ricostruzione della persona prende, su questo versante, le vesti della negazione – o, per dir meglio, della denegazione – a segnalare, credo, un di più di frustrazione; diverso è il percorso dell’impegno politico. Qui, lungi dal forzare sotto un giudizio negativo l’intera durata della militanza politica, si sottolinea ricorrentemente il declino delle condizioni che l’hanno resa possibile e non ci si sottrae a rievocare l’entusiasmo di ‘allora’, per quanto nei termini distaccati propri del tempo della narrazione. Il titolo del capitoletto, Prendevamo a calci la luna, dove più direttamente se ne parla è un trasparente omaggio all’opera memoriale di Pietro Ingrao, Volevo la luna. Intellettuale politico cui si dedica non casualmente il ricordo rattenuto dei suoi funerali. Il tono degli excursus sul tema, ricorrenti non solo nel tempo passato ma anche in quello attuale, è di disillusa resistenza. Chi si ri-racconta ha scelto una postazione che, se per un verso rifiuta il simulacro che ancora si chiama politica, per l’altro non cede al cinismo scettico di chi eternizza il presente. Non è difficile trovarne numerosi segni, non ultima l’evocazione fraterna di Bruno Amoroso. Ma per tutti può bastare la citazione condivisa di una testimonianza ingraiana, tanto più tenace e consona a chi si racconta, perché mette a nudo una faglia intima, dove personale e pubblico, sentimento e ragione, pensare ed essere, destino personale e destino collettivo si fondono naturalmente:
«Io sento penosamente la sofferenza altrui: dei più deboli, o più esattamente dei più offesi. Ma la sento perché pesa a me: per così dire, mi dà fastidio, mi fa star male. Quindi, in un certo senso, non è un agire per gli altri: è un agire per me. Perché alcune sofferenze degli altri mi sono insopportabili. Questo episodio può dire la ragione per cui io rimango incollato alla politica, persino sotto l’aspetto tattico. Non sono sicuro che ciò si possa rappresentare come una motivazione morale. C’entrano gli altri, in quanto la loro condizione mi turba, e senza gli altri non esisto (nemmeno sarei nato)».
Credo che qui s’incontri il punto più fondo, da cui origina la forza e la ragione prima del lavoro strenuo e severissimo compiuto dall’io per ri-trovare una propria unità. Questi è rimasto fedele alla ricerca di un’esistenza che fugga il più possibile le ipocrisie dei compartimenti stagno, le contraddizioni della sopraffazione, le cesure tra pensare ed essere. Se la durata del tempo attuale dedicato ai gesti elementari del vivere quotidiano, all’osservazione della natura, alle attività ‘non-utili’, ovvero a tutti quegli elementi che, per chi guardi con l’occhio della prestazione e del potere nei ruoli sociali, risultano insignificanti o addirittura dannosi; se la durata di quel tempo – dicevo – è messa ora in primo piano contro il tempo ‘adulto’ della vita professionale, ciò non dipende da una regressione nel privato, ma dal conflitto oggi tornato drammatico tra il bisogno di una vita integra e le forme odierne assunte sia dall’attività politica che da quella accademico-scientifica. In Fuori squadra io fermenta un enzima mite e tenacissimo che, a chi ha la pazienza d’ascoltarlo, grida la falsità dei nomi che hanno perso la cosa, insieme con la spinta inesausta a dargli seguito.
Intanto che chi si racconta fa i conti con il farsi e disfarsi dei suoi e nostri tempi di vita, al centro permane, salda come l’amore filiale e incancellabile come il senso di colpa, una Roma eternamente plebea. Oggi più che mai emblema del nostro tempo.
24 ottobre 2016
SUL LETTORE
Velio Abati
Tre domande
“Purtroppo (oggi) -scrive Ennio Abate- è così: i post più impegnativi (e lunghi) non ricevono commenti. […] Non è detto che non siano letti, ma è come se non si sentisse più l'esigenza di affrontare tematiche complesse. Non è un problema da sottovalutare: non ci sono più i destinatari che noi ci aspetteremmo. E anche i più ben disposti faticano a stare sul piano di un discorso razionalmente esigente o di una ricerca letteraria non accomodante […] riflettiamo sulle ragioni di queste "resistenze" e sui modi migliori con cui potremmo reagire noi a questa situazione di crisi”
Posto che la rilevazione del fenomeno compiuta da Ennio sia corretta (si manifesta come un dato di fatto):
1) è questo vero in modo onnicomprensivo, o solo per certi ambiti della cultura e della sua circolazione?
2) quali sono le cause e gli effetti?
3) quale risposta dare, ossia quale atteggiamento pratico assumere?
Donatello Santarone
Caro Velio,
le domande che poni sono cruciali. Credo che quel che scrive Ennio sia la prassi più diffusa in relazione a questioni che richiedono sforzo, studio, concentrazione. Insomma, quello scavo verticale che Hegel definiva "la fatica del concetto". Non mi meraviglia più di tanto quando abbiamo un partito-movimento, i 5 stelle, che fondano il loro consenso su un click "mi piace"/"non mi piace". Ultimi di un lungo processo di imbarbarimento della società italiana iniziato negli anni Ottanta e oggi arrivato a compimento.
D'altronde le nostre verità - poetiche, storiche, politiche, educative... - sono oggi in Italia caricaturizzate o semplicemente ignorate. Per nostre verità intendo quelle del marxismo, del socialismo, del comunismo. Ma continuo comunque a pensare che di queste verità ci sia bisogno e che pertanto, in ogni sede dove ci sia consentito agire, vadano dette. Se in un blog non c'è risposta, in un’aula scolastica o universitaria, in un piccolo centro sociale, in una biblioteca comunale, in un'associazione di volontariato, ancora esiste la possibilità di uno scambio, di una reciprocità, di una relazione non mercantile. Questa per me è una speranza.
La cosa tragica è che questa indifferenza e ostilità e fango vengono propinate in quella che l'economista Vladimiro Giacché, in bel libro dedicato al suo maestro alla Normale di Pisa, Nicola Badaloni, definisce La fabbrica del falso (Imprimatur Editore 2016). Menzogne scientificamente organizzate per nascondere gli orrendi crimini - le guerre imperialiste per nominare esattamente le cose - che i nostri paesi vanno compiendo in tante parti del mondo per imporre la civiltà del denaro, unica ammessa dal Capitale. Le recenti menzogne sulla Siria e su Aleppo sono in questo clamorose: gli artefici della distruzione di un paese sovrano e laico, cioè gli Usa e l'Europa occidentale finanziatori e istruttori del terrorismo islamico insieme ai fedeli alleati di Israele, Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Ungheria, Romania, Paesi baltici ecc. ecc.,, ora attribuiscono al governo siriano e alla Russia la responsabilità di quanto sta accadendo. E' sconcertante! Ed è solo uno dei mille esempi che possiamo fare (vedere per tutto quello che ci viene taciuto il sempre aggiornatissimo sito di Noam Chomsky).
Walter Lorenzoni
Caro Velio,
mi sono venute in mente tante discussioni che avevamo fatto su questi temi ai tempi della Fondazione Luciano Bianciardi e del “Gabellino”. Mi sono andato a rivedere alcuni di questi vecchi materiali e, dopo circa vent'anni, certe analisi che lì erano solo abbozzate, perché rivolte a fenomeni in fieri, ora risultano ancora più valide di allora, perché i processi in atto si sono compiutamente dispiegati. Nell'Introduzione agli atti del convegno sulle riviste provai a sintetizzare queste pluriennali riflessioni del nostro gruppo di lavoro. D'altra parte, proprio in quel convegno, volendo guardare più lontano, decidemmo, con non poche titubanze iniziali, di inserire proprio un intervento sulle riviste di cultura telematiche.
Non sto quindi qui a ripetere quali sono le conseguenze di un eccesso di informazioni, di una spasmodica ricerca della velocità (Paul Virilio paragona la troppa velocità alla troppa luce: non si vede nulla), di una frammentazione dei dati e della loro separazione in rigidi comparti, della rapidità di consumo dei "prodotti" delle diverse possibilità di accesso ecc. ecc.
Nello specifico, quello che più mi sollecita, e al tempo stesso mi inquieta, non sono tanto le domande che fai, ma la premessa: "Posto che la rilevazione del fenomeno compiuta da Ennio sia corretta".
Il mio sospetto è che non si tratti tanto di lettori per qualche ragione "intimiditi", che sicuramente ci sono, ma soprattutto di non-lettori. Ormai diversi anni fa, uscì un libro di questo mediattivista olandese, Geert Lovink, intitolato Zero comment, in cui si diceva che, in oltre il 90% dei più di cento milioni di blog allora esistenti, compariva, immancabilmente, un tassativo "zero comment", alla faccia dell'interattività promessa dal cyberspazio ed esaltata dai cantori delle magnifiche sorti progressive della rete. Su questo, ormai, credo che ci siano analisi sociologiche abbastanza consolidate, che rendono ragione anche di quel mutamento antropologico che sta coinvolgendo sicuramente le nuove generazioni (a scuola abbiamo modo di osservare da vicino il fenomeno), ma che riguarda anche chi nativo digitale non è (mi capita di seguire superficialmente questo dibattito leggendo le pagine culturali del "Manifesto", in particolare Benedetto Vecchi, che, tra le infinite altre cose, si occupa anche di questo).
Sui pochi lettori, che credo, comunque, ci siano, visto che “Poliscritture” è una rivista di cultura sulle cui pagine si va solo se si hanno certi interessi, penso siano giuste le osservazioni di Ennio Abate: difficoltà ad affrontare la complessità e progressivo slittamento verso un interlocutore che non è più il nostro e non sappiamo riconoscere.
Cosa fare sul piano pratico (dici tu), per capire queste resistenze e reagirvi (dice Ennio)? Non so proporre niente oltre il riflettere, il parlare e il confrontarmi su questi problemi: alla fine quello che stiamo facendo (penso, tra le altre cose, ai tuoi Colloqui del Tonale). Volendo rimproverarmi qualcosa che non sto facendo, non riesco a trovarlo. Non che non mi venga in mente niente in termini di possibilità, ma non riesce, realisticamente, a convincermi. Di questi tempi, scorciatoie volontaristiche non ne vedo.
Velio Abati
Il primo elemento a colpirmi delle vostre sollecite risposte è la loro disposizione non complanare. Donatello si sofferma sulla capacità mistificatrice degli apparati ideologici di massa e quindi sulla corrosione, in Italia, della teoria critica identificata con il marxismo.
Walter si concentra sull’enorme massa di non lettori e sul mutamento ‘antropologico’ del ristretto campo di lettori, tale da renderli irriconoscibili e inavvicinabili alla nostra ‘lunghezza d’onda’.
Io credo che i due discorsi siano nel loro ambito perfettamente condivisibili. Al contempo credo che la loro non incidenza mostri quanto labile sia diventata la griglia concettuale in grado di rendere comprensibile il nostro mondo, almeno per chi voglia cambiarlo.
Io – tanto per complicare le cose – mi soffermo su un aspetto ulteriore, ovvero sulla drammatica verticalizzazione economica, sociale, culturale e politica prodotta dal finanzcapitalismo. Dico “drammatica” perché tale processo di spoliazione avviene con fenomeni di distruzione dei corpi intermedi – in termini di organismi sociali – e di impoverimento ora relativo, ora assoluto di ceti e classi sociali. Io credo che sia tale metamorfosi penetrata nel tessuto quotidiano della nostra vita a connotare il mutamento ‘antropologico’ visibile nell’uso dei media, piuttosto che essere principalmente questi ultimi a determinare il resto. Credo, in altre parole, che la lettura distesa, la ricchezza concettuale e argomentativa non siano – come del resto avviene per la ricchezza economica – affatto scomparse, ma piuttosto sequestrate in ambiti specialissimi. Lo credo, perché il mondo, dietro il caos capitalistico, è oggi più che mai governato dal centro: questo nessun click, nessun cinguettio può farlo. Ciò sia detto, beninteso, senza togliere il fatto che tale requisizione al vertice comporta danni mortali anche all’intero genere umano, a causa dell’autoinganno prodotto dal violento specialismo e separazione in cui vive. Se già Keynes diceva che il capitalismo si preoccupa dei tempi brevi, figuriamoci se non lo faccia oggi, quando la durata è misurata dal click.
Su un punto le vostre due riflessioni convergono, a cui anch’io mi unisco: la pochezza, vicina all’impotenza, della nostra possibilità pratica. Intanto che le nostre vite passano, ci affidiamo ai movimenti tellurici della storia. Tuttavia si continui a scrivere, a cercare, a scrutare luci nella notte.
4 ottobre 2016
Fin dove arriva lo sguardo
dalle cose nessun'eco si leva.
È notte alta.
Severi, tenerissimi impugnano
incerti
la penna.
5 luglio 2016
L’accoglienza nel Mattinale della poesia di altro autore – uno xenion per mia madre – mi è sembrata necessaria soprattutto perché la sua levità e la tenera tenacia della chiusa bene rispondono alla richiesta di colloquio fermo e pacato che il sito rivolge al navigante. v.a.
Mario Marchionne
PENSIERO PER ELDA
Il cielo incupito
non credeva ai suoi occhi
all'incedere lento e profondo
allo squillo degli anni
al volo improvviso di farfalla
al cardellino alle ali sinuose
al suono del vento e la pioggia
a sorreggere sguardi attenti
presenti come il senso di essere
vita di essere pronti ancora.
1 giugno 2016
Il pezzo che segue è il testo della lezione tenuta il giorno 4 maggio 2016 al corso di Didattica interculturale del prof. Donatello Santarone, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi "Roma Tre"
NON È VERO
La poesia di Composita solvantur di Franco Fortini
1. Leggere un’opera è un’esperienza complessa, perché come ogni atto comunicativo umano convoglia tacitamente una quantità più o meno grande di significati, derivanti sia dalla storicità di chi parla sia dai legami storici intrattenuti con altri dal messaggio trasmesso: un quantum che sebbene implicito non è meno determinante nella produzione del significato. Ma in più l’opera letteraria aggiunge uno specifico lavoro linguistico, perché per l’autore la lingua non è semplicemente il mezzo per dire qualcosa ma, nella necessità di dirlo, sente indispensabile una verifica della lingua stessa. È come se, accingendosi alla scrittura, l’autore avvertisse innanzitutto la menomazione indicata dal detto lacaniano: è la lingua che ci parla. Credo che si trovi qui la verità dei tanti autori che in epoche le più diverse hanno testimoniato la necessità di una parola da essi chiamata ora autentica, ora originale, ora necessaria, ora divina. Preciso che quanto dico non è affatto l’identificazione romantica del bello con l’originale, con lo spontaneo ecc., tant’è vero che Fortini può a ben diritto raccomandare al militante e al saggista il riuso linguistico e difendere la verità trasmessa dal linguaggio formulare del contadino comunista cinese, mentre nella propria poesia non disdegna l’uso manieristico della tradizione. Ma di questo più avanti.
Fatto sta che tutto ciò richiede al lettore competenza specifica, cosicché – per usare ancora le parole di Fortini – “il Petrarca per tutti non esiste”[1]. A mio parere, quando l’opera è grande parla comunque a livelli diversi, ma è indubbio che tale sua qualità possa essere piegata - e nelle attuali società tardo capitalistiche lo è - a un uso mistificato o, come si usa dire oggi, populistico, ossia ideologico, che serve a dare l’illusione dell’azzeramento delle differenze di valore. Naturalmente, tale livellamento, come detta la legge dell’Auditel, avviene sempre verso il basso e infine l’infimo, generando quella condizione diffusa che Edoarda Masi in un seminario chiamò, con efficace ossimoro, “ignoranza presuntuosa”.
Siccome, così come avviene nella comunicazione ordinaria, la comprensione passa prima di tutto attraverso la determinazione della particolarità di quanto ci viene detto, allo stesso modo, all’apertura di pagina di un’opera la prima domanda che dobbiamo farci è: qual è il tratto distintivo di questo testo, ciò che gli è proprio e che lo differenzia dagli altri? Si tratta insomma di cogliere, per dir così, la cellula vitale dell’organismo testuale che abbiamo di fronte.
2. Per la verifica della mia ipotesi interpretativa di Composita salvantur propongo di partire da un componimento che si colloca, diciamo così, su una medietà sia di livello stilistico che di difficoltà interpretativa, quello conclusivo della prima sezione, dal cui piccolo episodio riferito, se non dal suo titolo, essa trae il nome, L’animale. Il testo si apre con la ricostruzione ipotetica dell’aggressione notturna di un piccolo carnivoro contro una preda, a partire dai segni sanguinosi trovati la mattina “sottocasa” (v.2). Prosegue con la riflessione su dove ora si goda di sognare la propria aggressione, con termini che si fanno crudi. Improvvisamente, con uno scarto brusco la voce poetante interrompe la sua proiezione fantastica, per un ritorno alla realtà, quasi sospinta dal bisogno di scacciare le immagini divenute violente della propria fantasia: “Vedo il mare, è celeste, lietissime le vele” (v.11). Poi, un nuovo, e questa volta davvero immotivato, ulteriore scarto sia dal piano referenziale che da quello dalla vicenda ricostruita in ipotesi:
Vedo il mare, è celeste, lietissime le vele.
E non è vero.
Nessuna motivazione interna giustifica la perentoria negazione, che non pertiene, naturalmente, solo all’enallage aggettivale, ma coinvolge l’intera precedente constatazione paesaggistica, solido principio di realtà, al quale, mosso da un istinto di fuga, il poeta si era rivolto in opposizione all’aggressività della costruzione fantastica. Dico ‘scarto immotivato’, perché nessuna diversa descrizione corregge e sostituisce la constatazione del v.11. Dunque la genesi e il valore della negazione si dispiegano in un diverso piano: il no spalanca alla mente una dimensione prima rimasta nascosta.
Ripercorriamo la narrazione fino al v.11. Come in un microscopico giallo, la voce poetante, coerente al principio di verisimiglianza, ha ricostruito vicenda, vittima e assassino, poi ha immaginato il godimento sadico di questi. L’orrore provato l’ha spinto a guardarsi intorno, acquetandosi nella contemplazione della serenità del paesaggio. Sennonché la consapevolezza, non derivabile in alcun modo da quell’esperienza determinata, rammenta al soggetto che la realtà non è mai solo quella immediata. Per indicare tale punto non so trovare rinvio concettuale migliore di quello hegeliano di mediazione. Né in ciò compio alcuna forzatura esterna all’autore se, in un’intervista con Donatello Santarone afferma: “qualunque immediatezza è, senza possibilità di dubbio, reazionaria”[2].
Nel componimento la rottura dell’immediato si dispiega, a partire dal v.13, in due lati sovrapposti. Uno è quello temporale. Si apre il futuro, immaginato come sviluppo del sogno sadico precedente:
Il piccolo animale sanguinario
ha morso nel veleno
e ora cieco di luce
stride e combatte e implora dagli spini pietà.
Un’altra direzione è invece, diciamo così, dimensionale. Perduta la determinatezza di spazio – prima della svolta narrativa, “dove” si chiede tre volte il v.7 -, l’animale non è più solo il particolare carnivoro che la notte ha catturato la sua preda, ma, come una fiera dantesca, diventa allegoria di un’intera classe di assassini.
Il salto compiuto a partire dal v.12 ri-determina l’intera sequenza iniziale: il qui e ora si scoprono momento dialettico di altro tempo e altrove che li nega additando, con la mediazione, una totalità, cosicché un animale e una vittima diventano l’animale e la vittima. Totalità del reale, perché gli animali sono figura degli uomini; ma anche totalità della storia perché il momento attuale, quello della sopraffazione assassina
Chissà dove ora si gode, dove dorme, dove sogna
di mordere e fulmineo eliminare
dal ventre della vittima le parti
fetide, amare.
si scopre passaggio di un rovesciamento:
Il piccolo animale sanguinario
ha morso nel veleno
e ora cieco di luce
stride e combatte e implora dagli spini pietà.
Nella totalità così riconquistata, prende significato – o, se vogliamo, motivazione emotiva – anche lo scarto, immesso da un’altra scena, del ‘no’ del v.12. L’approdo del v.11 vorrebbe essere l’idillio che appaga e rasserena la pietà per la vittima, la pietra su cui si conclude il trionfo del carnefice. Sarebbe, in altre parole, la soppressione della storia, l’eternizzazione del presente, l’obbedienza all’ideologia del dominio. È precisamente in questo precipizio che nasce lo scatto del ‘no’, proveniente da una consapevolezza esterna, ma che si nutre della violenza patita nel gesto di sopraffazione materiale – tramite l’identificazione con la vittima – e ideologica, con la pretesa di proclamare la fine della storia: il sogno è solo il sogno del vincitore.
La rideterminazione compiuta dalla relazione dialettica tra i due opposti coinvolge anche lo stesso titolo. Se fino al salto del v.12 Stanotte appariva indicare l’unità temporale dell’antefatto, contrapposta al tempo attuale del mattino:
“sulle piastrelle
che illumina un bel sole”, vv.2-3
a conclusione della lettura del testo si scopre indicazione allegorica dell’attuale epoca storica. Il “bel sole” è il falso giorno dei padroni del mondo, è la notte della violenza patita dall’uomo ad opera dell’uomo, durante la quale germina una possibile fine degli assassini.
Abbiamo dunque mostrato come il componimento si costruisca su una frattura che giustappone due parti le quali, se prese nella loro immediatezza, appaiono incongruenti. Se ci si limitasse a ricercare le motivazioni interne sia dal lato del soggetto – psicologiche – sia dal lato della vicenda, non reperiremmo la ragione del passaggio dall’una parte all’altra, il testo apparirebbe un centone, piuttosto che un organismo. Solo facendo ricorso a una consapevolezza che distanzia, nella sua determinatezza, il qui e ora della vicenda e di chi la guarda, ovvero all’istanza della mediazione, si ricompongono entro la totalità le relazioni tra le due parti e la logica dello sviluppo narrativo.
3. Esclusivamente per comodità espositiva, il discorso condotto ha messo tra parentesi un versante essenziale, anzi primario come s’è detto, della poesia: la strutturazione ritmica. Ci si era ripromessi, si ricorderà, di partire da un’area di ‘medietà’ della raccolta, perché meglio si potesse cogliere, nel suo funzionamento ‘normale’, la parola specifica di Composita solvantur. D’altra parte solo uno sguardo analitico mostra la disomogeneità tra le due parti del componimento che, altrimenti, potrebbe passare inosservata.
Analoga spinta diffrattiva tra due forze divergenti troviamo nella strutturazione ritmica. A tutta prima, il testo si presenta una composizione in verso libero. Infatti i sedici versi non hanno partizioni strofiche, né regolarità rimica, è anzi presente un’unica rima canonica: “eliminare” : “amare” (v.8, v.10), eccezionalità che ne esalta il rilievo già derivante sia dal fatto che essa sottolinea il campo semantico dell’aggressività astuta del carnefice, sia dalla funzione di suggello del trionfo di questa prima dell’idillio. Tanto che l’acuto della rima si propaga anche nel v.11, dove si lega in rima interna baciata con la parola “mare”, lessema che in questo modo vede oscuramente contaminata la propria connotazione di serenità.
Ma l’irregolarità del verso libero adottato risulta nell’analisi tramata da un contrappunto che discretamente sospinge alla regolarità classica, ora conseguita, ora allusa. Cinque dei sedici versi sono endecasillabi regolari. La loro presenza è certamente sottolineata dal fatto che tutti sono a maiore, ovvero con accento di sesta. Ma come se tale avvicinamento alla misura aurea della lirica italiana risultasse inavvicinabile, pullula insieme una spinta opposta: tre dei cinque endecasillabi (vv.: 5, 8, 9) concludono il primo emistichio con una parola sdrucciola, possibilità che nella forma classica, osserva il metricista Elwert, “in effetti non si presenta mai”[3]. Se poi guardiamo la disposizione degli endecasillabi, osserviamo altre forze che spingono alla ricomposizione. Il primo e l’ultimo endecasillabo – i due con chiusura d’emistichio piana - si dispongono in sede perfettamente simmetrica: quarto e quartultimo verso. Si aggiunga che quattro di essi compongono due coppie contigue (vv.: 4-5, 8-9).
La latenza della misura classica non si ferma tuttavia ai casi osservati, tramando variamente l’intero componimento. L’endecasillabo – ancora in a maiore con emistichio piano - affiora, mascherato dalla divisione del verso ma non dalla partitura sintattica, al v.2: “ha ucciso una bestiola, sottocasa. Sulle piastrelle”. La giunzione di endecasillabo con quinario è ripetuta ai vv.9-10 con artificio simmetrico - è infatti qui mascherata dalla divisione del verso e certificata dal nesso sintattico, costretto appunto all’enjambement: “dal ventre della vittima le parti / fetide, amare”. Il quinario apparentemente isolato è comunque ripetuto al fondamentale v.12, il cui valore contrastivo precedentemente indagato è rinsaldato dalla giunzione a distanza con il suo omologo tramite la quasi rima: “amaRE : vERo” (vv.: 10, 12).
Altra forma evidente di pressione dell’istanza di chiusura classica si registra in quattro dei cinque versi lunghi del componimento, tanto che, come vedremo tra poco, solo uno di essi risulta davvero un verso libero o, secondo la metrica classica, ipermetro. Di uno si è già osservata la riorganizzazione sull’endecasillabo. Altri tre sono in realtà versi doppi, nelle forme autorizzate dalle sperimentazioni italiane dal Seicento al Carducci, passando per il romanticismo lombardo. Il già notato doppio ottonario (v.7) rispetta rigorosamente la cesura. La partitura è nella “forma normale”[4] trocaica con accenti di 1^, 3^, 5^, 7^ sillaba nel secondo emistichio, ‘irregolare’ invece, con accenti forti di 3^ e 7^ sillaba nel primo emistichio:
Chissà dÓve ora si gÒde, dÓve dÒrme, dÓve sÓgna
I due rimanenti sono settenari doppi. Nel primo caso, l’anticipazione dell’accento nel secondo emistichio, in concomitanza con l’aggettivo sdrucciolo e la doppia sibilante del superlativo, provoca un vistoso rallentamento di forte patos:
Vedo il mÀre, è celÈste, lietÌssime le vÉle.
Il secondo caso è il verso di chiusura. Qui la pressione della misura chiusa esercita, mi pare, la sua massima forza. Il primo emistichio è martellato da tre verbi in polisindeto, con accenti di 1^, 4^, 6^; mentre il secondo, segnato dalla concisione del verso tronco e dal cambio di passo di due soli accenti, scivola rapido alla conclusione:
strÌde e combÀtte e implÒra dagli spÌni pietÀ.
È questa una partitura ritmico-sintattica che insistentemente richiama un testo aureo del Manzoni lirico, al quale Fortini ha ripetutamente tributato apprezzamenti e attenzione critica. Penso alla strofe inaugurale della Pentecoste, un Inno la cui coralità insieme solenne e popolare di chiesa militante è dal poeta romantico giocata sulle tre misure del settenario: piano, sdrucciolo e tronco.
In particolare, mi pare indubbio nel primo emistichio fortiniano l’eco di “soffri, combatti e preghi”, di cui si conserva il verbo centrale e se ne parafrasano gli altri due. Il secondo emistichio, direi per attrazione, reca la rima tronca in –à, come la chiusa delle prime due strofi manzoniane: “dall’uno all’altro mar”.
4. Vedo nei risultati ottenuti sui due versanti la medesima tensione tra due opposti: tra la datità del presente che s’installa come realtà e la sua trasfigurazione allegorica; tra l’aura della misura ritmica classica e l’infrazione del verso libero. Sono due opposti che proprio in quanto tali risultano inseparabili, legati come sono dal loro medio. E se nel testo non si dà la loro soppressione, perché essa non è data nella realtà storica, cosicché essi permangono nella loro reciproca diffrazione, il medio, che almeno nell’organismo letterario insieme tacitamente l’incatena e li ricompone nella totalità artistica, non cessa di svegliare nel suo lettore la sferza dolorosa della sua mancanza, il bisogno di chiudere la pagina per cercare nella realtà dei rapporti umani e di quelli dell’uomo con la natura la realizzazione di quel sogno da svegli che l’opera d’arte è stata.
È inevitabile notare come l’istanza della mediazione sia agita dalla parola poetica fortiniana non nel movimento triadico classico di Hegel, ma si soffermi su quella sporgenza insieme straziata ed eversiva del linguaggio sapienziale maoista indicata con la formula ‘l’uno si divide in due’.
5. Se il nostro sguardo non ha sbagliato, se la tensione tra gli opposti trattenuti dall’istanza insieme necessaria e assente della mediazione è davvero la cellula vitale di Composita solvantur, essa sarà osservabile in ogni livello e in ogni regione dell’opera. Non è qui luogo e tempo di una verifica ugualmente distesa delle varie parti. Basterà compiere alcuni saggi lungo linee di forza ritenute portanti.
La spinta centripeta e, se vogliamo, di “ordine” esercitata dalla compostezza ritmica classica – la poesia, dice Fortini, è sempre la lingua dei padroni[5] – si fa evidente anche nell’organizzazione della raccolta che la struttura organicamente. Se si escludono i testi raccolti in Appendice, il libro, composto di cinque parti e di due componimenti singoli liminari, si dispone a cerchi concentrici intorno al cuore costituito da Sette canzonette del Golfo.
Rimandando alle considerazioni conclusive i due testi liminari, l’analisi rivela che i sette componimenti dell’Animale e gli otto della sezione eponima, Composita solvantur, si costituiscono in simmetria già dalla scelta della titolazione: tutti i testi di esse sono desunti dall’incipit. Condizione altrimenti presente nella sola sezione centrale. Inoltre le due sezioni si caratterizzano per un’analoga media compostezza formale, con accentuazione nell’ultima, che infatti è aperta da un componimento in latino “da passi della Vulgata” – ci spiega in nota l’autore -, e si chiude con testo di tre terzine composte da due ottonari accoppiati seguiti da un verso costituito da ottonario più quaternario sdrucciolo. Non manca anche qui l’opposta forza diffrattiva per la quale nell’ultima strofe l’emistichio di chiusura del secondo verso è esattamente di misura dimezzata: un quaternario piano. Mentre il primo emistichio del primo verso è un ottonario sdrucciolo. L’inciampo metrico coincide con il grido agonico del proprio corpo: “più non posso”, che è poi il tema esplicito del componimento, della sezione e del libro. È appunto nello strazio di questa catastrofe che trova origine la maggiore pressione alla chiusura formale.
Risulta qui chiaro come il titolo del libro esponga, nella lingua marmorea dei padri, la stessa cellula vitale costitutiva dell’opera: l’ordine costituito – che in quanto tale si pretende definitivo – si dissolva, dove il verbo è, nota acutamente l’autore, “comando e augurio”, ovvero non deterministico. E ancora una volta assistiamo alla trasposizione che fa dell’agonia di Franco Fortini l’exemplum della ‘presente stagione’, per dirla con Leopardi, della nostra epoca tardo capitalistica.
Le undici Brevi elegie, come manifesta il titolo, allentano la compostezza tematica e stilistica della prima sezione sia aprendosi all’interlocuzione con autori, intellettuali amici discretamente indicati con il solo nome di battesimo o con le iniziali, studenti, sia cedendo ora alla nota melanconica, ora a quella patetica:
Dove ora siete, infelici studenti,
nelle sere delle nevi vane,
aule nere, Siena, conventi,
trattorie di salsicce, cacio, pane…
Movimento d’una venerando tradizione occidentale, risalente per lo meno al celebre ritornello della Ballade des Dames du temps jadis di François Villon: “Mais où sont les neiges d'antan?”
Per l’allentarsi della chiusura stilistica basti indicare l’affacciarsi scoperto del falsetto, ora a partire dalla poesia alta, Umberto Saba, ora dalla canzone popolare di Aniello Califano, ’O surdato nnamurato, italianizzata. In quest’ultimo caso, la spinta ironica e distanziante propria del falsetto si rende più esplicita.
E siamo così nel cuore del libro, Sette canzonette del Golfo. Già la prima parte del titolo dichiara il tono metrico-stilistico della sezione, mentre la seconda rinvia didatticamente alla vicenda storica. L’esibizione di genere lieve, popolaresco e narrativo è direttamente contrapposto alla gravità della “operazione di «polizia» tra il Golfo Persico e Bagdad”, annota il poeta, che nel 1991 “ammazzò centinaia di migliaia di persone, aprendo una nuova era nelle relazioni internazionali”. I testi vivono in un equilibrio davvero miracoloso tra ironia e angoscia dell’impotenza, tra gioco metrico citazionale spinto fino alla nenia infantile e devastazione del più potente esercito del mondo. In questa sezione troviamo anche il sonetto Gli imperatori, norma aurea appena infranta da una rima imperfetta al terzo verso. Ma culmine della straordinaria tensione che riesce a tenere sotto controllo e proprio per questo a comunicare rabbia e disperazione mi pare la Canzonetta in distici di senari doppi a rima baciata.
Un intero capitolo dovrebbe essere dedicato a commento. Ma una notazione non possiamo omettere, lo facciamo con le parole di Elwert: “il dodecasillabo, o senario doppio, con cesura mediana, fu impiegato dal Manzoni per il bell’effetto ritmico che se ne otteneva (e di certo ad imitazione del verso de arte mayor spagnolo), ma esso non attecchì: «Dagli atri muscosi, dai fori cadenti»”[6].
Dopo la discesa al cuore del libro, i cinque componimenti lunghi della Salita per un verso si lasciano alle spalle la cantabilità e l’ironia, per l’altro mantengono la misura argomentativa e narrativa. Tornano gli espliciti rinvii alla maniera del falsetto, l’interlocuzione con compagni, intellettuali ecc. Su di un piano metrico-stilistico ci si avvicina alla chiusura già indicata dell’ultima sezione.
I due componimenti liminari sono, come si premura di sottolineare l’autore in nota, gli unici “in corsivo e senza titolo”, dunque con esplicita funzione di soglia. Nel primo l’appello ai lettori è ovvio omaggio alla tradizione lirica occidentale, a principiare dal petrarchesco “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”:
Per quanto cerchi di dividere
con voi dal vero le parole,
ma il monostico a chiusura della prima parte del componimento ricorda piuttosto l’incipit della raccolta che forse più di altre inaugura la lirica moderna, Les fleurs du mal, là dove Baudelaire squarcia la tradizionale complicità con il proprio lettore “-Hypocrite lecteure, - mon semblable, - mon frère!”:
o incerti amici, o incerte prove
Alla discreta compostezza del componimento introduttivo – due parti di tre distici di novenari chiusi da un monostico di diversa lunghezza – risponde un congedo ben più drammatico e complesso, come già la nota autoriale avverte: “piuttosto che una sequenza di versi mi pare una epitome autobiografica: «E questo è il sonno» sono le prime parole del primo verso di Foglio di via, lo scrissi cinquant’anni fa”. Questo testo contiene tra l’altro tra virgolette le parole presunte– citiamo ancora la nota – del “commissario politico che, insieme ai «ventotto» eroi di Panfilov, fino alla propria morte volontaria contrastò vittoriosamente fanterie e carri armati tedeschi all’incrocio fra lo stradale di Volokolamsk e quello di Duboskovo, nel giorno e nel luogo dell’estrema vicinanza della Wehrmacht alla capitale sovietica. Pare avesse detto «La Russia è grande ma non abbiamo più dove ritirarci perché dietro di noi c’è Mosca»”. Il congedo chiude l’ultima raccolta fortiniana, appena tre anni prima della morte con questo verso:
Proteggete le nostre verità.
Quel “voi” siamo noi. Quel verso non significa, come apparentemente dice, che la sua verità è la nostra, che il futuro nasce dalla memoria. No. Non lo dice, perché la mediazione su cui si regge la parola poetica di Fortini apre la porta alla negazione dell’assolutezza dell’esistente, fa spazio a un possibile, non ne indica i contorni. Fortini, in compagnia di molti altri, sa con chiarezza che è il futuro che abbiamo in mente a determinare la memoria. Tutta l’opera poetica, saggistica, intellettuale e politica di Fortini ci dichiara che il consunto detto ‘non c’è futuro senza memoria’ va rovesciato: non c’è memoria senza futuro. Per questo quel verso testamentario ci addita trepido che solo se e nella misura in cui noi sappiamo far valere le nostre verità, anche la sua strenua lotta fisica e mentale, per affermare la mediazione, diventerà vera.
[1]Franco Fortini, «Fermezza, ardore, gravità», in Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a cura di Velio Abati, Torino, Boringhieri, 2003, p.375.
[2] Franco Fortini, Le catene che danno le ali, in Un dialogo ininterrotto, cit., p.301.
[3] W.T.Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Firenze, Le Monnier, 1979, p.53.
[4] W.T.Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, cit., p.75.
[5] Tra i numerosi luoghi si veda: “La poesia e l’arte, che sono «forma», si presentano come l’emanazione diretta della classe avversaria, cioè di quel gruppo di uomini, o di quella parte di ciascuno di noi, che è invece, o crede di essere, nell’essenza, e non soltanto nell’esistenza, che è o crede di essere proprietaria (proprietaria del proprio destino, proprietaria del sapere, proprietaria di «Dio»”, Franco Fortini, Il mestiere di poeta, in Un dialogo ininterrotto, cit., p.77.
[6] W.T.Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, cit., p.80, corsivi dell’Autore.
5 maggio 2016
Ricordavo bene Giacinto
Ricordavo bene Giacinto. Era un uomo riservato. Parlava con voce leggermente nasale, meglio, di gola, con gli occhi fermi in terra, o se alzava la fronte te li teneva di lato, dietro la spalla. Per questo, forse, non risultava simpatico. Però Giacinto non era uno qualunque. L’ho conosciuto un po’ tardi, perché in quel tempo io di rado attraversavo le piazze della nostra cittadina, rapido e guardingo come un gatto fugato. Altri erano i pesi del mattino e il sonno torpido. Oltretutto, scoprii poi, egli apparteneva a un mondo d’interessi e poteri, di amicizie, di sguardi sulle cose e sugli uomini che né mai era stato mio, né, soprattutto, allorché cominciai meglio a capirmi, sentivo amico. Certo nella foga degl’inizi non potevo sapere le sofferenze e i meriti antichi di quella parte e nemmeno m’interessava indagarne. Vedevo però con nettezza, con l’istinto millenario della mia gente che ora, per me, per noi era un muro e ne scrissi, ricordo. Una paginetta veemente consegnata a un foglio locale, che per un attimo – venni a sapere – provocò sorpresa, per il tono e per la firma ignota.
Benché oggi risulti incomprensibile, tanto che persino io devo obbligarmi a uno sforzo per rientrare nei panni di allora figuriamoci uno qualunque dei miei stessi allievi, in quel tempo non era difficile trovare qualcuno che come te guardasse con allarmata speranza al destino comune, con ragionata passione alla concreta condizione di quanti la sorte ci ha dato d'incontrare. Su questo, sulla risposta in cui ognuno impegnava se stesso si stringevano lotte e accordi, si decideva il futuro. Giacinto lo incontravo dunque di rado. Sapevo che nella nostra cittadina, dove la forza delle cose e l'allora inconsapevole obbedienza all'onestà con la prima radice mi avevano riportato una volta per sempre, egli già aveva fondato e dirigeva la sezione locale di un'istituzione gloriosa, per quanto volta a una strada più modesta e persino umiliata, fino all'inganno. Così noi pensavamo e ancor oggi nella sostanza seguito a giudicare. Le nostre discussioni allora erano rare, si può dire occasionali, non cercate. Nei miei ricordi, mi vedo con un libro in mano, Giacinto di là dalla lunga fila di libri. Si avvicinava a volte, più per il confronto che per il pur legittimo interesse a vendere: una discussione rapida, qualche battuta guardinga mentre intorno e alle spalle sciamavano volti e scambi serrati o distratti.
Ma la stagione in cui più regolare è stata la nostra frequentazione è venuta dopo. I rapidi rivolgimenti che hanno segnato i brevi decenni declinanti del secolo scorso avevano convinto lui a cambiar strada. Dico, e mi accorgo invece che forse si trattava d’altro. Ho già detto che era di poche parole. La voce, per quanto bassa, gli usciva sempre di testa, come se la gola dovesse sforzarsi per un qualche nodo, l’incarnato del volto, rossastro, ti dava l’impressione della fatica della parola, ma certo le pause, i silenzi cercavano la misura giusta. Se Giacinto era parco, di sé poi in tutti quegli anni non mi ha praticamente detto nulla. Avvertivo comunque negli sguardi il diniego di seguire certi sovvertimenti, per la necessità di un altro, superiore dovere, che ne aveva segnato la messa ai margini, di cui percepivo la furia della solitudine e del rancore. D’altra parte era iniziata la stagione che un mio amico – mite persona, resa dalla malvagità dei tempi risentito poeta - chiamava del disamore. Qualcosa di potente aveva preso energia, era cresciuto, nei corpi, nelle menti, nel tessuto minimo delle ore, talmente inavvertito che solo a fatto concluso hai potuto scorgere, sbigottito, con quanta velocità e quanto in profondo aveva slogato i legami, frantumato lo spazio, bruciati i giorni come attimi.
Io invece a quel tempo sembravo vivere un’altra stagione. Una sfasatura, seppi poi. I suoi silenzi mi parlavano. Avvertivo nelle sue impuntature, nei suoi scarti urticati un moto fraterno che mai poteva essere detto, né diversamente alluso. Passavo da lui, ogni tanto, sempre per una necessità pratica. Il libro frugato nelle babeli elettroniche, il volume inseguito negli scantinati del mercato potevano certo essere da me trovati e comprati direttamente, come infatti faceva da tempo un mio amico, risparmiando, diceva, soldi e tempo. Ma io andavo da Giacinto.
Pur conoscendo che io non acquistavo mai quello che c’era, non era impaziente vedendomi, perché condivideva, anche se non ne abbiamo mai parlato, il mio sprezzo per la moda: carota del bastone di comando. Lasciava qualunque altro impegno e si tuffava con qualche brontolio in ricerche a volte affannose da cui usciva ogni volta con un breve sorriso compiaciuto. In quel tempo aveva principiato a portare dei baffetti corti, vagamente biondi ma oramai quasi bianchi, che meglio facevano risaltare i piccoli occhi chiari, quando si ricordavano di guardarti. Nelle presentazioni dei libri – mi è capitato di farne, sempre proposte da me – avviate in primissima serata, appena dopo l’orario di chiusura, ascoltava con grande attenzione. E interveniva, nel caso incurante di ogni riguardo di venditore, solo seguendo le ragioni del suo animo.
Giacinto scomparve così, da un giorno all’altro.
Le saracinesche chiuse del piccolo edificio liberty ad angolo intristivano ancor più le modeste stradette della nostra cittadina. Ogni tanto ci passavo, non capivo. Di domandare avevo timore. Alla fine qualcuno disse che era partito. Anzi, per essere precisi, la persona che mi parlava, dopo essersi avvicinata e aver abbassato la voce, “scappato”, mi disse.
- E dove? Perché?
Scosse la fronte, nessuno sapeva.
Sarei insincero se non ammettessi che a volte soffro il peso dei silenzi. Uscire in bicicletta alla prima luce del febbraio che s’allarga nei campi e sulle case di periferia, fin quasi ai piedi dei colli distanti ancora glauchi mi rincuora. Guardo quel sorriso amico, respiro pieno i profumi antichi, meglio se i raggi bassi mi chiudono la vista. Ho tutto il giorno davanti, schizzo via veloce, mai scalo il cambio alla bicicletta. Eppure proprio in quel culmine intimo, per uno scatto inavvertito, nativo forse, ma nutrito da studi e attenzioni tocco con mano come quella costanza che mi circonda, che mi fa festa sia in realtà quasi al culmine d’un precipizio che travolgerà noi, causa prima, e altra catena innumere di esseri.
Lavoro, con la passione della mia vita, sull’ottusità programmata, nutrita fino al punto d’essere naturale forza delle cose. Cerco, con la fatica paziente che accolgo dai millenni della mia gente della terra, sentieri divenuti anfratti, dove le voci parlano come di eremiti. Fuochi dispersi nella notte, mi disse una volta un mio maestro. So che la verità non è, se non ha un luogo, se non svela il nome dei servi e del padrone. Ho imparato subito dalla mano forte di mio padre che la verità non è, se non viene comunicata, se non la si scambia come il pane caldo di forno, anche quando taglia come una spada, quando ti annichilisce. Per questo sprofondo talvolta nel buio, dispero della mia pazienza.
Nel percorso che da parecchio compio quotidianamente per campare, c’è un breve tratto serpentino, dentro un palmizio che scende fino a toccarti la testa e s’allontana inusitato dalla strada del traffico, con buffa pretesa d’esotico. Lì, correndo sui pedali, vedo alla svolta camminare una figura nota che saluto. Freno di colpo subito dopo. Quasi cado, più che scendere. Torno indietro.
- Giacinto!
Portava una barbetta arsiccia, un cappelletto rotondo in capo, forse a nascondere la calvizie, di foggia credo orientale. L’abbraccio d’impeto. Mi dice che è di passaggio, per due o tre giorni, l’indomani sarebbe ripartito. Parla fluido, con voce chiara. Sono contento, dice guardandomi diritto, di aver rivisto qualcheduno e in particolare te. Gli occhi gli tremano un poco. Non aveva niente con sé, camminava solo, forse stava solamente guardando le case, gli alberi, il cielo. Mi ha fatto piacere, riprende, ritrovare il profumo di questa terra, la dolcezza del mare. Improvvisamente, come un’amnesia ostinata che si sciolga imprevista, comprendo l’oscuro groviglio del suo intervento aggressivo nell’ultima presentazione, persa nel tempo. Per la serata, avevo fatto invitare un poeta schivo fino alla fobia. Il cerimoniale complesso e, pensavo, persino ostentato di azioni, pillole, tic di cui questi s’armava ogni volta che parlasse in pubblico, la lentezza sussurrata della voce non ingannavano nessuno sulla salda sicurezza di sé e delle proprie affermazioni. Giacinto fu tra i primi a prendere la parola, dal fondo della corta fila di sedie. S’appigliò a non so più quale concetto o verso, aggredì senza argine l’ospite e qualche parte della mia breve presentazione, si disperse in epoche che, s’intravedeva, erano state della sua vita, s’accalorava con la voce strozzata su ognuna di esse, come a volerle insieme difendere e seppellire. I suoi piccoli occhi tondi si muovevano in basso o a mezz’aria, ma quando fissava qualcuno dei presenti vi si rivelava l’ira repressa, che il colorirsi del volto sul breve collo e il flusso tumultuoso della voce rendevano palpabile. Ce ne andammo in silenzio, né per la strada del ritorno seppi trovare risposte alle lamentele irritate e velenose del poeta.
Continuo a guardare i suoi abiti austeri e comodi da viaggio, gli chiedo dove sia andato, dove viva. Mi risponde d’essere vissuto alcuni anni in un Paese dell’estremo oriente, poi d’essersi trasferito in uno limitrofo. Ora, dice, sta per partire per un altro ancora. A sessant’anni passati, mi sorride, bisogna sapere che non hai altro tempo. Non ho il coraggio di chiedere di più, della moglie, dei figli, della famiglia. Rivolgo una domanda obliqua. Solo, mi risponde sereno, queste cose si fanno soli, con la propria anima. Mentre continuo a guardarlo, penso alle foreste dense, ai colori e ai profumi che non ho mai visto, ai cieli senza fine, agli spazi dove l’occhio si perde senz’alcuna presenza umana.
Nel salutarlo, mi accorgo che reggo la bicicletta restata tra me e lui. Bonne chance, gli dico. Giacinto giunge le mani, sorride, piega leggermente il tronco verso di me e pronuncia poche parole, mi sembrano indiane.
Sì, lo conoscevo bene, Giacinto.
25 aprile 2016
La discussione avviata da Walter Lorenzoni – qui sotto -, proseguita con un intervento mio e con un altro di Mario Marchionne, si arricchisce di un nuovo contributo. v.a.
Claudia Musolesi
Aperti al futuro
Buongiorno caro Velio.
Intanto grazie per aver condiviso con me questa informazione che, immagino, riapra in te emozioni e ricordi di momenti passati.
Come sai, io da tempo non frequento più gli ambienti politici e pseudo-intellettuali grossetani. Approfitto qui per dirti che i due articoli/saggi (tuo e di Walter) nel Mattinale, li ho trovati interessati, precisi e aperti al futuro. Dico aperti al futuro perché, a mio avviso, le analisi giuste e non opportunistiche sono i punti di partenza per nuove costruzioni. Di idee e di relazioni.
Ben ha fatto Walter, a ricordare l'improvvisazione di alcune scelte politiche che con un colpo di spugna cancellarono anni di lavoro e orizzonti possibili di reale cambiamento.
Nei miei seminari, io utilizzo come uno dei punti di riferimento Lacan. Lacan sostenne (e questo rappresenta un punto forte del suo pensiero) che se ciascun* di noi non ritorna alla ferita esistenziale e lì risignifica il proprio agire, finirà per reiterare sempre il gesto del/la bambin* fragile che risponde alla vita in modo vendicativo. È nel ritorno alla ferita esistenziale (che Lacan individua nel compimento di un gesto concreto, volontario o no, che ha come effetto quello di umiliare/disconoscere/ferire il bambino o la bambina), è nel nominarla, nell'accettarla e nel trasformarla che l'uomo e la donna adulta trovano la loro soggettività. Un percorso lungo e faticoso, mai dato una volta per tutte.
Grosseto è una terra difficile. In questo momento in cui me ne sto allontanando, sto riscoprendo i profumi, i suoni ed i colori della terra dove sono cresciuta. Hanno contribuito a fare di me quella che sono. Ma è una terra periferica che (certo non per sua scelta o per vocazione naturale) si presta a colonizzazioni semplificatorie e di basso profilo.
Sono convinta che il ruolo della Fondazione Luciano Bianciardi sia stato pregnante e nutriente per questa città. Ma come ricordi tu, il Novecento si è chiuso. E con quel secolo, si è chiusa l'idea di soggettività che affondava le sue radici sul rispetto delle differenze e sul valore dell'unicità di ciascun soggetto.
Ho scritto di getto. Perdona la poco fluidità del discorso. Ma ho tenuto a scriverti subito.
Buon Natale. Un caro abbraccio
24 dicembre 2015
Accolgo qui una riflessione inviatami dall’autore sulla discussione avviata da Walter Lorenzoni – qui sotto – e proseguita con il mio intervento. v.a.
Mario Marchionne
Le esperienze durevoli
Carissimo compagno Velio (mi permetto di esibire una simile espressione visto che ci avviciniamo al santo natale!),
ho trovato lo scritto di Walter Lorenzoni molto interessante ed anche di una grande tristezza, non per quello che dice, totalmente condivisibile, ma per il fatto che non siamo stati capaci di avere la capacità di intuire la portata pratica del craxismo e del conseguente berlusconismo, ora del renzismo. Ciò mi sgomenta ma credo anche, nonostante tutto, che ci siano le energie per trovare una nuova via.
L'esperienza della Fondazione Luciano Bianciardi credo che sia stata fondamentale e non lo dico così, ma perché ha costruito un percorso culturale attivo, sia come analisi culturale che come apertura verso l'esterno. Sono convinto sempre più che le specificità conoscitive siano necessarie, così come, tanto più in questi tempi, l'apertura verso nuove esperienze e forme di comunicazione.
Per quanto riguarda la parte relativa alle vicende editoriali so poco, o meglio, so quello che a suo tempo mi avevi detto e che trovo interessante in due punti essenziali: marginalità in risorse e fare rivista, due momenti complicatissimi e, tuttavia, necessari. Tutto ciò si inscrive in un quadro, da quanto ho capito, anche di rapporto con le istituzioni. Avete sperimentato il voltafaccia dei berlusconiani di sinistra che hanno fatto cose peggiori del grande padre. Di solito gli epigoni sono patetici, ma a me sembra che, ultimamente, patetici siamo noi che non riusciamo a sconfiggere questi individui che ormai sono diventati senso comune (Gramsci).
Un'esperienza come la vostra non può essere altro che un punto di riferimento per nuove avventure, tutte da inventare. Sono convinto che le esperienze durevoli sono quelle strutturate dalle conoscenze personali, condivisibili o meno.
I partititi di notabili e comitati elettorali mi stanno perseguitando e trovo la questione di uno squallore infinito. È vero e dobbiamo metterci in testa che i sindaci al comando, i consigli comunali ruote di scorta, le leggi e le definizioni della realtà a beneficio del potere sono ormai pervasivi. Fortunatamente esistono ancora le persone ed anche, in diversi casi, le capacità dialettiche e di lotta per relazionarsi con la realtà. Quando penso ai giovani (anche ai nostri figli) che avranno pensioni miserrime di cui godranno con la badante, mi sembra che manchi il senso della dimensione del futuro e questo è quello che più mi angoscia. Trovare paradigmi di comprensione del reale è possibile ma va fatto in tempi rapidi e, soprattutto, va condiviso e reso attuabile.
24 dicembre 2015
Simulacri e nuovi germogli
Pubblico anche qui l'intervento di un dibattito nato nella rivista di Ennio Abate, "Poliscritture"
http://www.poliscritture.it/tag/velio-abati/
La parabola della rivista “Il Gabellino” descritta perfettamente da Walter Lorenzoni qui sotto è parte della vicenda della Fondazione Luciano Bianciardi. Una piccola storia, di un’area geografica e sociale marginale come la provincia di Grosseto. Tuttavia può ammaestrare sull’epoca.
Sono convinto che la sofferenza più grande nel nostro tempo sia la ferita dell’impotenza. E dico ferita nel senso di strappo interiore, silenzioso, oscuro. Impotenza: dell’agire, certo; ma anche del comprendere, del vedere il domani.
Quante volte, ascoltando la parola istituzionale rimbalzata contemporaneamente da quindici diversi canali comunicativi, sentiamo insopportabile l’offesa della falsificazione spudorata, sbalordiamo di fronte alla faccia tosta dei più impensati capovolgimenti di senso? Un’esperienza quotidiana da così tanto tempo, che ho dovuto chiedermi perché quella tal distanza della propaganda dalla realtà non spinga al riso, invece che alla rabbia. Tutto nasce dalla differenza verticale, incolmabile tra il singolo grido - eppur si muove! – che non ha eco e quel rimbombo istituzionale.
C’è un passo di Pierre Bourdieu che insegna come il corteo di una manifestazione costituisca la soglia che fa trapassare una certa richiesta o un certo giudizio da opinione personale a giudizio e richiesta legittima. Quella rabbia e quell’impotenza patite sono appunto la ferita di tale mancanza. Dobbiamo tornare a imparare che senza un progetto e un agire collettivo le nostre ragioni sono destinate a rimanere ridicole perché assurde, che noi abbiamo i capelli rossi perché siamo maliziosi e cattivi.
Grosseto è un incrocio di campagna. Fino alla fine dell’Ottocento d’estate si svuotava per la malaria, fino alla seconda guerra mondiale era quasi tutta compresa dentro la piccola cerchia muraria cinquecentesca, abnorme, perché fuori tempo massimo, struttura militare che – sghignazza Bianciardi – serviva tutt’al più a difendere la campagna dalla città. Giustamente Bianciardi e Cassola ironizzarono impazienti con i cultori di “glorie” locali. Poterono farlo perché i minatori, i braccianti, i contadini trovarono nei sindacati, nelle forze politiche della sinistra – partito comunista e socialista, in particolare – i luoghi per comprendere e dove parlare, gli strumenti per farsi sentire. Non può essere un caso che in quella stagione ricostruttiva del secondo dopoguerra due scrittori importanti vi operarono e uno vi crebbe. Che cosa avrebbe scritto Luciano Bianciardi senza quel clima e quella presenza? Come avrebbe potuto andare a Milano, nel gruppo di redattori con cui Giangiacomo Feltrinelli faceva nascere la casa editrice? Per questa ragione profonda ho sempre ritenuto puerile, quando non ipocrita ogni etichettatura “anarchica” – in realtà anticomunista – di Bianciardi.
Che il transito di Cassola a Grosseto sia stato breve e che Bianciardi sia emigrato a Milano, rientrano nella legge generale che fa del centro l’attrazione delle periferie. Sarebbe semmai da vedere perché nel ventennio italiano del centro-sinistra e dello sviluppo quella spinta a Grosseto si sia dispersa, perché, anzi, le effervescenze della contestazione studentesca e operaia del Sessantotto siano rimaste largamente inefficaci, ovvero non hanno potuto dar vita a novità culturali paragonabili ai due scrittori degli anni Cinquanta. Credo che le ragioni di tale fenomeno siano in parte le medesime che spiegano come proprio con l’avvio della crisi del Pci, principiata con la svolta occhettiana della Bolognina, alcune energie nutrite dai movimenti del Sessantotto abbiano coagulato nella nascita della Fondazione Luciano Bianciardi. Per giudicare l’operato di quel gruppo durato quasi un quindicennio, basta avere la pazienza di andarsi a computare i volumi pubblicati con Editori Riuniti, Giunti e infine Società Editrice Fiorentina, i convegni di studi, le ricerche e le produzioni filmiche, la promozione delle tesi di laurea con un premio nazionale, la chiamata di scrittori e scrittrici della migrazione da aree del Mediterraneo, i lavori con le scuole, la raccolta di carte, carteggi, testimonianze bianciardiane, la produzione delle Concordanze dell’opera in volume di Bianciardi, la bibliografia di Bianciardi, la costruzione del Fondo autori contemporanei, la costruzione del Fondo riviste di cultura, il semestrale “Il Gabellino”, l’organizzazione di seminari, incontri pubblici su un amplissimo raggio di temi.
La differenza fondamentale tra il sodalizio dei due scrittori negli anni Cinquanta e l’operato del gruppo della Fondazione Luciano Bianciardi è stato l’intento esplicito di quest’ultimo di creare a Grosseto un nuovo istituto culturale, che avesse la funzione di sedimentare energie locali non ignare dell’orizzonte complessivo e quindi possedesse la capacità di interloquire e far da filtro. Ma allorché la vecchia organizzazione politica del Pci uscì convulsamente dal suo smarrimento – l’amministrazione comunale grossetana fu la prima vittoria elettorale di Forza Italia nella ‘rossa’ Toscana – e tornò al comando mutata in quello che è oggi, ossia un partito di notabili in lotta per il comando di pezzi di territorio e dello stato, quell’esperienza fu abbattuta con un fuoco di fila a mezzo stampa, che tutto – opere e persone - ha falsificato, lordato, calunniato, ridicolizzato, nel giro di una ventina di giorni condotti senza esclusione di colpi di giornali compiacenti.
Anche a Grosseto, il Novecento è finito: con le forme politiche e sindacali, è consegnata alla storia una certa figura d’intellettuale, di cui il gruppo della Fondazione Luciano Bianciardi ha fatto parte. Le gallerie della vecchia talpa non sono visibili, ma come sono convinto che quanto si erge è in gran parte simulacro, così ho ferma fiducia che tra quanto appare rovina radicano operosi nuovi germogli.
8 dicembre 2015
Questa volta, contrariamente alla consuetidine di questa rubrica, mi sembra importante lasciare la parola ad altri. Ripubblico dunque qui uno scritto uscito sulla rivista on-line di Ennio Abate, "Poliscritture". v.a.
http://www.poliscritture.it/2015/12/01/cera-una-volta-il-gabellino/
Walter Lorenzoni
C'era una volta "Il Gabellino"
«Il Gabellino» (1999-2006) nacque come semestrale della Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto ed interpretava l’esigenza di un gruppo culturale, già attivo da diversi anni, di continuare il proprio percorso di lavoro dotandosi di uno strumento che fosse, nel contempo, uno spazio di riflessione e un’occasione di interlocuzione con altri soggetti. Fin da subito, fece proprio il duplice profilo, istituzionale e militante, che caratterizzava la Fondazione, impegnata sia nella conservazione che nella produzione culturale. La rivista, per un verso, gravitava intorno alla figura di Bianciardi e alle varie attività dell’istituzione di riferimento e, per un altro, invece, ricercava un’autonoma proposta intellettuale, nella direzione di uno sguardo «civile» sulla realtà, tentando così di allargare i propri orizzonti culturali al di fuori dell’ambito specifico di competenza. La scommessa fu quella di un periodico che sapesse muoversi tra radicamento nel territorio d’origine – cercando di valorizzarne le risorse presenti e di sviluppare competenze – ed apertura verso l’esterno, in direzione della intellettualità diffusa nata dai processi di scolarizzazione del secondo Novecento e dislocata, prevalentemente, negli ambiti dell’insegnamento, dell’editoria, del giornalismo e dell’informazione in genere; quell’intellettualità di massa strutturalmente divisa tra i ruoli subalterni ad essa imposti dall’industria della comunicazione e l’urgenza di liberarsi da questa posizione subordinata. L’obiettivo, neanche troppo sottinteso, era dunque di creare, in una realtà fortemente periferica, un luogo di aggregazione e di dibattito culturale che sapesse interpretare e stare dentro la stagione dei grandi movimenti del tempo, impegnati contro la guerra e nella critica alla globalizzazione neoliberista.
Il titolo, tratto da un topos bianciardiano presente nel romanzo Aprire il fuoco, alludeva al confine, allo spazio di frontiera, marginale e insidioso, ma, allo stesso tempo, anche capace di guardare oltre e quindi ricco di potenzialità; voleva indicare una sorta di paradigma della condizione in cui la Fondazione Luciano Bianciardi si trovava a riflettere e ad operare. L’idea che la marginalità potesse essere trasformata in risorsa, che costituisse un punto di osservazione in qualche modo privilegiato per portare lo sguardo oltre l’imperante omologazione mediatica e rappresentasse un luogo speciale per cogliere le trasformazioni in atto e per proporre un discorso pubblico alternativo a quello dominante, ricorrerà costantemente – forse, a volte, ripensandoci ora, con qualche ingenuità di troppo – dal primo all’ultimo numero del «Gabellino». Il profilo istituzionale, per la rivista, risultava, al tempo stesso, limitante e fecondo. Da un lato, infatti, dover dar conto di tutte le questioni legate alla vita della Fondazione portava via tempo ed energie preziose. Spesso, poi, risultavano necessari anche dei compromessi (solitamente di tipo qualitativo), non potendo rifiutare ospitalità a chi si muoveva entro le coordinate istituzionali da noi tracciate e che era nostro compito stimolare e far crescere. Dall’altro lato, però, l’essere istituzione era una sorta di garanzia di credibilità, apriva porte che altrimenti sarebbero rimaste chiuse, permetteva una molteplicità di contatti intellettuali che sarebbe stato difficile avere presentandosi come semplice rivista. Alcuni progetti, ad esempio il Fondo autori contemporanei, prima, e il Fondo riviste di cultura, poi, favorirono una serie di «agganci» che ci consentirono di avviare, all’interno del periodico, dibattiti e riflessioni che, di volta in volta, riuscivano addirittura a coinvolgere interi blocchi di interlocutori (insegnanti, redattori, autori). Tutto questo rese possibile l’apertura del semestrale a collaborazioni sempre più numerose e a tematiche diverse: la scrittura femminile, l’intercultura, l’editoria, la scuola, il «far rivista», l’intellettualità di massa. Il cuore del «Gabellino», ciò che ne incarnava lo spirito militante, divenne sempre di più il «Dossier» (allegato ad ogni numero) che cresceva o diminuiva a seconda delle partecipazioni e delle iniziative via via intraprese.
La redazione era composta, principalmente, da insegnanti, ma, per quanto riguarda i più giovani, anche da qualche lavoratore precario del settore intellettuale. Tutti vivevano e operavano nel nostro territorio. L’organizzazione redazionale prevedeva, innanzi tutto, due riunioni collegiali: la prima in fase di progettazione del numero e la seconda al momento della chiusura. L’apertura alle diverse collaborazioni e l’esistenza di rubriche fisse sul «Dossier» faceva sì, tuttavia, che il fascicolo potesse modificarsi significativamente in corso d’opera. Il lavoro più importante, poi, fatto in maniera continuativa (per email, per telefono, o in occasione della riunione settimanale della Fondazione) era svolto da me (direttore editoriale) e da Velio Abati (direttore del comitato scientifico della Fondazione). Gli altri redattori partecipavano, in prevalenza, per le parti loro assegnate inizialmente o per le rubriche fisse di cui si occupavano. Accanto alle attività specificamente legate al semestrale, la redazione si impegnò poi, nel corso degli anni, nel promuovere forme di coordinamento tra le riviste di cultura che presentavano prospettive intellettuali simili e avevano un comune orizzonte di riferimento. L’intenzione era di provare a realizzare un percorso condiviso di crescita in termini organizzativi e di riflessione intorno alla questione del «far rivista», proprio sfruttando la peculiare posizione istituzionale che ci consentiva di diventare un punto stabile di riferimento in un contesto, quello delle riviste di cultura, segnato da frammentarietà, precarietà organizzativa, incertezze economiche e di altra varia natura. Nacquero così numerose iniziative (incontro alla Fiera del libro di Torino, mostra e convegno sulle riviste di cultura a Grosseto, seminari sulle e tra le riviste, spazio del «Dossier» appositamente dedicato al confronto critico tra redattori e riviste), anche se, però – come forse già allora avremmo dovuto prevedere –, proprio per la peculiarità che ci contraddistingueva, la nostra spinta militante fu spesso trasformata dagli interlocutori in semplice aspettativa istituzionale.
Statisticamente, le riviste di cultura muoiono o per forza d’inerzia, per il graduale esaurirsi delle motivazioni e delle attese iniziali, oppure per conflitti di vario genere (personali, intellettuali, organizzativi) che vengono a crearsi tra i redattori. In ogni caso, a venir meno sono le basi di quella che, al di là delle molteplici differenze, si configura sempre come un’impresa collettiva. Nel caso del «Gabellino», invece, le circostanze furono completamente diverse, perché la sua fine coincise con un momento di maturità e di crescita ed avvenne a causa di un traumatico defenestramento politico che riguardò tutto il gruppo di lavoro della Fondazione. Il paradosso è che la cacciata si verificò in corrispondenza del ritorno del centrosinistra al governo del comune, dopo dieci anni di amministrazione di destra. La Fondazione Luciano Bianciardi era nata nel 1993 su iniziativa della CGIL locale, della famiglia dello scrittore e di altri soggetti economici; ad essa avevano aderito poi, tra gli altri, anche il comune e la provincia di Grosseto, gli enti che garantivano le risorse più significative. Durante il decennio di amministrazione comunale berlusconiana, aveva dovuto sopportare tagli cospicui ed era stata costretta a muoversi con prudenza di fronte ad un assessorato alla cultura che, in certi frangenti, interpretò in maniera molto aggressiva la vulgata allora ricorrente, approdata anche sulla stampa nazionale, della caduta di Grosseto, amministrazione ininterrottamente «rossa» dal 1945 in poi, come testa di ponte per la futura conquista dell’intera Toscana. Nonostante tutto ciò, a nessuno venne mai in mente, però, di occupare e smantellare la Fondazione per farne una propria piazzaforte. La bella idea, purtroppo, ce l’ebbe la nuova giunta di centrosinistra che, sfruttando il malumore di alcuni componenti della famiglia Bianciardi per un’attività, a loro giudizio, troppo debordante rispetto al tranquillo orticello bianciardiano, trovò una sponda per lanciare, sui compiacenti giornali locali, una diffamatoria campagna di stampa che chiedeva, tout court, l’azzeramento del vecchio gruppo di lavoro. Chi, per ruolo istituzionale, avrebbe potuto bloccare questa deriva, vuoi per insipienza vuoi per opportunismo, o tacque o saltò rapidamente sul carro dei vincitori.
A bocce ferme, dopo circa tre mesi dagli eventi, Donatello Santarone, sul «Manifesto» (12 ottobre 2006), tratteggiò con rara lucidità quello che era successo, ipotizzando l’aprirsi, a sinistra, di una nuova stagione che, per certi versi, si sta dispiegando completamente sotto i nostri occhi solo oggi:
La prima, istruttiva, lezione dell’affaire riguarda la natura dei partiti politici trasformati in «puri» comitati elettorali. Il loro comportamento, seppur aggiornato, ricorda l’esperienza ottocentesca dei partiti di notabili. E come in passato mal sopportano non solo conflitti, ma anche voci dissonanti rispetto al loro operato. L’autonomia intellettuale e organizzativa è dunque vista come un’«inefficienza sistemica», mentre l’accentramento dei poteri e dei ruoli è considerato funzionale al controllo delle idee, della «distribuzione razionalizzata» delle risorse e delle conseguenti strategie elettorali. In quest’ottica, non c’è spazio per un lavoro in profondità capace di sedimentare competenze e valorizzare i «giacimenti culturali» e le reti sociali presenti a livello locale. Le fondazioni e le istituzioni culturali devono semmai funzionare come macchine produttrici di eventi che abbiano come «effetto collaterale» variazioni significative sul consenso elettorale. Da questo punto di vista la crisi della Fondazione Luciano Bianciardi può essere interpretata come il fatto che il lascito del berlusconismo sia ancora presente non solo nella società, ma anche nella sinistra politica, incapace di sviluppare un proprio «ordine del discorso» autonomo dalle logiche del mercato, sia quando attestano l’avvento di una generica società dell’informazione o quando annunciano la fine delle «grandi narrazioni».
L’eliminazione del vecchio gruppo non significò la chiusura della Fondazione, quindi, formalmente, il periodico sarebbe dovuto continuare con i nuovi arrivati. Anche se tentativi in questa direzione ci furono, e lo sappiamo per certo, i fatti, ad ogni buon conto, non andarono così, perché «Il Gabellino» era diventato ormai una macchina complessa, che richiedeva un impegno costante, giornaliero quasi, e non lasciava spazio a improvvisazioni o velleitarismi di sorta. Non si riuscì a proseguire neanche con un semplice bollettino istituzionale, rigorosamente vincolato alla figura di Bianciardi, cosa che poteva rappresentare, comunque, una valida alternativa dopo che erano state allontanate le componenti troppo militanti, sempre nel senso culturale del termine, che costituivano la redazione precedente.
E noi, i «destituiti», non avremmo potuto provare a continuare con una nuova testata? Certamente non con il cartaceo, per un problema di costi, ma senz’altro con una rivista online, tenuto conto anche che, come qualcuno fece notare, eliminata la «zavorra istituzionale», si sarebbero potute liberare nuove forze ed energie. Da una prima ricognizione, emerse subito, tuttavia, che si sarebbe trattato di una soluzione del tutto diversa, con un prodotto finale molto distante dall’originale. E questo proprio perché la rivista, nella sua cifra specifica, si reggeva, per l’appunto, su quell’equilibrio particolare tra profilo militante e istituzionale che fin dagli inizi era stato, per «Il Gabellino», non un elemento di ambiguità, ma un ingrediente vitale. Tolto uno dei termini della coppia, quella rivista, su cui tanto avevamo scommesso ed investito, non esisteva più. E così si preferì lasciar perdere, facendo poi ognuno scelte individuali differenti.
A distanza ormai di dieci anni, credo che quell’esperienza possa essere ora maggiormente apprezzata, per il tentativo fatto, in un contesto periferico e di oggettiva marginalità, di costruire un luogo e un gruppo di riflessione capace di interloquire in modo autentico con una molteplicità di soggetti intellettuali distribuiti sull’intero territorio nazionale ed anche oltre. Oggi, anche se il tempo trascorso non è poi molto, appare del tutto impensabile, in una realtà come la nostra – e forse non solo come la nostra – un’avventura come quella del «Gabellino». E segni che qualcosa del genere possa avvenire in un immediato futuro qui non si vedono.
1 dicembre 2015
Diari
Non c’è bisogno degl’insegnamenti, numerosi e autorevoli, dei secoli: basta una riflessione onesta, per vedere che prima di prender parola si deve rispondere a poche domande non evitabili. Se non altro perché la ‘risposta’ c’è già, anche se non vogliamo saperne. Così, dopo lunga erranza nelle lettere, torno al rendiconto.
In nome di chi parlo? Se scrivo un’analisi didattica per i miei alunni – ne ho prodotte – so di parlare prima di tutto in nome dell’istituzione scolastica che mi ha formato, oggi in profonda disgregazione; poi in nome dell’istituzione letteraria in drammatica perdita di ruolo e di statuto; infine in nome di una parte - minoritaria quanto mai - di quell’istituzione, che cerca di tenere insieme il testo e l’extratesto, il bello e il vero, la storia e l’antropologia, lo storico e il biologico.
Fuori non so più chi sono. Se va bene, scrivo una pagina di diario.
A chi parlo? In un caso so di parlare a giovani che tentano di guadagnarsi un bonus in più da spendere nella roulette del lavoro. So però che chi mi ascolta mi attribuisce più o meno autorità.
Nell’altro non so più niente. So che da qualche parte ancora esiste – immagino che esista – un ceto di severi e competenti studiosi di cose letterarie. So che quel distretto ipotetico, dove si posseggono le lingue della Terra – deve pur esistere, per alcune funzioni indispensabili al comando del mondo –, è lontanissimo dai bisogni e dai valori che la mia vita e gli studi chiamano a non tradire. So allora che chi incontrerà la mia parola, lo farà nelle intermittenze della chiacchiera imbonitoria, dello spettacolo triviale, degli assilli incomponibili del giorno, nelle solitudini affollate, nell’insensato travolgimento della vita.
A che serve ciò che dico? Di fronte ai miei alunni so che, in forza del nome per cui parlo, posso tentare di svegliare in chi ascolta qualche domanda di senso su di sé e sul mondo che ci circonda. So che posso controllare in una certa misura il risultato del mio dire e fare. So che posso attendermi qualche alzata di spalle o qualche domanda ammonitrici.
Altrove posso solo tentare di costruire il diagramma dialettico in cui si delinei e non si disperda l’attrito di forze del mio essere nel mondo tra gli aprili della pagina, la strada che mi attende la mattina per guadagnarmi il pane e le scosse profonde del presente. Scommessa al buio, nella supposizione – supponente? - che qualcuno vi si riconosca o vi si riscontri o vi si contrapponga.
Di qui, la rarità della mia scrittura critica, ispida e condensata, illudendomi che essa sporga il suo inciampo, evochi un soprassalto da verità inattese, inascoltate.
23 settembre 2015
Giorgio Luzzi, Troppo tardi per Santiago
La già corposa produzione luzziana presenta al lettore un nuovo libro importante che include anche la sequenza Rogo alla Thyssen-krupp, composta a seguito dell’orrida morte dei sette operai della fonderia torinese nel dicembre 2007, sequenza musicata da Guarnieri e rappresentata lo scorso autunno al teatro Astra di quella città con la regia di Alberto Jona. La costitutiva preminenza del tutto sulle parti dell’opera d’arte è da Giorgio Luzzi assecondata da un sorvegliato intento costruttivo, evidente a partire dalla titolazione, impiegata per un verso a complicare le fughe semantiche del componimento e per l’altro a strutturare legami d’insieme nella raccolta, per cui il profilo dei testi e delle sezioni precedentemente usciti in forme occasionali acquista ora un significato parzialmente nuovo.
La radice nutritiva di Luzzi, classe 1940 “valtellinese di nascita e torinese d’elezione” come ama precisare, è riconoscibilmente mitteleuropea, con aperture all’area francese, cosicché non sorprende che la sua voce si collochi nell’espressionismo lombardo, sorretta per altro da una forte tensione narrativa. L’energia che la anima è principalmente etica, con esplicite incursioni civili, sostenuta dalla profonda convinzione nella responsabilità della parola e della poesia, cui è assegnato il compito di scavare oltre la falsa chiarezza di ciò che immediatamente appare, oltre l’inganno reiterato della comunicazione alla portata di tutti, arma del potere. Per questo i suoi testi sono slogati da una doppia tensione. Infatti mentre essi assecondano il bisogno di ancorarsi alla determinatezza ora con indicazioni circostanziali, appelli e sollecitazioni al lettore convocato nella scena, ora con continui ricorsi al dato cronachistico tramite inserti di voci in presa diretta e lacerti di dialogo, nel contempo tali agganci alla ruvidezza del principio di realtà sono violentemente virati in una dimensione altra, che dà al materiale denotativo forma spaesante, irriconoscibile. Il modus operandi principe è, insieme con l’elisione operata da un secco procedimento sineddotico, il montaggio. Per questo se la figura chiave è l’analogia, il ritmo è vistosamente segnato da ciò che altra volta ho cercato di riassumere con il termine sintattismo.
Uno dei primi elementi che colpiscono il lettore, perché vi si trama l’intera raccolta, è il tema del viaggio. Numerosi e disseminati sono i nomi di luogo: dall’amata Vienna al Vermont, dalla Francia ai paesi africani, per tacere di altri anonimi paesaggi e passaggi. Eppure a sondar oltre la superficie, si scorge un immorare, un patire che diresti da locus conclusus. Per meglio testare il senso di questa faglia, è necessario però percorrere un’altra strada.
Dicevo del primato etico della parola, della tensione a fare del tessuto poetico, per l’oltranza che gli è propria, il luogo dove vive il senso della vita del poeta e dell’ordine collettivo. Avverti in ogni mossa la nobiltà della parola, sia quando prende movenze da divertissement infantile, sia quando s’impenna nell’invettiva sarcastica. Da questa tensione nascono l’intermittente ricorso alle clausole gnomiche, la predilezione per le giunture analogiche rare, in lessico alto fino all’arcaismo o al neologismo. È insomma convogliata tutta una cerimonialità della parola che più si palesa laddove lo sforzo ultraneo dell’espressionismo diviene più rarefatto, in contrappeso a quell’avvicinamento alla materia storica che altra volta ho intravisto nella recente ricerca luzziana. In quei punti estremi avverti la tensione etica scoprire un uso difensivo della nobiltà della parola. Ferita squadernata dalla sincerità intrepida del poeta che percorre intera la strada scelta, giungendo a mettere a nudo la sua impotenza e sperimentando sulla propria carne la precarietà irrimediabile della propria scommessa: i viaggi forse sono irreali, così come l’onore della lingua diventa forse un gesto autoconsolatorio. Dico “propria”, ma naturalmente è di un’intera cultura che si parla. È una certa figura novecentesca di poeta che guarda smarrita il paesaggio sociale e umano, una cultura e una lingua sfigurati eppure ineludibili: mentre gridano che l’intera fase otto-novecentesca è finita, reclamano altre domande, altri gesti. Ecco, solo da questo ultimo orizzonte diviene chiaro il titolo, bellissimo, della raccolta: Troppo tardi per Santiago. Quasi fraterno e oscuro rinvio a una poesia del viennese Karl Kraus, La domenica dopo la guerra: “Che ora è del giorno? / Troppo tardi”.
2 agosto 2015
Leggendo Fortini
Spettatori
Ben ch’io sappia che oblio
preme chi troppo all’età propria increbbe
Giacomo Leopardi, La ginestra
Sono solo; con le masse
Franco Fortini, 1984
1. Ci sono tempi in cui può essere segno d’onore il silenzio, perché l’ultimo modo per non concorrere direttamente o indirettamente all’ipertrofia della chiacchiera pubblica, per non alimentare l’ignoranza presuntuosa che, come già Socrate insegnava, allontana l’inizio della sapienza. Contro tale sopraffazione Franco Fortini ha lottato fino all’ultimo giorno. Si erge, con verità immutata, vent’anni dopo, una manciata di giorni prima della morte, avvenuta il 28 novembre 1994, una lettera che costituisce forse l’ultimo scritto, l’ultimo pensiero. Si rileggano alcune parti:
Spero di non dover mai stringere la mano né a Sgarbi né a Ferrara né ai loro equivalenti oggi esistenti anche nelle file dei “progressisti”.
[…] Tommaso d’Aquino, Marx, Pareto, Weber, Croce e Gramsci mi hanno insegnato che la libertà di espressione del pensiero, sempre politica, è sempre stata all’interno della cultura dominante anche quando la combatteva. Tutt’intorno ai suoi confini, però, c’erano, lungo i secoli, miliardi di analfabeti, inquisizioni mistiche o, a scelta, grassi dobermann accademici, reparti speciali di provocatori incaricati di picchiare tipografi e distruggere i manoscritti. Ci sono – puoi ordinarli per posta – manuali per l’uso della calunnia nel management della comunicazione, lupare bianche, colpi alla nuca; o, nel più soave dei casi, la damnatio memoriae.
[…] Chi finge di non vedere il ben coltivato degrado di qualità informativa, di grammatica e persino di tecnica giornalistica nella stampa e sui video, è complice di quelli che lo sanno, gemono e vi si lasciano dirigere. Come lo fu nel 1922 e nel 1925.
Non fascismo. Ma oscura voglia, e disperata, di dimissione e servitù; che è cosa diversa. Sono vecchio abbastanza per ricordare come tanti padri scendevano a patti, allora, in attesa che fossero tutti i padri a ingannare tutti i figli. Cerchiamo almeno di diminuire la quota degli ingannati. Ripuliamo la sintassi e le meningi. Non scriviamo un articolo al giorno ma impariamo a ripeterci, contro la audience e i contratti pubblicitari.
[…] Pagare di persona, secondo le regole del finto mercato che fingiamo di accettare: ossia dimettersi o costringere altrui alle dimissioni, ritirare o apporre le firme e le qualifiche e il proprio passato, affrontare sulla soglia di casa o di redazione le bastonature fisiche o morali già in scadenza.
[…] Scade il primo semestre di chi ha perso il potere, come tanti altri, legalmente, coi voti di un terzo degli elettori, ossia giocando con la manovra della informazione e la debilità culturale ed economica di tanti nostri connazionali e, perché no, la nostra medesima.
La breve eco della ricorrenza del ventennale non contraddice la sostanziale assenza dell’opera fortiniana nella cultura odierna. Naturalmente questo fatto ci dice molto di più della natura del nostro tempo che di quella dell’opera di Fortini. Egli, se per certi aspetti della sua convinta e fedele frequentazione del genere saggistico, nonché, e forse soprattutto, per la qualità dialettica della sua prosa ricorda Adorno, il suo marxismo lo portava sì ai margini del milieu politico e culturale, ma sempre in connessione con una soggettività sociale e politica agita. Ha sempre avuto un’acuminata e antinomica consapevolezza di essere al contempo nella cultura dominante e sintomo di “miliardi di analfabeti”. La rivendicazione verso i dirigenti dei partiti della sinistra – rivendicazione accusata da questi ora di essere elitaria, ora piccolo-borghese - del diritto al giudizio politico non era mai disgiunta dal disegno e dalla speranza che l’eco delle rivistine di poche centinaia di copie, in cui spesso ha scelto di scrivere, sarebbe arrivato alle ampie masse militanti di quegli stessi partiti.
2. Tre giovani della mia cittadina di provincia, mentre si divertivano a ‘postare’ brevi storie filmate fatte in casa, si sono trovati a ricevere oltre un milione di ‘contatti’ dal mondo, così, con loro sorpresa, si sentono chiamare da una, come si usa dire, importante casa editrice per scriverne un volume. Non troppo tempo fa uno che aveva dignitosamente girato la nazione con la sua arte di saltimbanco, decide di fare un salto più grande, diventare istrione. Grida la sua guerra in quegli stessi nuovi mezzi di comunicazione e fa di un simbolo da guida turistica il primo ‘partito’ italiano. Abbiamo scoperto l’America.
Il quantum di possibilità, che l’informatizzazione di dati e di mezzi comunicativi ha dato al singolo di parlare ‘a tutti’, è insieme la carota e il bastone con cui il capitale ha distrutto prima i luoghi della manifattura poi di riproduzione della vita quotidiana nei quali le classi subalterne avevano in un secolo e mezzo costruito il proprio incontro e la propria azione di resistenza e di contrasto. Lì ci si è conosciuti come interesse comune, come soggettività capace di agire, come produzione di conoscenza, come embrione di un domani tendenzialmente alternativo. Erano i luoghi del sindacato, del partito, dell’associazione vissuti nelle articolazioni diverse del vivere comune. Intendo i luoghi e le forme che hanno storicamente fatto nascere e segnato il grado di democrazia nelle società moderne: dai puritani del Cromwell ai giacobini francesi, dai soviet del 1905-1917 ai partiti, ai sindacati e alle associazioni del secolo breve.
Non si dà democrazia se i senza potere, oltre a riconoscersi come tali, non affermano e fanno vivere forme di volontà comune, progetto comune, visibile e alternativo nelle articolazioni sociali. Fortini ha scritto e agito in un periodo in cui le sue parole e la sua azione risuonavano nei diversi luoghi aggregativi che diversamente le intendevano e diversamente se ne appropriavano, così facendole vivere, magari rifiutandole.
Oggi domina la molecolarità. L’ipertrofia dell’io, che da certa sociologia americana nei tardi anni Ottanta era stata chiamata “società narcisistica”, nel disfacimento della lunghissima crisi attuale si mostra in tutta la sua miseria e impotenza. Il godimento coattivo di quel decennio si è tramutato oggi in urla, quando non in silenti autolesioni. In tale cacofonia del caos dove le classi subalterne sono spesso ridotte al loro puro esistere sociale, deprivate come sono di propri luoghi comuni o, come si usa dire, dei “corpi intermedi”, non c’è spazio per ciò che Fortini marxianamente chiamava la “mediazione”. Tutta l’opera di lui e ogni suo gesto presuppongono un contesto e – quel che più conta – costruiscono un interlocutore che poggi e operi nella mediazione. Mediazione di organizzazioni politiche, come si diceva, e associative che degli “analfabeti al di là dei confini” interpretassero domande e silenzi, operando per una nuova forma sociale, ma mediazione anche nel senso di fatica del concetto per la conoscenza critica della totalità economico-sociale.
Nell’odierna illusione che ognuno possa parlare a tutti – prodotto diretto della convinzione trionfante che, diceva Margaret Thatcher, la “società non esiste” – solo chi possiede ricchezze, potere e strumenti può farsi sentire sopra l’immane brusio. Agli altri non rimane che l’urlo plebeo o l’applauso. Questa comunicazione verticale è fatta di slogan, non di discorsi; è una performance che costruisce una realtà virtuale, non un’argomentazione che si confronti con il principio di realtà; pertiene all’estetica dello spettacolo che comanda l’immedesimazione passiva, non all’etica della responsabilità e alla conoscenza che coltivi il passaggio all’età adulta.
Per tutto questo, dicevo, oggi Franco Fortini è rimosso.
Prosa e poesia
La verità di un giudizio politico può essere scritta parlando di Proust, e un consiglio di poetica può nascondersi in una valutazione di dissenso dell’Est
Franco Fortini, 1977
La massima “l’uno si divide in due” non era per Fortini né un vezzo dei tempi, né solo un assunto teorico. Era, prima di tutto, un dato esistenziale profondamente vissuto.
Mi è stato fatto non so quando un male.
Una ingiustizia strana e indecifrabile
mi ha reso stolto e forte per sempre.
Leggendo una poesia
Il doppio registro della sua ricerca, saggistica e poesia, ne è soltanto un esempio. E certo egli ha sofferto del poco rilievo che a lungo la critica ha dato alla sua produzione poetica. Tra le tante sue testimonianze, reco una memoria personale. Giovanissimi studenti universitari lo ascoltavamo a una lezione sui lirici italiani del primo Novecento quando, con la mestizia del Virgilio dantesco, osservò che essere poeti è un onore grande, anche se lo si è di seconda fila.
Eppure, malgrado le cautele, le resistenze, le denegazioni autentiche dello stesso Fortini, ci priveremmo di uno sguardo più profondo, se non vedessimo che proprio l’energia feconda di quel volersi avversario del pensiero dominante senza dismettere la coscienza di esserne parte, rivendicato nell’attività saggistica, è la medesima che nutre il manierismo, il falsetto della sua poesia.
Se in vita ha visto messa in secondo piano la sua opera poetica rispetto alla saggistica, dopo la sua morte assistiamo al recupero della figura poetica a discapito dell’intellettuale militante. Ribaltamento curioso, che conferma proprio quanto sopra si argomentava. Fortini è diventato un classico:
Non so che senso abbia turbare quei due defunti [Pasolini e Moravia], già così ben disposti nei loculi dei manuali e delle antologie. Fare l’agente di borsa, diciamo, non è un mestiere da tutti; soprattutto dove una Borsa Valori non c’è, tutt’al più una Sala Corse per tristi bookmakers. Lasciamo che Pasolini e Moravia conversino nei licei, come già fanno da tempo, con i loro nonni D’Annunzio e Svevo, Pascoli e Pirandello, dopo essere vissuti in un mondo fedele alla persuasione che gli uomini di lettere, i poeti e i romanzieri potessero toccare le coscienze. Ormai le parole, o i silenzi, sono altrove.
La firma è di Fortini, anno 1992. Il cerchio si chiude, sebbene le parole e i silenzi siano altri da quelli ch’egli stanzi.
Il presente
Guardavo, ero ma sono.
La melma si asciuga fra le radici.
Il mio verbo è al presente.
Questo mondo residuo d'incendi
vuole esistere.
Insetti tendono
trappole lunghe millenni.
Le effimere sfumano. Si sfanno
impresse nel dolce vento d'Arcadia.
Attraversa il fiume una barca.
È un servo del vescovo Baudo.
Va tra la paglia d'una capanna
sfogliata sotto molte lune.
Detto la mia legge ironica
alle foglie che ronzano, al trasvolo
nervoso del drago-cervo.
Confido alle canne false eterne
la grande strategia da Yenan allo Hopei.
Seguo il segno che una mano armata incide
sulla scorza del pino
e prepara il fuoco dell'ambra dove starò visibile.
Franco Fortini, Il presente
Non scorgo poesia più grande, meditazioni più profonde che al pari di Fortini non abbiano sentito l’assillo, meglio, l’ossessione fino alla ferocia del presente, analoghe in questo alla dura concretezza di milioni di esistenze che lungo i millenni hanno strappato il pane per sé e per gli altri. È un presente però sempre slogato dalla consapevolezza del passato e dalla memoria dello sguardo futuro. “Guardavo, ero ma sono”: la parola “presente” si slabbra da subito verso il passato. “Sono”, nel pensiero fortiniano, ha abbandonato alla sua falsità l’immediatezza che pare affermare, addita invece e attiva in sé stratificazioni che affondano in ere remotissime, fin oltre il biologico: “questo mondo residuo d’incendi”. La soggettività umana, anzi individuale del sum si slarga in direzione sarcasticamente anti-antropocentrica, segnalata da un’antifrasi rattenuta da sottile gioco di spostamento: “Detto la mia legge ironica / alle foglie che ronzano, al trasvolo / nervoso del drago-cervo” ecc. Ad essere “ironica” non è affatto la “legge”, bensì la voce che, pretendendo d’imporre alla natura la propria legge umana, si scopre oggetto di derisione.
Ovvia, in tale dialettica, la proiezione verso il futuro più remoto: l’ “ambra dove starò visibile”. Così messa a nudo la transitorietà del presente, non c’è spazio né per un sentimento di resa, né per una sopravvivenza nichilistica. Le “effimere” (specie di farfalle che vivono un solo giorno) che “sfumano” sono precisamente la falsa irrelatezza del presente o, per dir meglio, della nostra vita individuale. Il presente non è mai solo un punto, l’io individuale non è mai sola impotenza, perché si carica del sapere e del potere di chi gli è prima e di chi gli è accanto; il suo fare non muore mai con lui e mai si ferma ai confini della propria mano. A questa altezza cosmica Fortini consegna a chi, nel nostro tempo della miseria, è buttato da parte un messaggio di forza inesauribile, oscuro però, niente affatto eroico, e arduo, incompatibile con l’accecamento immediato dei plausi o dei fischi.
Spettatori?
Indignez-vous!
Stéphan Hessel, 2010
Dentro questo autobus che ci trasferisce c’è tale un urlìo
che non permette di parlare
e nemmeno di tacere umanamente
Franco Fortini, Leggendo una poesia
Il grido di un vecchio partigiano indomito, Stéphan Hessel, ha d’improvviso scosso le coscienze di milioni di giovani che tutto ignoravano, ma molto sentivano. Un moto imponente, che ha fiorito, adattandone il nome, sulle due sponde dell’Atlantico, invaso il Mediterraneo. La risacca è stata repentina, anche se di certo fruttificherà in forme e luoghi per ora ignoti.
Perché Fortini sosteneva che “non serve indignarsi”? Indignarsi è prima di tutto lo scatto emotivo e morale di chi sente la misura colma. È l’atto di chi a lungo ha immaginato di comprendere, pensandosi estraneo o immune, per alla fine trovarsi di fronte a qualcosa che lo sovrasta, lo sbalordisce e lo ripugna. Vi scorgeva dunque il duplice limite dello sfogo immediato, quando invece si tratta di comprendere, per agire secondo una strategia razionale. Indignarsi si configura come la reazione automatica del crepuscolo della società affluente, la cattiva dialettica di un’epoca che, mentre vede spegnersi tutte le promesse della propria origine in un potente moto regressivo, sta intanto prosciugando i pozzi di chi fino ad allora aveva voluto opporlesi.
Fortini proveniva da una cultura che lo aveva attrezzato – tra, diciamo, l’8 settembre e la conclusione del secolo breve - prima contro le pretese dogmatico-paternaliste, poi contro la mitizzazione della spontaneità di ciò che allora si chiamava ‘base’, oggi virtuosamente trasformata in ‘società civile’. Per questo ha immediatamente colto con sarcasmo la curiosa fusione di paternalismo e spontaneismo, primo annuncio del populismo odierno, che negli anni Ottanta animò la politica dell’“effimero” inaugurata dalle amministrazioni di sinistra. Quelli ch’egli chiamava Assessorati al turismo e allo spettacolo, estendendo il modello del concerto rock, trasformarono i diversi campi culturali in “eventi”: dalla proiezione cinematografica, alla lettura di poesia, alla mostra di pittura. Rammento, dice Fortini, “che nel corso della discussione mi accadde di buttare lì una battuta, che scandalizzò orrendamente i progressisti seduti accanto a me. Dissi: «non esiste il Petrarca per tutti». Vale a dire: il tentativo di rendere accessibili alcune opere, che sono state create in un certo contesto storico e che hanno una definibile funzione che non può valere per tutti”. Parole del 1989, nel pieno svilupparsi di ciò che Fortini chiamò “snobismo di massa”, allorché le trasformazioni economico-sociali e politiche lo avevano costretto a un isolamento crescente. Negli ultimissimi tempi della sua vita, giudicato oramai incongruo e infrequentabile lo spazio pubblico, preferiva ricevere in casa propria piccoli gruppi di giovani.
Già un decennio prima, sul finire degli anni Settanta, indicava nei suoi scritti, senza timore d’apparire provocatorio e addirittura reazionario, il pericolo dell’urlìo camuffato da pratica democratica, guardato invece con simpatia dalla sinistra più radicale del tempo, perché si accompagnava alla diffusione delle cosiddette radio libere, antesignane delle ‘televisioni libere’, ossia della televisione commerciale, che in Italia è stato ed è il duopolio tra la Rai e la berlusconiana Mediaset. “In via di principio – dice Fortini in un’intervista del 1978 – non posso essere contrario a dilatare l’accesso alla comunicazione; a condizione che non si abbia inutile rispetto ‘democratico’ per la imbecillità”.
L’odierno lettore di Fortini si trova nella schizofrenia di osservare per un verso una condizione socio-culturale che conferma e anzi enfatizza le diagnosi fortiniane e per l’altro la crescita simmetrica delle condizioni che ostacolano l’avvicinamento e la comprensione di quelle diagnosi. È in fin dei conti il riproporsi del tema classico della presa di coscienza. Per questa strada incontriamo clamorosamente ciò che sociologi ed economisti hanno di recente chiamato vittoria del capitale sul lavoro, introiezione da parte delle classi subalterne dell’ideologia dominante come dato di natura. Risulta credo più chiaro perché il lascito fortiniano oggi sopravviva ai margini, mentre la sua resistenza a divenire fungibile qui e ora è, per converso, il segno del suo valore critico sul piano euristico e contrastivo in quello politico. Non è morto. Un giorno o l’altro, come certi enzimi, si riattiverà.
Ma noi come possiamo usare l’esperienza fortiniana? Noi, dico, cui è dato vivere in questa notte? Se alla chiamata non declinabile del che fare, che ogni giorno misura il senso del nostro vivere, non so dare la risposta alta che sento necessaria, perché essa non è data nell’ambito dell’azione individuale, trovo nell’ antropologia conquistata da Fortini, insieme con la messa in guardia verso la società dello spettacolo, nutrimenti fecondi. Perché mentre mi addita il limite del mio essere qui e ora, mi dimostra anche che l’alternativa non è mai il nulla e neppure ‘il meglio che niente’. È solo di registro diverso. C’è qui, in Fortini, la meditazione di Marx, a partire dalla quinta e sesta Tesi su Feuerbach, e di moltissimi altri, non ultimo Paolo di Tarso: “quello che di te rimane – dice Fortini a otto mesi dalla morte – è una quantità di modificazioni che la tua vita, come quella degli altri, ha introdotto nei rapporti fra gli uomini”.
2 luglio 2015
Non ho tempo
a D.
Non ho avuto tempo, mi risponde la giovanissima allieva cui ho chiesto la consegna di una breve certificazione. L’inciampo minimo mi ha interrotto mano e pensiero: non era una scusa. I congegni del giorno sono potenti; occorre lo strappo d’un imprevisto, perché il profumo di una vigna o uno sfavillio di celeste irrompa. Non ho tempo è il bruciore improvviso acceso da ogni sporgenza verso il futuro, da ogni necessità nuova che impegni un punto qualsiasi a venire. Il presente occupa compattamente l’esperienza del tempo. La saturazione del presente non è solo delle cose da fare o da pensare. È, prima ancora, della vista, dell’udito. Si può anzi dire che è dell’udito e della vista perché si faccia senza pensare e si pensi senza fare, come c’insegnano i grandi viali coperti, le ampie isole dei centri commerciali. Solo l’eccedenza scuce un lembo, dà un fiato alla sofferenza del sintomo. Non sorprende che la sua forma, in frequenza crescente e in età sempre più precoce, sia il panico.
L’altro, opposto e più confermativo sintomo è lo smarrimento, l’angoscia che dilaga in ogni falla, in ogni lenimento della routine.
Solo la mala fede può far asserire che tale dato è in contrasto con l’esperienza ormai vasta del non lavoro e della precarietà. La saturazione del presente, più ancora che il nascondimento del passato, è la forclusione del futuro. Per questo il presente è diventato il tempo dell’ossessione. La coazione a ripetere che umilia le esistenze individuali è la stessa che ci spiega come tagliare gl’investimenti per pagare il finanziere sia fonte di benessere e come aumentare il consumo dei combustibili fossili non provochi cataclismi climatici.
“Si può sostenere - ha osservato un geografo - che la storia del capitalismo è stata caratterizzata da un’accelerazione nel ritmo della vita, con relativo superamento delle barriere spaziali”, mentre “gli orizzonti temporali si accorciano fino al punto in cui il presente è tutto ciò che c’è” (D. Harvey). La descrizione tanto realistica della fenomenologia del nostro tempo ne mostra anche la Verità, se si rammenta che il salto dalla società feudale al capitalismo è l’inversione dei tempi tra produzione e distribuzione: il capitalista ha dovuto prima pagare i fattori della produzione e poi far produrre. È in quell’originario consumo di un frutto futuro, il motore della presentificazione in figura dell’avvenire, inghiottito dalla dilatazione del presente. È da quella genesi permanente la progressione ossessiva che divora oggi ai nostri figli terra, acqua, ossigeno, che alimenta il buio delle nostre vite.
Non abbiamo tempo.
15 aprile 2015
Piero Bevilacqua, Pasolini. L’insensata modernità
Di fronte all’insensatezza dell’uomo costretto a mero fattore di produzione e alle tragedie di un ecosistema che sempre più violentemente reagisce a chi pretende d’ignorare una sua alterità alla trasformazione tecnologica e al profitto, il pensiero della decrescita promosso da Latouche apre strappi utili nel pensiero dominante. Piero Bevilacqua, in un saggio “di alta divulgazione e di essenzialità”, mette alla prova la figura intellettuale di Pasolini a partire da questo intento, per mostrarci “il critico dei miti della crescita”.
Dopo aver osservato la consonanza con il rifiuto leopardiano delle “magnifiche sorti e progressive”, lo storico, ripercorrendone rapidamente l’opera, conduce il lettore ad una faglia da cui si possono attingere materiali attualissimi di critica all’oggi. Ciò che permane, dice Bevilacqua, nei diversi periodi della produzione pasoliniana è il contrasto radicale tra la nostalgia del mondo contadino e la società industriale, in Italia esplosa nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Se è vero, sostiene lo storico, che fino agli anni sessanta tale rifiuto si accompagnava contraddittoriamente a un progressismo derivato dall’adesione al Pci, nella parte finale della sua vita, abbracciata coerentemente una posizione pessimista e intransigente, lo sguardo di Pasolini si fa più penetrante. Quel volgere le spalle alla modernità, quel misurarla con i valori che egli attribuiva al mondo cancellato – indipendentemente dalla verità storica di tale attribuzione – ha portato il poeta, il polemista, il critico a pagine sferzanti e in buona misura anticipatrici della natura della sofferenza odierna. Ai suoi occhi risultava agevole scorgere, appena sotto la superficie dei progressi materiali ridistribuiti dallo sviluppo capitalistico, la mercificazione di tutto, la drammatica riduzione della complessità storico-naturale alla sola misura dell’utile e quindi la cancellazione del senso del vivere umano, lo smarrimento della presenza del ciclo naturale della materia e del vivente.
Almeno un’altra messa in guardia ci viene consegnata dalla ricognizione di Bevilacqua. La mutazione antropologica che Pasolini osservava l’ha portato a scrutare la fisicità dei corpi, denunciando il loro ammutolirsi nell’anonimia della “gente”, così come l’ha fatto soffermare sulla perdita di espressività di una lingua italiana strumentale e pubblicitaria che ha sospinto l’espressività dialettale ai margini. Da ultimo, nella fase forse più nota, il Pasolini ‘corsaro’ ha denunciato con estrema violenza l’irrilevanza della politica, simmetricamente al suo corruttivo, antidemocratico rinserrarsi nel Palazzo.
Lo sguardo partecipe e insieme misurato di Bevilacqua non manca di sottolineare il tono del discorso che va ripercorrendo, la natura sua propria. Chiarito che non è da chiedere a Pasolini ciò che non può dare (“la formula che mondi possa aprirti”, direbbe Montale), perché la sua voce grida “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, lo scrittore, conclude Bevilacqua, è “sovranamente impolitico”, la sua è la figura dell’eroe solitario: “voleva urlare ai suoi lettori la barbarie che vedeva avanzare, lui solo, veggente in mezzo alle tenebre, tra gli applausi che i suoi contemporanei accecati le tributavano”. Si coglie qui un elemento che merita una riflessione, perché aiuta a illuminare una verità attuale. La fortuna di Pasolini dopo la sua morte è tanto vasta e duratura, che non sono sufficienti a spiegarla né l’opera letteraria, né la tragicità e il mistero del suo assassinio, né la rilevanza della sua produzione cinematografica: c’è un di più.
Le ultime pagine del saggio di Bevilacqua, di forte presa sulla realtà politica, sociale e culturale odierna, di vibrante tensione civile, nelle quali la sua voce ‘invera’ il viatico di Pasolini, costituiscono il reale inizio del saggio, tanto che verrebbe voglia d’invitare a leggerlo dalla fine. Qui il lettore trova i tratti dolenti della miseria del presente, allorché il capitalismo, con la propria vittoria mondiale, ha portato al massimo grado quell' “ininterrotta messa in discussione di tutte le condizioni sociali” già diagnosticata nel 1848 dal Manifesto di Marx-Engels, così producendo ciò che Bauman, nelle sue fortunate descrizioni, chiama “società liquida”. È il deserto che sembra abitare una società impoverita e umiliata a nuovo plebeismo, il nulla del pensiero, la vuotezza del gergo quotidiano, la difficoltà ardua di aggregare i rivoli del disagio e della protesta, la sfuggenza dei centri reali di comando, l’arrogante refrattarietà di chi dice di detenere il governo, che fanno sentire più vicino, meglio comprensibile chi in altre epoche si è trovato a gridare da solo nel deserto, ha fatto ricorso alla “poesia, fondo dell’alterità … in rivolta contro l’ottundimento del conformismo, l’assoggettamento della soggettività agli automatismi massificati”. Per questo, Pasolini è più nostro che del suo tempo.
9 aprile 2015
Notizie
Accestisce qui l'erba ch'affolta da oltre vent'anni
imprevisto alle trame affiora un ronzio di sciame.
E' tiepida stamani la luce.
Ma è profondo dicembre
vuoto il cielo di voli, né
più alcuna mano è nei campi.
Tu sai che nella terra precipita
la corsa breve e gli slanci
delle stagioni. Immobile rimane
per niente materna.
Ma senti, nascosti tra i roghi
altri sguardi in attesa:
niente, di vero e di falso, andrà perduto. Irromperà
lo squillo del picchio.
Nota
"Roghi", l'uso dialettale è tutt'altro dal significato italiano. Ma "rovi" sarebbe riuscito troppo falso.
1 gennaio 2015
C’era una volta una piccola città
clicca qui per la discussione
A Velso: contadino, mio padre
C’era una volta una piccola città che era abitata dai Bassi e dagli Alti. Come tutte le città del piccolo pianeta, aveva difetti, tanto più che i suoi abitanti non avevano grande esperienza di democrazia o, se ce l’avevano avuta, era stato in tempi così antichi che nessuno se la ricordava più. Eppure, approfittando di un certo periodo di crescita e di benessere, i Bassi avevano saputo trovare la forza e il gusto di discutere, di stare insieme per le strade e per le botteghe della piccola città, anche fino a notte fonda. In breve, avevano saputo contare di più. Forse, in questo, aveva la sua parte il fatto che gli Alti, da tempi immemorabili notabili della piccola città, nei loro traffici con i concorrenti avevano sempre figurato come i guitti, gli arraffoni estemporanei, che esibivano come patacche – non avresti saputo dire se tragiche o comiche - i blasoni di glorie antichissime. Insomma, la loro ricchezza era più dovuta alla condizione di plebe dei Bassi, all’uso spregiudicato del proprio comando, per il quale trasformavano ogni diritto dei loro sottoposti in favore da concedere o da negare, piuttosto che alla propria capacità imprenditoriale, alla propria virtù di governo. Alcuni storici scrivono che le speranze fiorite in quel certo periodo di crescita, l’allegria breve che aveva fermentato tra i Bassi e contagiato persino alcune famiglie degli Alti, tanto che la piccola città si era guadagnata qualche risonanza fra le altre, erano state possibili proprio per la relativa debolezza degli Alti.
La piccola città aveva due sole scuole: una per gli Alti e una per i Bassi. Naturalmente diversi erano gl’insegnanti e gli studenti, diversi erano i fini e le materie, diversi il ruolo e il prestigio. Ma a un certo punto del breve periodo di crescita che si diceva i Bassi cominciarono a interrogarsi. Non tutti, certo, ciò non accade mai. Però i dubbi si erano insinuati, le domande giuste: se i padri e i nonni dei Bassi lo erano stati di nome e di fatto, perché i loro figli, per la circostanza che così si chiamavano, dovevano continuare a seguire le scuole basse? Nessuna scienza, nessuna morale, nessuna Verità poteva negare che capaci e meritevoli nascessero fra i Bassi come fra gli Alti. Era stato scritto che tutti i cittadini erano uguali di fronte alla legge, ma si comprese subito che non era vero. Così si arrivò addirittura a proclamare sui muri della piazza, perché tutti potessero leggerlo e rivendicarlo, che era compito – proprio così, “compito” - della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Per un certo periodo, le conquiste, i progressi, lo slancio creativo crescevano, cento fiori fiorivano. Qualcuno proclamò, con argomenti pratici, che fare parti uguali tra disuguali era la peggiore delle ingiustizie, perché se giustizia è rendere uguali, proprio chi aveva di meno doveva invece avere di più. Che è un modo diverso di dire che se sono le circostanze a formare l’uomo, si tratta di umanizzare le circostanze. I più sensibili, i più impegnati portarono alla luce, con opere e scritti, che non si dà vera felicità se questa non è condivisa, che la spada ferisce sempre da due parti: chi è colpito e chi colpisce. In breve, si era venuto corrodendo il pensiero comune –rivelatosi allora tenace quanto erroneo – che gli Alti si chiamavano così, perché questa era la loro natura. Molti scoprirono con sorpresa che la felicità comune poteva prendere avvio proprio da chi fino ad allora era stato e veniva considerato basso. Fu certo per questo motivo che sulla torretta chiamata dei diavoli, forse antico fortilizio dei Bassi della piccola città, notte tempo una mano ignota scolpì “vivas foelix”.
Tutto questo sommovimento scombussolò antiche consuetudini e relazioni, solide convinzioni comunemente ritenute vere proprio perché tramandate. Le due scuole, pur serbando in parte la loro vecchia natura, si mescolarono. Sfortunatamente, il processo in questo modo avviato presto si arrestò.
Alcuni storici sostengono che fenomeni analoghi erano apparsi nello stesso tempo in numerose altre città del piccolo pianeta, provocando lo scandalo e, peggio ancora, il danno immediato delle confraternite degli Alti di quelle stesse città. Tali storici dicono anche che la reazione non fu immediata, né uniforme, che si ebbero resistenze, parziali avanzate, ritardi. Sembra che i più generosi, o semplicemente i più lungimiranti, tra chi sosteneva le ragioni dei Bassi, andassero affermando che se piccolo danno avveniva per alcuni Alti nell’immediato, nel medio periodo invece grande e comune sarebbe stato il vantaggio. Si rispose loro che di questo non si curavano, perché a quel tempo sarebbero stati tutti morti.
Fatto sta che gli Alti della piccola città non seppero né approfittare della spinta comune per crescere in acume, inventiva imprenditoriale sui concorrenti della altre città del piccolo pianeta; né riuscirono davvero a spazzar via la pretesa dei Bassi. Così fecero ciò che da secoli oramai ripetevano: mettersi a disposizione dei loro concorrenti più forti delle altre città, ora facendo i buffoni, ora concedendo qualche pezzo della piccola città, ora rubacchiando al banco degli affari. Tra sé si dicevano furbi, lasciavano correre le risatine, i colpi di gomito o le vere e sonore risate, perché ciò che loro premeva era dirsi, con i Bassi, costretti a fare ciò che facevano o a lasciare che altri facessero.
Certi storici sostengono – perché non tutti sono concordi - che i concorrenti degli Alti, in lotta e in combutta in tutto il piccolo pianeta, avevano trovato un rimedio straordinario per semplicità ed efficacia. C’è addirittura chi sostiene, ma la cosa non è mai stata provata, che l’idea sia stata messa in pratica da una vera e propria commissione che, per il tavolo bizzarro impiegato nell’occasione, fosse stata chiamata trilaterale. L’idea, dicono dunque certuni tra gli studiosi di cose passate, partiva da questa semplice constatazione: se i Bassi della piccola città e di tutto il piccolo pianeta hanno cominciato a mettere in discussione la loro naturale condizione, al punto da far breccia anche tra gli Alti; se a ciò hanno aggiunto l’operato concreto di gruppi e di singoli che vogliono la repubblica o comunque lo stato strumento di rimescolamento delle condizioni; basta affermare la superiorità della libera iniziativa sui vincoli delle burocrazie, la sanità naturale della concorrenza tra gl’individui contro l’artificiosità di chi approfitta del proprio comando dello stato per imporre il proprio interesse. Qualcuno di quegli storici arriva ad affermare – ma dovrebbe esibire le prove – che in quell’epoca fosse stata addirittura creata la parola d’ordine “più mercato meno stato”.
Sia come sia, con discreta rapidità i governi della piccola città cominciarono a scoprire che il debito dello stato era troppo alto, che quello, come una famiglia, non può alla lunga vivere con i debiti, che la cura era abbattere il parassitismo delle burocrazie pubbliche e fare sacrifici per i figli. E non solo i governi, si capisce, ma anche i gazzettieri, le botteghe, i caffè e le famiglie medesime si ripetevano la verità comune e del tutto ovvia. Così fu presto una corsa a vendere ciò che era pubblico, a togliere le spese comuni, perché i soldi tornassero nelle tasche private, perché si favorissero i guadagni e gl’investimenti privati, la produzione, l’occupazione, insomma il benessere di tutti. La concorrenza, si diceva, era l’anima dell’efficienza perché dava spazio ai migliori, della democrazia perché toglieva le rendite di chi approfittava del posto, della moralità perché dava di più a chi sapeva più conquistarselo. Così si elogiava e si praticava il risparmio nelle attività rimaste pubbliche per un duplice vantaggio: faceva diminuire le spese comuni e riconduceva quelle che fossero sopravvissute alla virtù dell’impresa privata, grazie anche a investimenti economici in quelle da parte di chi poteva.
Fu così che la scuola degli Alti e la scuola dei Bassi tornarono a farsi concorrenza: non per coerenza con il proprio nome – chi ci credeva più alle ideologie? – ma per togliere all’altra iscritti e per attirare investimenti di chi aveva. Raccontano gli storici che le assemblee degl’insegnanti e del personale tutto s’impegnarono con fervore a cercare i modi più fantasiosi per rendere appetibile l’iscrizione, per attirare investimenti, non tanto dalla piccola città (non è che mancassero i soldi, il fatto è che qui gli Alti non sapevano che farsene di ricerca e istruzione, avendo già deciso che la loro strada era la truffa, la cortigianeria, l’improvvisazione) quanto di altre leghe e città del piccolo pianeta. Alcuni storici asseriscono che insegnanti e personale migliore, quello che si era formato in quel certo periodo di crescita - migliore perché più motivato, più aperto alle trasformazioni, persino più competente – si erano buttati anima e corpo nel sostenere le ragioni della propria scuola e quindi della concorrenza. Lo facevano, scrivono, senza alcun sospetto, in completa innocenza.
Gli storici ci dicono che i legami e le comunicazioni tra tutte le città del piccolo pianeta si erano assai intensificate rispetto alle epoche passate, cosicché le migrazioni per ragioni più diverse sempre presenti si fecero più naturali e necessarie, per fuggire dalla miseria, dalle persecuzioni, dalle guerre. Visto che tali legami avvenivano sotto il segno della concorrenza, ciò non significò affatto diminuzione dei conflitti tra economie, religioni, lingue: ridisegnò invece i confini, sociali e geografici, tra gli Alti e i Bassi del piccolo pianeta, aggravò la loro differenza. Gli Alti della piccola città capirono subito che la lingua ora dominante nel piccolo pianeta, loro ovvio patrimonio per i propri traffici, sarebbe stata utile per rendere più facile la migrazione dei Bassi acculturati, migrazione quanto mai necessaria vista la condizione subalterna in cui avevano riconfermato la piccola città. Così incoraggiarono la preparazione di giovani in quella lingua. Non mancò, dicono certuni storici, chi sostenne che si trattava di una scelta miope, perché rischiava d’impoverire l’antico, glorioso fra tutti, patrimonio linguistico della piccola città in campi vitali del sapere come le scienze, la storia, la tecnologia, l’intero vasto campo dell’industria della comunicazione. Queste rare voci ripetevano che nella storia la vitalità di una lingua – e a maggior ragione in campi prestigiosi del sapere – era stata condizione della vitalità di qualsiasi città. Di certo lo era stato per la piccola città, che solo grazie alla letteratura grande che vi era fiorita poté dirsi per secoli città e poi diventarlo davvero, invece che villaggi dispersi.
Pare che – se si vuol credere a uno o due cultori di cose passate - in una delle due scuole della piccola città fosse stato deciso un percorso di studi nel quale titoli degl’insegnanti, programmi insegnati, nonché i relativi esami fossero interamente decisi, controllati non dal governo della piccola città, come sarebbe stato legittimo dovere, nemmeno si dice da uno di un’altra del piccolo pianeta, bensì da un’impresa privata di altra città. Il medesimo insegnamento delle varie materie, naturalmente, doveva avvenire nella lingua straniera di quella. Essendo l’impresa di comando privata, non investiva alcunché, anzi chiedeva essa stessa di essere pagata, cosa che poteva avvenire solo da parte delle famiglie. Sembra che ci si chiedesse come selezionare gl’iscritti, nel caso le domande fossero state troppe. Alcuni proposero degli esami di merito, altri suggerirono di anticipare corsi ed esami agli anni precedenti, qualche spiritoso osservò che bastava aumentare le tasse d’iscrizione.
È davvero meritevole d’attenzione constatare che l’affermazione visionaria e vagamente catastrofica di taluni scrittori del breve periodo di crescita, ovvero che ogni istituzione – la scuola, l’ospedale, lo stato – avrebbe di mira se stessa e non l’utente per il quale è stata istituita, apparisse allora, tale affermazione, pienamente vera. L’utile per lo studente coincide con l’utile della scuola solo se non si è più in grado di vedere il presupposto del comando scritto ancora sulla piazza della piccola città, ‘non è vero che siamo tutti uguali’, in forza del quale si era prescritto “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Certo invita a riflettere sulle condizioni dell’esistenza umana osservare in quale modo gli Alti della piccola città, con la loro arroganza con i deboli e la loro cupidigia di servilismo con i forti loro concorrenti, avessero condotto a un grado tanto alto di miseria e di pericolo comune.
Forse, se e quando i Bassi sapranno riprendere le fila del loro riscatto, essi dovranno trovare altre strade, ma non diversi scopi alla loro liberazione umana.
19 giugno 2014 - 14 dicembre 2014
Non è vero
Ora so che nessuno
busserà alla porta
ma non mi rassegno.
L’aria è del tutto immobile
l’autunno permane tiepido.
Accolgo paziente le notizie del giorno,
i giornali sono accessibili.
Da ieri e per qualche volta ancora
parleranno di te, perché tace
-sperano per sempre
la nostra parte
e il sangue.
Nota
Parleranno di te: “Lasciamo che Pasolini e Moravia conversino nei licei, come già fanno da tempo, con i loro nonni D’Annunzio e Svevo, Pascoli e Pirandello, dopo essere vissuti in un mondo fedele alla persuasione che gli uomini di lettere, i romanzieri e i poeti potessero toccare le coscienze. Ormai le parole, o i silenzi, sono altrove”, F. Fortini, 1992.
1 dicembre 2014
Lettere
Insegniamo letteratura? È vero che la Repubblica (quella della Costituzione, non il quotidiano) non s’interroga più sulla funzione dell’insegnamento, ma ciascuno di noi continua, seppur incertamente, ad essere pensante, quindi non posso far a meno di chiedermelo, per mio conto. Agl’inizi del secolo scorso il liceo, scriveva Fortini, nutriva nelle fanciulle della piccola borghesia la speranza di un buon partito.
Dico letteratura quasi arrossendo. Vedo lo smantellamento universitario delle materie umanistiche, il destino sociale dei non più giovani laureati… Non è stato un lapsus quello dell’ultima ministra dell’istruzione, ma limpida coerenza, quando ha suggerito di abolire nella prova di stato l’analisi del testo letterario. Così come non è semplice difetto d’età e di cultura, se presso i miei giovanissimi alunni non beneficio – quando propongo loro i testi alti della letteratura - del naturale pregiudizio per il quale l’insegnante ‘è supposto sapere’. Voglio dire che la logica economico-sociale che ha svalutato l’istruzione e l’insegnante, che ha trivializzato il prodotto televisivo e la comunicazione sociale è il medesimo che ha travolto la distinzione tra cultura alta e cultura bassa. Non perché non esistano differenze di valore letterario o perché oggi non si coltivi un’alta, anzi altissima cultura e istruzione, solo che quelle vette, come l’iperborghesia (lo 0,015 della popolazione mondiale) che ci comanda, vivono in un mondo parallelo al nostro. Tutti noi ci nutriamo della medesima pappetta sintetica. Se le cose sono grosso modo così, mi spiego meglio la sfasatura sbalorditiva tra quella realtà possente e la pretesa – valida fino a ieri sera – d’insegnare la letteratura come uno dei valori della civiltà di un popolo e strumento ricco per la crescita personale.
Che fare? Con presuntuosissima modestia sono andato solitariamente compilando una mia guida al mestiere. Alle lettere pertiene, inscindibile, un altissimo tasso di educazione linguistica. La lingua comune, la lingua delle scienze, la lingua dei testi letterari sono un tessuto fecondo, sedimento storico vivente e affinamento del sé: educazione intellettiva e sentimentale; sperimentazione della storicità individuale e collettiva; strumento di comprensione e di trasformazione; consapevolezza dei diritti e capacità di farli valere. Tanto più la comunicazione sociale gronda di trivialità, i luoghi della socializzazione primaria sono desertificati, il mondo delle merci educa alla strumentalità immediata di sé e degli altri, assuefà all’addestramento, la lingua italiana s’impidocchia di anglismi intraducibili, tanto più il compito della scuola è letteralmente insostituibile. Qualunque genitore sa che nessun padre o madre può surrogarne la funzione.
Per questo vado da tempo assegnando letture per un percorso diverso da quello strettamente scolastico, ‘più libero’, per accennare e magari invogliare alla consuetudine della lettura personale, non pratica per imparare una tecnica specifica, ma per sperimentare che la lettura è un’esperienza specifica. Con il tempo ho appreso che una delle cose – apparirà un paradosso – più difficili da far capire ai giovanissimi è che dalla lettura bisogna lasciarsi vincere, attività ben diversa dal consumare un prodotto. La risposta comune è l’esclamazione euforica o il rifiuto egotico: la prima è la coazione del consumatore soggiogato; la seconda del pregiudizio infantile. In nessuno dei due casi l’interiorità del lettore ha fatto spazio all’esperienza del mondo narrato: l’esperienza è vivere le sfumature, i contrasti, le intermittenze; dall’esperienza si prendono distanze, con l’esperienza ci si confronta, si pronunciano giudizi. Per dirla in termini tecnici, la meta educativa più difficile è il ricorso consapevole sia alla pratica del lettore implicito che a quella del lettore storico, nonché il passaggio motivato dall’una all’altra. Per questo non chiedo compilazioni di schede, ma diari di lettura. Scrittura personale meditata e lettura sono una la faccia dell’altra, crescono insieme.
Saggistica, storia, economia, psicologia, scienza, letteratura e altro ancora si ampliano e sovrappongono nel tempo, secondo le domande del lavoro didattico, le curiosità degli allievi, le intimazioni del presente.
Malgrado il brusio osceno che ci sovrasta, è sempre dalla porta del mattino che ci aspetta la domanda non rinviabile e che rischia d’annichilirci.
Ciò che può fa – scriveva nei suoi giudizi il maestro Manzi – ciò che non può non fa.
Non è poco.
20 novembre 2014
Franco Fortini
Ai miei alunni
“Chi finge di non vedere il ben coltivato degrado di qualità informativa, di grammatica e persino di tecnica giornalistica nella stampa e sui video, è complice di quelli che lo sanno, gemono e vi si lasciano dirigere. Come lo fu nel 1922 e nel 1925.
Non fascismo. Ma oscura voglia, e disperata, di dimissione e servitù; che è cosa diversa. Sono vecchio abbastanza per ricordare come tanti padri scendevano a patti, allora, in attesa che fossero tutti i padri a ingannare tutti i figli. Cerchiamo almeno di diminuire la quota degli ingannati. Ripuliamo la sintassi e le meningi […] impariamo a ripeterci”, 5 novembre 1994.
Il santo furore di Fortini sul letto di morte (cesserà di vivere il 28) non perde purtroppo un lisco di ragioni dopo vent’anni. Registra anzi quella scomparsa dello scandalo che Brecht indica nel moltiplicarsi delle stragi. Eppure la cupidigia di servilismo, il tornaconto, o il disperato e sempre più frequente ricatto su chi deve pur campare non sono sufficienti, da soli, a spiegare la devastazione. Se è vero che per sentenza di legge e di coscienza la responsabilità è solo personale, non c’è bisogno di Marx per capire che avvenimenti collettivi hanno cause diverse dalla somma di volontà singole, che gl’individui sottostanno “all’effetto di campo” e sono piegati, per taluni aspetti, a strumento. La responsabilità di essi allora è non fuggire il principio di realtà, il primo grado di libero arbitrio è non aderire.
Si dice, e io stesso dico, che è la legge della messa a profitto immediato di ogni manufatto, gesto, parola, corpo, bioma a generare in ciascuno l’utile e il dannoso, il bello e il brutto, il vero e il falso. Il telos del profitto innerva fin la minima fibra della nostra società, a principiare dall’informazione, dal godimento estetico e dalle conoscenze, carne e sangue queste del comando, perché oggi nessun dominio, persino quello del fuoco militare, vive senza consenso. È per questo che il giornalista, dal video delle nostre case, avalla con un sorriso le più aberranti asserzioni del governo in carica quel giorno, l’autore televisivo disegna il più triviale degli spettacoli, senza che arrivi la velina del capostruttura. È l’auditel il faro. L’auditel è l’anatomia dell’arte, dell’istruzione, del lavoro, della vita e della morte: delle nostre società. Solo il cretino o il sovversivo abbisognano dell’imposizione esterna. Il padre è nostro.
Eppure basta allungare di due secoli lo sguardo, per scorgere che l’identico imperativo del profitto ha generato dal nulla oltre quattromila sottoscrittori all’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers; in una manciata d’anni ha spazzato via dai salotti di corte e dai banchi delle fiere la polvere dei cicisbei e delle maschere fisse; con il suo “nudo interesse, lo spietato «pagamento in contanti»” la borghesia, dice una volta per tutte il Manifesto del 1848, “ha creato ben altre meraviglie che le piramidi d’Egitto, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche; essa ha fatto ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e le Crociate”. È quei blasoni appunto, quando la troppa violenza dei fatti strappa la trama, che l’addetto di turno innalza, proclamando che con essi è avvenuto il compimento del tempo. Se dunque ci si sottrae alla medusa del presente, se si avrà la pazienza di reggere la forza del futuro e la generosità d’ascoltare il suo fascino, gli dei del mattino torneranno a dirci che la verità è sempre storica, nell’alba mostreranno che il terrore dell’Oggi è solo delirio del morente: il suo utile, il suo profitto.
5 novembre 2014
Altri sismografi
Un secolo fa, quando Umberto Eco teneva sotto pseudonimo una rubrica sul “Manifesto” intitolata, se non ricordo male, Ammazza l’uccellino, osservò che se un insegnante avesse vietato la lettura dei Promessi sposi e quindi indotto gli alunni a leggerli sottobanco, il romanzo manzoniano sarebbe stato amato. Per questo m’appassiono al sottotesto dei banchi e dei muri delle mie classi. Territorio costitutivamente ambiguo, nascosto eppure palese, anonimo ma non apocrifo, ribelle eppure istituzionale. Senza queste ruvidità, l’imbiancatura dell’aula sarebbe sepolcrale.
Segnacci neri che sporcano mani e vesti marchiano pesantemente un banco: “A scuola i professori spiegano / io guardo fuori di là dai vetri / sognando i milioni”. Perplesso, chiedo l’età alla probabile scrivana. Provo a spiegare la mia pena perché i sogni di una quindicenne si chiudono nei milioni. È la miseria del presente – mi accaloro – che tu tramuti in tuo sogno. Voci e sguardi intorno, di disapprovazione verso l’insegnante, poi una parola si fa strada, affiora limpida:
“Perché lei, a quindici anni, sognava di diventare un professore delle medie di una cittadina di provincia?”.
26 ottobre 2014
Sismografi
Nelle civiltà odierne, la scuola dei vari ordini, più ancora della formazione universitaria, è il sismografo della direzione che la classe dominante imprime sul medio periodo all’insieme sociale. Dico “classe dominante” includendovi anche le controspinte, di resistenza e di sovversione, che la dinamica della totalità comporta. Il problema, eminentemente politico, è la comprensione delle curve che essa ci squaderna. Per esempio, La lettera a una professoressa della scuola di Barbiana, con la sua scabrità con la sua insofferenza anticotestamentarie, recava la rabbia d’una sottomissione oramai insopportabile, la sua pagina additava l’energia e l’entusiasmo di un mondo nuovo che si afferma. Lì si leggono in figura i cattivi maestri che i benpensanti avevano deriso e punito, lì si trova in incubazione una generazione di subalterni che per prima è riuscita a lavarsi le mani dalla merda.
Qualche sera fa, Sergio Rizzo, giornalista del “Corriere della Sera”, per comprovare il dannoso anacronismo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in una trasmissione televisiva ha graziosamente dichiarato: “Ho chiesto ai miei due figli, lei di 19 anni lui di 24. Non sapevano che cosa fosse”. L’intervistatore assentiva sorridente. Non ci hanno detto che entrambi mangiano brioche. E certo per un sodo meccanismo retorico noto all’intervistatore – di sicuro in quel momento candido come la sua coscienza – il comune ascoltatore con quel sorriso ha dimenticato lo scarso pane della propria credenza.
Vicino, la giovane ragazza, studiosa e appassionata, decide alla fine che il suo destino non sarà la ricerca e lo studio, ma un breve corso professionalizzante. Nella civile Toscana dov’io nacqui e parlo ancora la lingua di Dante, l’abbandono scolastico è oggi al 17,6 per cento dei ragazzi in età scolare. Ma le cifre sono tante.
Anzi troppe. C’è il telegiornale che trionfa allegro il “boom dei giovani” negli alberghieri. Bene o male, un rudimento d’inglese per qualche oltrefrontiera lo impareranno.
7 ottobre 2014
Sulle domande del lettore
A Davide B.
Sembra che Eugenio Montale, al critico che gli sottoponesse un’interpretazione di suoi testi più oscuri, persino la meno probabile, rispondesse divertito ‘può essere’. Franco Fortini si diceva pronto a difendere con forza i suoi scritti critici, ma di non poter che alzare le mani di fronte alle critiche, anche feroci, verso le sue poesie. C’è dell’esagerazione in entrambi. Il primo enfatizza la sprezzatura aristocratica dell’autore a fronte della fatica del critico; il secondo esaspera la chiamata politico-morale del saggista. Dico esagerazione, perché ogni opera – saggistica o letteraria che sia – tende all’organicità, dunque a una polisemia dei suoi elementi, ovvero a un di più che non necessariamente obbedisce all’intenzione del suo autore. A questo allude l’espressione comune ‘l’opera ha una vita propria’.
Tuttavia la forzatura dei due intellettuali scaturisce da un dato innegabile: nell’opera d’arte agisce un grado maggiore – nella condizione e nell’espressione umana, si tratta sempre di gradi, come ha notato Freud a proposito di salute/patologia – d’inconsapevolezza, rispetto alla produzione saggistica. Che un personaggio, un intreccio, una situazione mostrino una loro energia intrinseca, refrattaria alla volontà dell’autore è testimoniato da scrittori di ogni epoca: dal “fŭrŏr” divino dell’epoca classica, al dantesco “Amor m’ispira […] e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando”, fino ai sei personaggi di Pirandello. Di conseguenza l’autore non gode alcuna posizione di vantaggio rispetto a qualsiasi altro fruitore. Anzi, la memoria in lui dell’intenzione, che ha preceduto e accompagnato la composizione e di cui il fruitore è invece scevro, può potentemente ingannarlo, proprio quando l’istinto comune gli attribuisce un’ingannevole autorevolezza. Ogni autore minimamente avvertito sa di questo proprio paradosso, quindi non per malignità verso il fruitore, ma per consapevole rispetto dell’opera – qualunque sia il valore di questa – se ne vieta l’interpretazione.
Se poi mi si chiedesse da dove proviene l’“inconsapevolezza” di cui ho parlato, indicherei una molteplicità di fonti. Una certamente, venuta alla luce per merito della psicoanalisi, è la carica del rimosso, individuale e sociale. Un’altra, forse più importante, è il complesso sistema di significati, relazioni, valori socialmente determinati che ogni persona, gesto, oggetto, sguardo, azione, parola porta con sé. Si tratta di un sistema quantitativamente rilevantissimo, in massima parte implicito come l’altra faccia della luna, eppure connaturato a ogni elemento del vivere umano, al punto che nessuno di tali elementi è letteralmente comprensibile se si amputa di quell’implicito; così come, per converso, sarebbe impronunciabile qualunque proposizione che volesse esplicitare l’intero suo non detto: dato un enunciato, dice Peirce, se ne può sempre trovare un altro più preciso. C’è infine da segnalare almeno un’altra fonte, ovvero le strutture formali storicamente determinate dell’opera, le istituzioni in cui essa si produce – dal genere, alla corrente culturale, ai canali in cui circola, ecc. – sono a loro volta portatrici di un proprio significato, con il gioco complesso di obbedienze e scarti attuato dall’opera in questione.
Per questo, Davide, non ho risposte alle tue domande. In realtà, esse sono rivolte all’opera. Dico meglio: non so se sempre, ma certo nella nostra epoca di sfruttamento e di alienazione il valore dell’arte non è nel dare risposte, ma nel germogliare domande; più le domande che radica sono urgenti e nascoste, più alto è il suo valore. D’altra parte tu medesimo avverti tale fatto, se nei libri, come dici, cerchi te stesso. Si cerca ciò che non c’è, che ci sfugge, che ci è sottratto, si cerca perché è una nostra menomazione.
Non posso invece che gioire dentro di me e ringraziarti apertamente di due implicazioni presenti nel tuo commento. Proprio in apertura affermi d’aver ascoltato le mie pagine come le canzoni di Velso, mio padre, e allo stesso modo ne hai compreso le parole. Questo significherebbe che non è stata tradita la parte che rivendico mia, che il mondo vivente nell’opera ha una sua verità. Un altro aspetto, più personale e privato, trattengo commosso dalle tue parole. Babbo, persona assai rispettosa delle scelte altrui, solo un paio di volte si è rammaricato che non ho seguito la sua passione musicale. Eppure le sue suonate sono il ritmo della mia infanzia. Mi dà piacere pensare che quelle dolcezze, quelle geometrie ora ardite, ora fonde, ora lievi che ordivano le sue dita indurite dalla terra siano trasfuse e nutrite nella mia sintassi.
Del tutto diversa, si capisce, è invece la questione di ciò che precede, accompagna e soprattutto segue il testo. Per me l’arte è sempre un invito al dialogo, non tanto – malgrado tutte le apparenze di cui si adorna l’opera e malgrado gli strabordanti narcisismi dell’autore - su di lei, quanto sul fuori di lei, sul nostro tempo. In quel dialogo mi sento impegnato. Anzi, sono convinto che uno dei modi più oppressivi - perché pervasivo, perché nasce dall’abbrutimento della mente e lo moltiplica - dell’odierna restaurazione antidemocratica è proprio la mancanza di dialogo. Non mi riferisco solo allo stato dell’industria della comunicazione, alla sua opera di censura della realtà, di cui credo di conoscere i motivi di profitto e di potere. Mi colpisce di più l’autoinibizione al dialogo tenacemente praticata nei nuovi mezzi generati da Internet, curvati al monologo. Persino là dove si presentano con la veste del confronto – penso alle rubriche “commento” – trasmutano in puri conati d’esistenza: urlo, quindi sono. Tralascio la questione, nota solo in parte peraltro, che quel vasto campo apparentemente libero è ricondotto al profitto da potenti soggetti economici. No, quello che mi colpisce di più, perché mostra davvero la subordinazione all’ideologia dominante, la forza di questa nella sottomissione, è il fatto che là dove i subalterni possono e comunque credono di parlare con la propria testa, sono umiliati alla coazione senza saperlo.
Per entrare nel merito di ciò che sta oltre l’opera, una cosa mi preme discutere con te, Davide. Conclusivamente mi ringrazi di aver dato vita, dici, a un passato di cui sentirsi orgogliosi. Come ho ampiamente affermato, non so pronunciarmi sul valore di quel passato, ossia di Domani, ma certo sono convinto che il mondo storico a cui esso rimanda non è affatto passato. Mi spiego meglio. Un’assai ampia dimensione del dominio e dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo di quel mondo vive e fruttifica fra noi. Un’altra vasta strutturazione storica, specifica questa della società italiana, è più che mai attiva nelle sofferenze odierne, nelle sue violente coartazioni. Un insieme di modi del vivere quotidiano, dei rapporti tra le persone travolti dall’industrializzazione novecentesca ritornano oggi non come schegge archeologiche, ma come potenzialità soppresse, enzimi vitali; ce lo dicono menti attente, giovani intraprendenti e non rassegnati. C’è infine tutta la dimensione del vivere con le stagioni, con le piante, con gli animali, che il prometeismo industriale supponeva d’aver cancellato e che invece torna nell’incubo delle nostre terre franose, dei disgeli oceanici. Voglio dire che dobbiamo sottrarci all’illusione o all’incubo che la storia sia solo un grande cimitero, che il passato sia solo un ricordo: non è la vita dell’individuo la misura del tempo, esattamente come la società umana non è una somma d’individui, per quanto il cinismo sprezzante del neoliberismo ce lo inculchi da quarant’anni. Si deve dunque sapere che il domani sperato nella nostra mente riaccende sempre dal passato energie che credevamo ormai spente o che ignoravamo del tutto.
Questa sorgente di forza è nostra.
29 agosto 2014
Di Zanzotto e di Fortini
Contro la società verticale
Zanzotto su Fortini :http://lapresenzadierato.com/2014/07/30/andrea-zanzotto-su-franco-fortini/
Qualunque lettore di critica sa la differenza tra il gusto collezionistico dell’erudito e la forza del critico che ti coinvolge con nuove domande, se non con le risposte. Il primo è fisso al passato, il secondo non cessa di parlare al futuro, per quanto distante e imprevisto esso sia. Un italianista statunitense ebbe a osservarmi, a proposito di una raccolta di scritti su Manzoni, tra cui uno di Fortini: non c’è bisogno di leggere la firma, il critico vero non ti fa distrarre, addita sempre te nella sua pagina. Se è vero per la critica, non lo è meno per l’opera letteraria, perché ciò attiene alla misteriosa, difficile e pericolosa qualità di ogni azione umana. È insieme nell’hic et nunc, ne subisce la genesi, la natura, ed è eterna. Anzi, tanto più è vera, ossia porta limpida la radice della propria profonda storicità, tanto più essa è di ogni uomo, di ogni tempo. Dunque esiste un criterio sicuro di rilevanza d’un testo come di un’azione comune, è il suo quantum che ci riguarda. Nel confrontarci con l’intervento zanzottiano su Franco Fortini, partiremo dunque da questo semplice metro immediato.
Diciannove anni dopo, chiuso con ogni evidenza il periodo storico del Novecento (intendo valori culturali, condizioni civili e istituzionali, associazioni sindacali e politiche, forme degli assilli, delle attese e delle relazioni della vita quotidiana), insomma catapultati in un altro mondo, al punto che l’ordine del discorso di Zanzotto potrebbe apparire non più distante da noi di un qualunque altro secolo trascorso, quali piaghe odierne mette a nudo, a quali mete sollecita l’attenzione?
Nell’immediata relazione con il testo, qualunque lettore di media consapevolezza e sufficiente attitudine al disinganno non sfuggirà ad almeno tre punti d’attrito. Non ha importanza, in prima approssimazione, distinguere quanto pertiene alla voce del soggetto e quanto a quella dell’oggetto critico. Chiara è comunque la sottolineatura di alcune urgenze. Nel mettere in guardia da fraintendimenti, Zanzotto addita l’energia, la fecondità creativa della “totalizzante fede in un senso del mondo”. Lasciamo agl’imbonitori e ai gazzettieri la trivialità di leggere nell’espressione un bisogno generico, quindi innocuo dell’uomo senza tempo. Nella realtà storico-concreta delle nostre strade, delle case dove consumiamo la vita tra alternative senza speranza, assiepate nel giorno come marruche e sterpi, quell’appello a un senso del mondo irrompe con la forza di un urlo d’allarme, di un palpito di speranza. Si proclama “totalizzante”. Non è una parte, nemmeno una somma; è una relazione, un insieme di relazioni, dove tutto si tiene. Di quel tutto noi stessi siamo parte, ogni nostro agire e dire e pensare. Ecco perché le impotenze e le umiliazioni che ci assalgono non sono né naturali né opera di un dio nascosto, ma prodotto storico-umano. Ecco perché esse non sono mai completamente tali, senza l’acquiescenza del nostro consenso. Zanzotto dà a quel senso il nome di “fede”, perché c’è ma si nasconde, va costretto a disvelarsi, meglio ancora a prodursi con il sudore della nostra fronte.
Zanzotto proclama inoltre l’urgenza di non porre in ombra il fondamento di “ogni atto culturale”, che è, dice, “etico-politico”. Il richiamo trova giustificazione nella già indicata totalità di senso, ma ciò che esso più scuote dell’odierno consenso è l’ovvietà che la politica sia tecnica e non etica; che l’etica sia un dato naturale o astorico, non scelta politica, dunque storica e di parte.
Dato che ogni atto culturale è etico-politico, qual è il senso della scelta linguistica di un poeta? Il segnale del pericolo di “parlare in lingua mortua cum mortuis” è, prima di tutto e ancora una volta, un avvertimento a tener desto l’occhio sul molto di scarto, di falsa-vita, magari incipriata dalla moda che affolla il bla bla soffocante dei nostri giorni. Un avvertimento a evitare di appagarci con il narcisismo della nostra irrilevanza. Poi è, più in concreto, un sorprendente squarcio sulla realtà linguistica italiana, sul suo quasi inerme cedere alle pressioni – oggi lo vediamo bene – della neo-lingua angloamericana, al suo impidocchiarsi di locuzioni intraducibili, storture sintattiche, tanto da esporsi al contraccolpo della riemersione dei forti sostrati antichi, traboccanti fino all’idiotismo. Colpi dal basso e dall’alto, dunque, oggi autorevolmente assecondati dall’esibizione di interi percorsi universitari italiani in lingua inglese. Questo frangersi che appare senza scampo, ci avverte ancora Zanzotto, non è un fatto esclusivamente linguistico: è il prodursi stesso della “disgregazione italiana”. Compagni, ripeterebbe ancor oggi Bertolt Brecht, come già fece al Congresso internazionale degli scrittori in difesa della cultura del 1935, parliamo dei rapporti di proprietà; dunque dell’odierno finanz-capitalismo e, in esso, del ruolo subalterno della classe dominante italiana, disposta a tutto sperperare e tutti ridurre a plebe, pur di conservare il proprio comando e ricchezza.
Registrati gli urti, si tratta di rispondere alla domanda fondamentale: chi è che ci parla? Perché solo con la sua risposta possiamo comprendere le circostanze da cui quegli urti ci giungono, il sottointeso di cui si caricano: natura di cose - cioè fatti storico-umani, spiega una volta per tutte Vico – altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise. E comprendere la determinazione storica di chi ci parla è il dé-tournement necessario per intendere noi nella nostra. L’articolo zanzottiano per la solennità della circostanza, il rilievo della figura e la forza della frequentazione si presenta come uno specimen altamente emblematico per indicarci il timbro fondamentale dell’autore, la nervatura del suo discorso, le strategie su cui si muove. Nel contempo, la natura seconda dello scritto obbliga a intrecciare ad esso l’ulteriore détournement su Franco Fortini.
Clamorosa – per chi conosca l’imponente rilievo politico e saggistico di Fortini nel suo tempo – è la scelta zanzottiana di mettere in primo piano Fortini poeta, quando la critica coeva non era mai stata su questo generosa. Saremmo tuttavia assai lontani dal vero, se vedessimo quella scelta dettata dalla svolta post-ideologica affermatasi alla fine del secolo breve, che ha portato un’intera generazione di uomini della politica, della cultura o della militanza politico-sindacale intermedia all’esplicito misconoscimento del proprio passato, con franca adesione all’antisocialismo e all’antimarxismo. Quell’avvio della restaurazione liberista e antidemocratica ha prodotto, tra i suoi effetti, il ritorno a una visione della poesia “pura” da implicazioni diverse da se stessa, fino ad asserirla, in certe aree, fatto assolutamente privato. Che la strada di Zanzotto sia diversa – e, per chi lo conosce, in intima coerenza con sé – è chiaro fin dall’abbrivio, dove si riconosce con parole nette, condividendola, la complessità della figura intellettuale di Fortini. Ma, più cogentemente, è l’intero sviluppo del ragionamento a connettere lo sguardo sulla poesia con l’insieme dell’attività saggistica, secondo l’ottica della totalità.
Zanzotto poeta e critico, come ho cercato di mostrare altrove, muove da un’originaria, potente spinta orfica che presto ha accettato di confrontarsi con le ragioni altrettanto perentorie della storia. Egli ha saputo acutamente far di questo suo dualismo costitutivo chiave d’accesso al proprio tempo. Per un verso ha ricondotto l’urto deflgrante dei suoi demoni interiori - che costantemente lo risucchiavano ben oltre il paesaggio, verso la cancellazione di ogni cultura umana e di sé medesimo - alla disciplina insieme funambolica e iperraziocinante della psicoanalisi lacaniana; per l’altro ha coltivato la sua compromissione con la storia, passata a contrappelo dall’ostentata marginalità solighese, mettendo via via a frutto tanto il socialismo resistenziale, quanto una vitalissima radice sensista e materialista di derivazione e natura indubitabilmente colta, ma in parte consonante con l’universo rurale cui è rimasto fedele.
Credo che le ragioni del primato che, “tra le figure dell’umano”, egli assegna al poeta si trovino sia nell’orfismo che su per li rami lo collega alla grande stagione romantica europea, sia nel ricorso al surrealismo lacaniano. Un primato che però mai ha ceduto alla presunzione di sufficienza e di esclusione dalla totalità storico-umana, come anche nell’articolo in questione ben si conferma. Totalità non ricomposta, si capisce: strenuamente inseguita, ora raggiunta, ora dileguante, ora semplicemente segnata da una béance sanguinante. Zanzotto ha saputo portarsi all’altezza del proprio tempo proprio facendo circuitare la personale ferita originaria con il fermentante conflitto sociale, politico e culturale che ha caratterizzato il trentennio del secondo dopoguerra. Conflitto tra capitale e lavoro, donne e uomini, movimenti sociali e istituzioni, creatività e conservazione. Un conflitto assai aspro, anche cruento, che ha però prodotto nel mondo e in Italia una decisa democratizzazione.
Come accade a un pensiero forte e ai poeti autentici, Zanzotto impiega il proprio metro anche nella lettura degli altri, tanto più penetrante quanto più affini gli autori, né sorprenderà che in quella qui in questione muova sul filo del ricordo personale. Come ogni pensiero, sgorga con la sua lingua. Il lettore non tarderà ad accorgersi che la nota dominante dell’articolo è il contrasto, ora nei modi sintattici più distesi dell’antitesi, ora nell’ossimoro, per quanto esso qui figuri nella giuntura attenuata da congiunzione: “Bellicoso e contemporaneamente rattratto in sé”; sentir “peccaminoso” il “degustare, porsi al servizio”; “nell’estremamente futile” una “verità”; “le sue insicurezze diventavano cogenti”; ecc. La frequenza e la concentrazione nell’ossimoro del procedimento si accentuano via via che l’avvicinamento all’oggetto si fa maggiore, insieme con la condivisione: “generoso e intransigente”; “raggiunto e risparmiato”; “verificarsi e vanificarsi”; “un vagito” che “sa di essere un rantolo”; ecc. È appena il caso di notare che l’antitesi non è a somma zero, ma affina lo sguardo su elementi realmente confliggenti, innescando al contempo l’insofferenza contro ogni acquetamento.
Anche la scelta lessicale è mossa da un’energia che mentre cerca ora la precisione tecnica – principalmente della psicoanalisi, ma anche delle scienze, come “clonato”, o del linguaggio sportivo, “sprint”-; ora di ben determinati campi della cultura – dal dantesco “dittar dentro”, alle “nuge” dei neoteroi latini, fino al latino biblico, all’immancabile francese surrealista e al classicismo filosofico della “cosa in sé” -; tale energia sempre pone quegli appoggi specialistici al servizio di una più ampia connessione e del sapere e dei tempi storici. Da qui la sorvegliatezza del registro, la complessità e le impuntature della sintassi, in perfetta coerenza e quasi in reazione all’allarme sullo sfaldamento dell’italiano.
Zanzotto, come da sua premessa, articola il breve percorso, che in verità abbraccia l’intero quarantennio della frequentazione, intorno alla questione della poesia. Tralasciando i riconoscimenti ricevuti sulla propria poesia, portati a riprova della coerenza fortiniana tra poetica e prassi critica, risultano con nettezza il terreno comune e la diversa ‘traduzione’ che nei due intellettuali esso riceve. Se sotto l’aspetto delle genealogie culturali la consonanza tra i due affonda nel condiviso magistero del romanticismo europeo, sul piano più strettamente storico-sociale loro coevo identica è l’acutezza di sguardo su ciò che Fortini ha chiamato fine del mandato degli intellettuali, di cui il poeta è forma particolare.
Per Fortini la poesia e in genere l’opera d’arte nella società capitalistico-borghese soffre di una doppia mistificazione, che acceca il lettore così come il suo autore. In quanto totalità realizzata ‘in figura’ e in forza del suo costitutivo imperativo al fruitore – sii come me - la forma artistica dà l’illusione di attuare quella pienezza di senso del mondo cui solo una riappropriazione reale del destino comune e di ciascuno può effettivamente approssimarsi. Una mistificazione assai palese e talvolta – come in D’Annunzio – cinica di tale condizione è nell’equiparazione di arte e vita compiuta dall’estetismo primo novecentesco. La seconda mistificazione deriva dalla più ampia condizione della lingua e della cultura. In Fortini ferma è la convinzione marxista che ogni produzione culturale e, prima ancora, ogni enunciato semiotico prende significato dal contesto in cui nasce e vive, compreso quindi il suo medesimo fruitore: due persone diverse che dicono la stessa cosa non dicono la stessa cosa, indica icastico. Tale condizione paradossale, che in verità è diretto portato della socialità dell’uomo, della sua capacità di produrre la storia del proprio genere, incide nella pretesa autosufficienza dell’opera d’arte una seconda ferita, per quanto nascosta dal godimento estetico.
Si tratta di una condizione storica insuperabile in una società basata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo; una contraddizione reale che solo la consapevolezza dello sfruttamento e dell’alienazione rende possibile all’autore e al fruitore di vivere alla sua altezza, cioè in uno stato di negazione e insieme di rifiuto di quell’impotenza. Tale condizione da Fortini è rappresentata con due diverse espressioni: il significato delle parole lo decide chi comanda; la poesia è sempre poesia dei padroni. Per questo, in compagnia di grandi e diversi marxisti, da Lenin a Benjamin fino a Gramsci, sia rammenta a se stesso il comandamento qui ricordato da Zanzotto: non serve a niente, ma scrivi; sia, ricorda ancora il solighese, per lui il poeta non occupa il primo posto. Se solo sul terreno reale, ossia esterno alla totalità dell’opera d’arte, è possibile rendere effettivo l’orizzonte di senso che essa propone e mistifica; è però altrettanto vero che nel tout-se-tien della sua opera fermenta quel bisogno di riappropriazione comune della vita che, dice Fortini, costringeva Lenin a interrompere furioso l’ascolto di Beetoven.
Esattamente questo snodo costitutivo Zanzotto mette a fuoco, perché esso rifrange la propria medesima croce, tradotto, come dicevo, “iuxta propria principia”. La fortiniana lingua dei padroni diventa la lingua dell’inconscio. Il salto tra poeta e saggista, cui Fortini fa fronte con, come con acuta sensibilità dice Zanzotto, “quel tipo di presicurezza insonne che lo travagliava […] una stretta, una tenaglia, un invito ad un’ordalia non evitabile”, mentre Zanzotto, sopraffatto piuttosto dal suo “rapporto col nulla”, cede all’acedia.
Entrambi gli autori, dunque, hanno saputo guardare oltre la superficie dell’impetuosa crescita del dopoguerra, il cui slancio in parte mascherava e rendeva più tollerabili contraddizioni sociali, sopraffazioni umane e alienazioni, sperimentate a partire dalla propria condizione di poeti e di intellettuali, mostrandone nel proprio diverso linguaggio la perdita di ruolo, gli smarrimenti di senso. Comune è anche l’apparentemente opposta marginalità: Fortini, al centro della scena culturale ma in posizione di cattivo maestro delle minoranze, guardato con sufficienza dagli stati maggiori della poesia italiana; Zanzotto, ai margini della marca trevigiana, senza influenza nello scontro intellettuale, ma subito accolto dai poeti più influenti della poesia italiana. Condizione e prezzo, la collocazione ai margini, di chi si ostinava ad ascoltare il vuoto (nella condizione quotidiana, nel cuore euroamericano, nei terzi e quarti mondi) e pretendeva, come aveva insegnato il grande pensiero critico otto-novecentesco, che esso non fosse un residuo, un’incompletezza non ancora raggiunta dalle magnifiche sorti, ma costituisse il prodotto costante e il nutrimento indispensabile del “pieno” che otturava la vista. In entrambi l’orizzonte di senso prendeva insomma la forma della totalità. Per Fortini, essa era una costruzione storica da produrre in una formazione economico-sociale futura, per cui all’intellettuale critico spettava il compito di porsi al massimo livello dello sviluppo intellettuale per mostrarne la contraddizione negativa che ne teneva aperta la dialettica – l’uno, diceva in quegli anni Mao, si divide sempre in due. Trova qui ragione fondativa la raffinata e potente pratica manierista della poesia fortiniana. Per Zanzotto, la totalità è un regno perduto – ma nella sua maggiore consapevolezza, si rammenti, al di là di qualunque dimensione storica, ossia di tentazione nostalgica – da tentare instancabilmente nel dispiegarsi più ampio della storia, di qui la ricorrenza del suo “rapporto col nulla”, le ricadute nell’acedia, di qui l’opposizione simmetrica tra l’impossibilità originaria della parola e la paradossale “verbalizzazione del mondo” (anche in senso tecnico, si pensi alla fertilissima disponibilità plurilinguista zanzottiana), di qui, infine, la centralità, nella sua pagina, dell’ossimoro.
Oggi la restaurazione di una feroce società verticale sotto il dominio triste del finanz-capitalismo ha così potentemente esteso le condizioni della marginalità, non solo del ruolo intellettuale, da farle apparire naturali e se le forme possibili dell’agire contro lo stato di cose presenti sono anch’esse mutate, scendendo ancor più rasoterra, più acuta che mai è divenuta la necessità di un orizzonte di senso che sappia riconnettere le parti del vivere comune e ne mostri la verità storica.
16 agosto 2014
I Padroni del Mondo
Mario Alighiero Manacorda, Perché non posso non dirmi comunista. Una grande utopia che non può morire, prefazione di Donatello Santarone, Roma, Editori Riuniti, 2014.
«Se siamo al passaggio dal capitalismo industriale a una forma totalizzante e diffusa di capitalismo finanziario, allora è qui che dobbiamo guardare per capire qualcosa. Oggi, anche grazie alle possibilità dell’informatica e della rete, il vero dominatore del mondo non è più il padrone delle fabbriche che producono beni materiali, ma sono quei manager-azionisti che dalle banche e dalle borse, senza essere formalmente né padroni né, tantomeno, gestori tecnici delle aziende, conoscendo il valore dei titoli e le loro oscillazioni, possono comprarle e venderle speculando per sé e impoverendo gli altri, a cominciare da quei “colletti bianchi” che, vivendo alla loro ombra credevano di tutto sapere e tutto poter guadagnare. E questo tanto più che, essendo questi manager spesso anche politici (ecco il conflitto d’interessi!), con una sola parola possono far salire o scendere ad libitum i valori delle azioni, vendendole quando valgono e ricomprandole quando saranno precipitate. Così hanno fatto e fanno i Bush e compari in Usa e, poniamo, i Tronchetti Provera tra noi, e anche qualche nostrano politico minore, non solo della destra, purtroppo. Ci vuol tanto a capire che chi potrà decidere di fare o non fare la guerra, o anche solo di annunciarla, farà salire e scendere le azioni dei fabbricanti d’armi e di medicinali e dei padroni del petrolio e potrà giocarsele a piacimento? E intanto spingere il mondo alle guerre in nome della democrazia?
[…] Oggi la sola speranza è l’affiorare di una coscienza nuova tra i popoli emarginati e tra i giovani di tutto il mondo, che non ha più il nome impossibile di comunismo, e non ha altro nome che una negazione, in cui esprime la contraddizione al processo dominante, afferma una diversa universalizzazione della convivenza umana e può parlare di pace senza ipocrisie. […] Non mi divide certo da lui il fatto di pensare a questo o a quel dio o a nessun dio, perché questo rientra, per me e per lui, in quella mentisi libertas in cui è la beatitudo; mi può invece unire a lui il comportamento umano (umanitario, umanistico?) e la comune ricerca del massimo bene possibile per il massimo numero degli uomini, anzi dei viventi».
27 luglio 2014
Esercizi cinesi
clicca qui per la discussione
Se, come avviene oggi, 400 individui sono proprietari del 40% delle ricchezze dell'intero genere umano, non meraviglierà scoprirci numeri di una società verticale. Tuttavia - è un dato psicologico e politico risaputo - quasi mai l'ovvio è anche consapevolezza.
Invito chi mi legge al semplice esperimento mentale che io, per circostanze fortuite, ho proposto a me stesso con questa domanda: nella mia vita attuale, quali sono i luoghi fisici, quali le occasioni del giorno o del mese, quali le persone con cui avviene il mio confronto su di me e sul mondo? Con "confronto" intendo conoscenza dei dati di fatto, formazione di un giudizio, costruzione di relazioni, in modo tale che esso sia quegli elementi costruisca e verifichi, sia immetta a una risposta pratica, individuale e collettiva, alle attese aperte. Temo che la gran parte di voi giunga alla stessa risposta data a me stesso: pressoché nessun confronto. Le conoscenze me le procuro in modo non dissimile nella sostanza dalle mie escursioni al supermercato. Tengo d'occhio il foglietto che mi porto dietro, controllo quello che trovo, cerco di scegliere quello che meno mi è estraneo (per pregiudizio? Per precedenti e dimenticati imbonimenti pubblicitari? Per seduzione momentanea?), metto nel carrello e alla fine passo alla cassa. Raramente guardo a gesti analoghi di chi mi passa accanto, praticamente mai chiedo informazioni o pareri. Così guardo le immagini del telegiornale o del talk show, sfoglio qualche videata di Internet, dove non infrequentemente capita che qualcuno si senta vivo perché vi digita un urlio o una qualche parola bassa.
Questo, intendo, è società verticale.
Mi rendo però conto che, per quanto disumano sia il divario tra chi ha e chi non ha, esso da solo non basta a spiegare il fenomeno per cui si parla con una lingua via via più povera, poco più che bambinesca, articolazione di parole frasi, eppure autorevolissima per i luoghi di potere da cui parla, senza contrasto di sostanza ma solo - e acerrimo - per chi ricopra il medesimo posto con la medesima funzione. C'è dunque un di più, sì intimamente connesso a quel divario materiale, ma di natura diversa.
Lo scarto con cui il capitale è passato negli ultimi trent'anni al finanz-capitalismo - in ciò aiutato dal fallimento dei socialismi storici - ha sbaraccato, insieme con il compromesso keynesiano, ogni strumento di analisi critica del presente. Prove empiriche abbondano da ogni lato. Mi limito a un dato, sociologico, che riguarda la pratica di terra bruciata in atto nel campo della cultura di base. Tutti i rilievi statistici a disposizione segnalano la precipitosa regressione dalla scolarizzazione di massa, conquistata nel trentennio del secondo dopoguerra: abbandoni scolastici, analfabetismo funzionale, inutilità dei titoli ottenuti, ostacoli senza fine - disciplinari ed economici - per chi voglia percorrere gli alti studi. Tutti fenomeni troppo convergenti e massivi, perché siano dovuti al caso. Così, nel pensiero comune, ossia nelle idee dominanti, il capitalismo è tornato a essere ciò che da sempre vuole apparire: un dato naturale.
La nostra è divenuta una società senza pensiero.
E' per questo secondo fatto, disumano quanto il suo volto materiale, che le classi subalterne sono tornate plebe, poveri e le persone fantasmi, "gente" si dice in lingua italiana. In questo cascame, se la cosa - come accade - non trova la sua parola, allora la sofferenza della dignità calpestata, delle vite strozzate nella giovinezza, della povertà che fa sanguinare i corpi, diventa solo un gesto, terra e sterco.
Bisogna sudare la fatica del concetto. Per farlo, in questo tempo della miseria, occorre la sapienza cinese di partire dalla quotidiana ginnastica della mente, delle emozioni, della morale, del linguaggio, perché i nostri gesti siano meno distanti possibile dalle nostre parole, perché quella parte di plebe, di cecità, di disperazione che è in noi cessi quanto più di essere serva, ometta, per quanto difficile possa risultare, ininfluente possa apparire, di portare la nostra fascina al rogo, affinché i legami interrati che, benché battuti e umiliati, tuttavia sussistono, possano con pazienza fruttificare più in alto nel nostro domani.
8 aprile 2014
Dia-loghi
Ho riflettuto a lungo sugli echi che dalle opere mi giungono qui, come falò notturni, da chi legge.
Sebbene sappia che l'opera d'arte parla con una voce che solo in parte è quella del suo atuore, né di essa mi sento irresponsabile, né al suo cammino sono indifferente: nelle età della miseria, il cerimoniale dell'opera d'arte s'istalla proprio come speranza contro la speranza. Per questo guardo con fiducia i segnali che incrinano la notte. Vi devo una risposta. Parziale, certo, e obliqua, come ho detto.
Nelle varie e personali sottolineature - ognuna con una sua sorprendente acutezza - delle opere, scorgo una nervatura comune che desidero mettere in risalto. "L'opera tua ha già preso il volo, per dare voci ad altre voci...Mi chiedo: dispiace ad un autore essere letto così 'liberamente'?". Il gesto di cortesia, la scusa garbata che Daniela Marretti (3/1/2014) porge nella domanda non mette in discussione la certezza del fatto che la precede. La mia risposta, dal posto decentrato che all'autore compete, è diretta: no. Anzi, leggo rinfrancato la medesima spinta in tutti gli altri interventi. "Accendere una luce nella mente", scrive filorosso (7/12/2013), con rinvio ai dormienti eraclitei; "Voglia di poter vivere in prima persona" testimonia Tiziana Peri (17/12/2013); "Grazie" dice Mavì (1/1/2014) "della forza dell'attesa"; "Ritengo che ogni considerazione" scrive Anonimo (1/1/2014) "nasca da una sedimentazione nel nostro cuore e nella nostra mente"; "Spetta a noi" conclude Natalino Pacca (7/1/2014) "acquisire la consapevolezza di come le vicende passate possano illuminare la nostra lettura del presente e guidarci nel cammino verso il domani".
La forza attiva che filtra dai lettori, se posso dirlo, mi fa fiero. E' in ogni modo ciò che con convinzione attendo da ogni opera d'arte, perché ben prima di questa e molto più di questa cresce, rasoterra, la necessità del dialogo. il logos che si alimenta solo scambiandocelo.
18 gennaio 2014
Questa notte
C'è un tumulto, indietro
Soffoca ora la porta. Fuori
il lago dell'alba.
Non tacere
amore, non tacere
il nodo che strozza la notte.
Lo senti anche tu
il balzo nel petto, la fonda del mare
e il figlio, che sogna quieto. In questa notte
apri mia vita
la mano.
(14 dicembre 2013: nelle piazze, abbai osceni e gridi disperati)
Ai miei sei lettori, anzi lettrici
«Come la parola prende vita nel dialogo, così l’opera letteraria vive nel giungere da altro e nel trasformarsi in altro. Un testo, malgrado le apparenze e le sue pretese, non è mai anaerobico. Per quanto misteriose siano le vie che segue, l’arte, come ogni esperienza di vita, interroga, invita a una forma, sollecita al dialogo ben oltre se stessa: più mezzo che fine, sebbene non cessi di fermentare. Per questo ho contestualmente aperto un sito a cui sei invitato».
Così scrivo in un cartoncino che, a segnalibro, allego ai volumi del mio romanzo, Domani, quando mi capita di darlo direttamente al lettore. Mi sembrano le parole più adatte a ricordare lo spirito di tutto quello che, qui, state leggendo, ragione per cui apprezzo tantissimo i messaggi che mi avete lasciato, care lettrici.
Questa mattina, mi capitava di far notare ai miei giovanissimi allievi la necessità inalienabile e vitalissima della comunicazione, ricordando l’esperienza eroica di quello statista sudamericano che, costretto per un decennio all’isolamento più aberrante, si è salvato dalla pazzia parlando con gl’insetti della sua grotta. Ma avrei parimenti potuto parlare loro delle osservazioni minute e curiose del carcerato Gramsci Antonio sul passerotto che teneva in cella.
La prima riflessione che dai vostri messaggi mi viene è – se posso dirlo – di genere. È assolutamente notevole, e certo non casuale, che le firme siano tutte femminili. Ebbene? – dice una mia voce erudita – anche il Decameron si affidava alle donne. Ma credo invece che ci sia qualcosa di più, di meglio. Vi scorgo il segno, visibile nelle nostre aule e in mille altri luoghi anche se non nelle gerarchie della nostra società, di uno scatto in avanti compiuto dalla donna nel secolo scorso. Qualcuno addirittura, lo storico Hobsbawm tra essi, afferma che l’emancipazione del genere femminile è stata forse la più duratura rivoluzione del Novecento. Sia chiaro, emancipazione non vuol dire liberazione, ma certo segnala la crisi del ruolo maschile, ben avvertibile sotto l’inturgidirsi ridicolo e malfermo, da dominio decrepito, delle nostre società tardo capitalistiche.
La seconda riflessione nasce dalle notazioni di più d’una di voi. «Intimidita dalla bellezza delle tue parole», scrivi esattamente, am. Si tratta di un punto assai importante, ben oltre le nostre piccole cose. Qualche tempo fa, a una mia classe quinta, per spiegare il senso profondo che scorgo nell’arte dannunziana, usavo queste parole. D’Annunzio, con le sue poesie, conduce il proprio lettore in una stanza meravigliosamente arredata di gioielli, pietre preziose, oggetti luccicanti e dice: «Guardate, tutto questo è mio, non potrà mai essere vostro».
Di questo genere di bellezza, di questo uso terroristico della bellezza non so che farci. Lascio che i morti seppelliscano i morti.
Vuol forse dire questo che la bellezza, la verità, l’autentico è l’informale, lo sciatto, il brutto, il triviale? La verità è quella dell’iper-vero della vita in diretta, delle liti a pagamento, dei talk show, del microfono aperto, della spazzatura che soffoca le nostre vite?
C’è invece, provvisoria quanto si vuole, incerta quanto il crepuscolo, ma vitale come l’alba che preme, un’altra strada. Affinare lo sguardo e la voce, far maturare il silenzio: scusate se sono stato lungo, scrive il filosofo, ma non avevo tempo. Se la parola che in questo modo esce è ardua, lo sarà solo per la promessa che indica necessaria. Perché ci fa toccar con mano la bellezza che ci si sottrae, ma che ci appartiene quale nostro bene più intimo. La sofferenza che allora ci stringe è la verità della nostra condizione, la spinta a ribaltarla il principio di guarigione.
18 novembre 2013
La merce è libertà
Nelle paginette del Manifesto del 1848, sempre pronte sul mio comodino, si dice con insuperabile chiarezza che con il capitalismo la libertà diventa merce. Quel disvelamento ha segnato la mia vita, come di altri milioni prima e accanto a me.
Questa mattina, durante l’intervallo una mia giovanissima allieva mi chiede a bruciapelo: «È vero che lei ha pubblicato un romanzo?». Colto così, sul fatto, non ho saputo mentire. Ne è nata una breve fila di domande e risposte. A un certo punto, un’altra osserva: «Ora, chissà quanti soldi farà». Sorridendo, ho solo osservato che non sono né calciatore, né comico, né presentatore televisivo. La discussione si è fatta più interessante.
Suonata la campanella, sulla via dell’uscita, nel fiume che scorreva chiassoso, l’amico fidato mi parlava della notizia del giorno: la prostituzione protoadolescenziale in scuole del Nord, del Sud e nella capitale. Insieme con l’orrore, ci siamo detti il muro salito in questi ultimi decenni tra la verità a fatica conquistata e le parole che vorrebbero pronunciarla. Ci siamo guardati smarriti, fino al saluto nell’aria tiepida del falso settembre.
Abbiamo seguitato a meditare l’oscenità che quei fatti e mille altri, anonimi, gridano, senza essere intesi. La mercificazione dei corpi, delle menti, dell’aria, dell’acqua, dei sogni e del domani è talmente ovvia e triviale che il bambino e l’accademico accolgono pacifici la Verità autoevidente: non è vero che la libertà è merce; astruseria non meno falsa di chi affermasse che l’aria è respiro, come se il respiro fosse in funzione dell’aria. No, è proprio la merce che è libertà.
8 novembre 2013
L'onestà di un poeta
Luciano Morandini
Ho conosciuto Luciano Morandini solo per telefono. Ci siamo scambiati alcune lettere per qualche lavoro comune. La sua era una parola pacata e generosa, che ascoltavo con piacere e profitto. Quando una turbolenta vicenda – sciagurata, invero, ma per niente eccezionale nell’indegna gestione della cosa pubblica in cui precipita da anni il nostro Paese – travolse il gruppo culturale con cui collaboravo, ricevemmo un’importante lettera di solidarietà e di protesta. Pochi anni dopo, nel 2009, apprendemmo con dolore la notizia della sua scomparsa improvvisa.
Ora, una scelta postuma di suoi scritti militanti mi raggiunge come un nuovo dono. Morandini, nato nel 1928, è una figura assai interessante del secondo Novecento. Formatosi sull’opera del personalismo cattolico di Emmanuel Mounier, aderisce al socialismo. I suoi esordi poetici (Terra d’amore, Fino all’arco dei monti, Monrupino) e intellettuali avvengono nella temperie del neorealismo. Infaticabile la sua attività culturale, dai programmi per la Rai del Friuli Venezia Giulia e per Radio Koper-Capodistria, a direttore delle riviste friulane “Zeta” e “Diverse Lingue”. Sue opere sono state tradotte in sloveno, serbo-croato, tedesco, inglese e spagnolo.
Il volume, L’onestà del poeta, a cura di Giuseppe Marini, (Udine, Forum, 2013, pp.227) reca un titolo preso in prestito da Umberto Saba. Vi si raccoglie una scelta di scritti per la rivista “Il Nuovo Friuli”, dal 2001 all’anno della morte. Certo in coerenza con la testata, emerge assai chiara l’organicità profonda dell’autore alla terra natale, come già era accaduto, per restare entro le coordinate geografiche, a molti suoi maggiori o coetanei, da Saba, a Biagio Marin, a Amedeo Giacomini fino alla matria solighese di Andrea Zanzotto, per altro mai nominato in queste pagine. Del resto, come ha insegnato a suo tempo Carlo Dionisotti, è l’intera letteratura italiana - dunque la lingua, la cultura e la vita sociale - a portare impresso il segno della pluralità regionale.
L’inaugurale neorealismo di Morandini ne costituisce appunto una specifica coloritura generazionale e personale, con la carica libertaria e contestativa che, fino agli anni Sessanta, la rivendicazione delle particolarità locali e dal basso comportava. Ma gl’interventi ora raccolti sono tutti nati in piena rivoluzione passiva berlusconiana e nella travolgente globalizzazione neoliberista. Tra i tanti nomi che hanno ribaltato il loro significato, nel cuore del leghismo incontriamo naturalmente la spinta contro il centralismo, tanto più che anche la vicina pluralità eterodossa della Repubblica Jugoslava è tornata ad essere, come prima del “secolo breve”, piaga sanguinante d’Europa. Così, il sarcasmo di Morandini si scaglia contro il “Padrone della Casa” che nell’edizione dell’Elogio della pazzia di Erasmo da Rotterdam, preso dalla furia imbonitrice, si fa a propria insaputa prefatore dell’autoritratto: “credete che mi ricordi ancora di quel che ho detto? […] Dicevano gli antichi: odio il commensale che ha buona memoria. E i moderni: odio l’uditore che ha buona memoria […] addio, dunque: applaudite, state sani, bevete”. Per la medesima buona ragione Morandini prende le distanze dal leghismo: “mi chiedevo […] se non sia artificiosa e retorica ogni pretesa che si richiami alla diversità friulana”.
Gli scritti pongono dunque con energia l’accento su quelle linee d’apertura che il Friuli, terra di confine quanto forse poche altre, porta nel proprio seno: dall’area mitteleuropea, alle nuove regioni ex jugoslave, fino alle antiche migrazioni contadine verso il Nord e verso le Americhe. Tuttavia gli scritti si portano un nodo irrisolto, tra la rivendicazione di queste aperture e l’attaccamento all’‘identità’: “se la destra più rozza si schiera tutt’oggi acriticamente, fino alla xenofobia, sulla linea dell’etnocentrismo, per la sinistra l’identità è qualcosa di diverso, non è autoaffermazione che esclude, ma senso di un’appartenenza che si coniuga, democraticamente, con il rispetto di tutte le identità, nel nome dei diritti universali e della collaborazione fra le culture di varia appartenenza, locali o nazionali che siano”. La risposta al razzismo e all’accecamento corporativo consisterebbe insomma in una diversa disposizione morale: abbandonare l’esclusione per l’accoglimento. È altamente significativo dell’impotenza che attanaglia le nostre vite e offusca il domani il fatto che la fedeltà di Morandini all’originario socialismo umanitario – sua “onestà” e suo onore - approdi alle medesime posizioni dei nuovi movimenti mondiali: radicati sì nel loro specifico e magari radicali, ma incapaci di cogliere e praticare, o rivendicare ciò che unifica, solo invocando il processo per addizione.
3 novembre 2013
Orfani per inganno
Maria Vittoria De Filippis, Copé hai il nonoso?
Inavvertito, come lo sguardo casuale d’una passante, il postino ha lasciato furtivo il volumetto di Maria Vittoria De Filippis, Mavì per tutti gli amici e per lei stessa. Une mémoire lieve come il volo d’una farfalla, un libretto d’altri tempi. La scrittrice lavora con tenacia a levare. Entra nelle pieghe straziate della propria vita e nei palpiti dell’altrui con discrezione settecentesca, dove il sorriso e le nuance mai fanno velo alla sincerità.
Il lettore risale agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale per poi discendere fino agli sbigottimenti della nostra epoca triste. I paesaggi vanno dagli esilî antifascisti della provincia francese alla Firenze dell’Italietta mussoliniana, fino all’amata Roma degli studi, del teatro, della politica e poi allo sguardo europeo della Milano di Fortini. Ma non manca la provincia italiana delle vacanze, dei sodalizi intellettuali, dell’amore: la Ciociaria, l’Amiata, Bocca di Magra, la Sardegna, fra le altre. La voce narrante si abbandona alla percussività della memoria, ma non sfugge al lettore avvertito la forza sotterranea che la muove, lo strazio del misconoscimento paterno e, ancor più ferrigno, quello materno e familiare, l’originaria messa in questione radicale del proprio sé, tenuto così in sospeso tra l’abisso del vuoto di verità e la nausea della menzogna. Una vertigine che nessuna confessione tardiva riuscirà a sanare, né lunghi anni d’analisi.
Accanto e sopra questo filo intimo, si dipana la trama degl’incontri ricca, sorprendente nella quale l’olimpica impertinenza di bambina accosta Giorgio Napolitano al contadino Basilio, Guido Calogero alla balia ciociara… Così il lettore, guidato dalla voce confidente nella stanza delle cucine, si trova, senz’avvedersene, per effetto di una magia intimamente femminile, a percorrere un tratto importante della cultura e della politica del Novecento: da Franco Fortini a Ugo La Malfa, da Luigi Cancrini a Vittorio Gassman, da Edoarda Masi a Jean-Marie Straub, da Giulio Einaudi a Tullio Gregory.
Chiuso il volumetto, mi soffermo sul volto di una Mavì di pochi mesi in braccia alla madre, dove calamita incredibilmente severo – come presago - lo sguardo sulla donna di spalle.
La foto del retro si stacca sull’intenso chiaroscuro d’un mare al tramonto che gira fino alla prima di copertina, senza indicazioni della casa editrice. Apro la pagina del colophon: “libro pubblicato dall’autore, ilmiolibro.it , 2013”
17 ottobre 2013
Il pane quotidiano
Certo, di fronte ai lancinanti resoconti di Tullio de Mauro, autorevoli quanto inascoltati, sull’analfabetismo in Italia (“solo il 20 per cento della popolazione adulta italiana è in grado di orientarsi nella società contemporanea”, 2012) e dopo la lettura a caldo dell’ultima inchiesta Ocse, che nelle competenze alfabetiche conferma l’Italia, con 250 punti (il massimo essendo 500), lontana dalla media Ocse del 273 http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf potrebbe apparire quasi frivolo parlare delle storture nell’industria editoriale. Ma di frivolo, anzi, di osceno, c’è solo il succedersi delle dichiarazioni dei ministri competenti, meglio, responsabili: “bamboccioni” (Padoa-Schioppa, ministro dell’Economia 2006-8), “choosy” (Fornero, ministra del Welfare 2011-12), “poco occupabili” (Giovannini, ministro del Lavoro in carica). La mia collega di matematica mi mostrava con vergogna e sensi di colpa i dati. Le ho risposto che negli ultimi trent’anni la scuola – insieme con tutti i servizi dello stato sociale con i quali si è tentato di dare attuazione al secondo comma dell’articolo 3 della nostra Carta costituzionale – sono stati nient’altro che terreno di devastazione e di rapina, da parte di coloro ai quali abbiamo permesso di governarci.
Su un solo punto l’ultimo ministro ha ragione: oggi più che mai l’istruzione è pane. È futuro, personale e collettivo. Quello che il ministro finge di non vedere è che l’espropriazione delle conoscenze fondamentali ai danni dei più è ferocemente programmata, perseguita dalle nostre classi dominanti. Quello che lui ed esse non vedono è che nel medio periodo tale riduzione a terra coloniale porta l’intera nostra collettività alla rovina: ma nel medio periodo, pensano, saremo tutti morti.
Pur tuttavia, in tale affamamento delle conoscenze di base, la rovina dell’industria editoriale non è estranea, ne è un’articolazione necessaria.
L’articolo di Riccardo De Gennaro, veloce ma informato, può aiutare a conoscere e ragionare.
Anche da questi temi passa il nostro pane quotidiano.
10 ottobre 2013
(Anniversario della nascita di Andrea Zanzotto)
A una giovane
1. “Non ho idea di cosa farò, non riesco ancora a trovare la mia passione, ma solo un grande buco nero e questo un pochino, sinceramente, mi spaventa”. La frase m’interpella, anzi, c’interpella, nel più inclusivo senso della parola “noi”, ciascuno con le nostre distinte responsabilità, con i nostri differenti poteri. Dice infatti il pedagogista Mario Alighiero Manacorda: nella relazione l’uomo acquista “oltre a capacità di vita impensabili nell’isolamento di un ipotetico stato di natura, anche tutto il bagaglio culturale che gli consente di inserirsi a pari titolo con gli altri nella società dei suoi simili: di essere insomma, per usare l’espressione di Gramsci, un contemporaneo della sua epoca” (Storia illustrata dell’educazione, Firenze, Giunti, 1992).
2. A sud, in un giorno qualsiasi, i morti si ammassano, gridano come gabbiani, per poco ancora moribondi avanti di affogare lerci di petrolio. Altri già bruciano. Sospinti dal silenzio di migliaia di strazi e salme, increspano per due giorni il brusio quotidiano, prima di ricomporsi.
3. Si tratta di conoscere le cause generali che hanno generato e protraggono l’attuale sistema di smarrimenti solitari, di miserie economiche e ideali: la nostra condizione materiale d’esistenza. Di chi è il vantaggio? di chi la sudditanza? “Quello che non sai di tua scienza / in realtà non lo sai. / Verifica il conto: / sei tu che lo paghi”, si ostina Bertold Brecht. Fili rossi, indizi solidi puoi di nuovo trovare, se ben cerchi nel profluvio del tritume, in testi come quelli di Luciano Gallino Finanzcapitalismo (Torino, Einaudi, 2011), La lotta di classe dopo la lotta di classe (Bari-Roma, Laterza, 2012) o in siti come www.sbilanciamoci.org. Altri possono meglio contribuire, perché il meglio si produce, non è un dato.
4. “Preferirei i rapporti diretti, le parole e il loro suono, il commento anche a braccio, lo scambio nel tempo limitato”, mi scrive il viandante di via Latina “magari per inviti umani […] il concreto scambio eguale, il sentire comune e l'occasione”. Conosco bene questa ragione antica e sempre viva, anzi oggi più che mai vera. Se tutti, se il 99% - per usare un’espressione odierna - siamo moltitudine, non è arbitrario partire da qui. Nel tempo della povertà, conta l’essenziale; la pochezza non può essere alibi all’inerzia. Che faccio la mattina quando mi alzo? A chi concedo e a chi rifiuto il saluto? I miei sì e i miei no sono distinti? In che rapporto sono la mia parola e la mia mano?
L’ho imparato dall’ultimo Fortini: la scrittura saggistica medesima trasmuta in pagina di diario.
5. Per questo ho resistito al primo impulso, dopo la lettura dell’articolo del “Sole 24 Ore” su Franco Fortini: “se i suoi discorsi sono ipotecati dal mito di un Futuro Rivoluzionario, la sua dote peculiare sta poi nell’affiancare al mito una sensibilità straordinaria per la complessità presente dell’individuo e delle sue espressioni estetiche, difese da ogni politicismo volgare. Certo, il suo destino Fortini se lo è in parte cercato: ostinandosi a tenere acrobaticamente insieme marxismo e alta cultura, mentre le loro sorti si separavano in modo irreparabile” (Matteo Marchesini, Versi alle ideologie, Domenica 29 settembre 2013). È insopportabile il sussiego sprezzante con cui – epurato Fortini del futuro – gli si concede la pace nel cimitero dei classici.
6. No, si deve fare altro. Ascoltare nella vicinanza il dolore muto perché diventi un grimaldello, una luce che apra la parola, la conoscenza che sfondi il “buco nero”, spalanchi il futuro. E dirlo a tutti, a tutti, a tutti, perché tutti prendano parola e l’ascoltino.
6 ottobre 2013
