Fughe


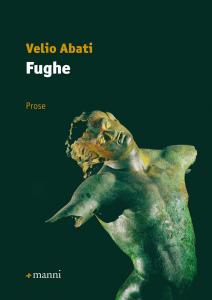
Una scrittura che nasce dall'allarme del presente, dando vita a racconti, figure, meditazioni.
Ogni fuga rinnova la sua energia contro le ottusità, le violenze, gli smarrimenti dell’oggi, in vista di un orizzonte di senso del sé e del mondo da riconquistare, sempre muovendo dalla concretezza dura dell'esistenza.
In primo piano sono le amicizie, l'impegno civile e intellettuale, l'insegnamento, l'amata letteratura, la comunicazione, il paesaggio, il lavoro manuale.
La forma dell’opera e lo stile invitano alla riflessione filosofica, morale, linguistica, estetica.
Mario Fraschetti ha curato la lettura di Yalla
racconto di un viaggio in Cisgiordania con Assopace Palestina, guidato da Luisa Morgantini. La voce è di Velio Abati
24 novembre 2023

Milano, Libreria popolare di via Tadino - venerdì 9 settembre 18,30. Presentazione di Fughe, Manni editore, interviene con l'autore Massimo Parizzi.


Libreria Palomar
Grosseto
31 maggio 2022
ore 18,30
Velio Abati e Massimo Parizzi
Fughe e Io
Doppia presentazione
Autori presentati da autori

Carlotta Pais
Biografia, comunicazione e atti linguistici
Una lettura di Fughe attraverso la filosofia del linguaggio
Le prose di Velio Abati parlano molto del loro autore, l’elemento biografico viene letto attraverso delle fughe, degli scorci, assi prospettici che costruiscono vie e attraversano epoche, vengono dal passato e ci parlano del presente. Incontriamo i nomi, anzi le Voci, (come si intitola la prima sezione del libro) dei protagonisti dei racconti, nomi di chi è, o è stato, parte dell’esperienza di vita dell’autore, a tutto tondo, dal punto di vista personale, famigliare, professionale e politico.
Quando si ha a che fare con la vita di un autore ci si chiede che ruolo abbia questa vita nel rapporto biografia-opera, problema non da poco, analizzato dalle varie correnti della critica letteraria. I formalisti russi, ad esempio, si chiedevano che cosa fosse pertinente di una biografia di un autore, scrittore o poeta, che cosa ne costituisse l’essenza, anche naturalmente per decidere che lettura fare dell’opera. Rispondevano che la biografia è importante perché viene plasmata dall’autore come una leggenda, diventando dunque fatto letterario[1]. Di fronte a fatti autobiografici come li troviamo in Fughe vediamo come la storia particolare ci riconduca sempre a qualcosa di altro, non certo forzatamente “universale” ma più vasto, qualcosa che si apre all’altro, agli altri, in un continuo moto dal passato al presente che diventa fatto letterario.
E proprio su una di queste traiettorie dal passato, una traiettoria antica che inizia nel 1901, vorrei condurre la mia riflessione. L’anno è quello della nascita di Lorenzo, il nonno di Velio, e Lorenzo è proprio il titolo del testo che più mi ha colpita in questo meccanismo narrativo, in cui la storia raccontata è essa stessa dichiarazione narratologica, per non dire dichiarazione di poetica, perché la scrittura di Velio ha sempre quel “qualcosa in più”, quel sapore in più che si attribuisce alla poesia, qui non certo per il verso – assente – o la rima, ma per lo studio sempre raffinatissimo della scelta lessicale che contraddistingue tutta la sua produzione.
La sua è una lingua che ogni tanto necessita una rilettura, e magari anche una ricerca sul vocabolario, per poi imparare qualche termine nuovo, regionale o letterario, ricercato e aulico o basso e popolare. Potrei elencare tantissime parole affascinanti riscoperte nelle pagine di Velio. Solo per rimanere all’interno della prosa scelta mi viene in mente ‘albagia’, ma mi sono stupita quando ho visto che ‘cacarello’ non solo è presente sul vocabolario Hoepli, ma indica anche in maniera puntuale e non generica il suo diretto referente.
Tra le altre prose Lorenzo mi ha colpita per la sua forma, diversa dalle altre, capace di toccare la riflessione filosofica, morale, linguistica ed estetica nell’arco di una decina di pagine. Mi parlava di Velio, delle sue origini, della sua lingua e della sua idea di opera d’arte. Ecco la “dichiarazione di poetica” di cui parlavo prima: un ragionamento estetico, che diventa meta-letterario nel momento in cui ci descrive la scrittura stessa. E non solo la scrittura, ma anche la lettura e i processi di apprendimento relativi, per approdare quasi alla forma di un saggio di filosofia della comunicazione.
Nel racconto infatti facciamo la conoscenza del nonno di Velio, Lorenzo appunto, contadino che impara a leggere e a scrivere da autodidatta, attraverso il canto, senza mai essere andato a scuola. Impara attraverso le romanze che circolavano nelle campagne dei primi anni del secolo scorso. Romanze che canta con voce fine, ariosa e limpida sui poggi intorno al podere. Questo imparare dal canto è l’ontogenesi che ricapitola la filogenesi, l’apprendimento individuale che diventa apprendimento e impossessamento prometeico di un’arte e ancor di più di uno strumento fondamentale: il comunicare. Emerge nella prosa la necessità della comunicazione, come fondamento vitale, ma nella scrittura di Velio ciò non è mai reso attraverso l’idillio. È problematizzato, reso indagine, studiato attraverso gli strumenti della filosofia del linguaggio e della comunicazione. Troviamo qui come in altre prose una questione ricorrente formulata nelle parole «a chi parlo?» «chi è che mi parla?». Questo richiamarsi al contesto lo troviamo in diversi punti di Fughe, come ad esempio in Diari dove le domande diventano: «in nome di chi parlo?» «a chi parlo?» «a che serve ciò che dico?».
Sono domande metodologiche, programmatiche in un certo senso, perché pongono le radici del comunicare alla base di quel parlare e farsi comprendere che costituisce le fondamenta di due temi cari all’autore: l’opera letteraria, propria e altrui, e l’insegnamento. Tanto l’opera scritta quanto l’insegnamento è esempio materiale e tangibile della comunicazione, e l’autore non smette di ricordarlo fin nel Congedo (p.121), dove afferma che «insegnare è un lavoro stupendo, che a volte, senza saperlo o volerlo, miracolosamente diventa reciproco».
Quel piccolo miracolo l’ho iniziato a scoprire anche io, nell’esatto momento in cui mi sono affacciata alla carriera d’insegnante, nell’istante in cui mi si chiedeva, per la prima volta, di portare dei contenuti da trasmettere ad altri. Mi sono resa conto che era quella la circostanza in cui più che mai ero desiderosa di imparare. Formarsi come docente è questione di costante studio e aggiornamento, ma all’inizio, quando si fa il primo passo, assomiglia molto di più ad un’improvvisazione teatrale. Da un momento all’altro si gioca il ruolo dell’autorevolezza, della credibilità e bisogna essere in grado in questo “giuoco delle parti” di essere all’altezza, di riuscire nel proprio intento e comunicare, appunto, qualcosa. È lì che almeno per me è iniziata la necessità di vivere ogni giorno in classe come uno scambio, di sentire che ogni mia lezione fosse una lezione anche per me, e forse in questo primo anno posso davvero affermare di aver prevalentemente ricevuto.
Sul filo rosso della comunicazione, che ovviamente non è l’unico rimando interno tra queste prose, torno al testo dal quale sono partita, Lorenzo, costellato di quelle domande disseminate nelle prose e che troviamo anche alla fine condensate nelle domande del lettore che ci portano a definire l’opera come dialogo, un dialogo tra queste voci, un dialogo che da dentro si rivolge al fuori, al nostro tempo, al nostro presente. Per questo è bene ribadire che queste fughe non sono mai “centri-fughe” ma se mai prospettive centripete, che ci riportano sempre all’hic et nunc del presente: «dobbiamo sottrarci all’illusione o all’incubo che la storia sia solo un grande cimitero» dice, «che il passato sia solo un ricordo: non è la vita dell’individuo la misura del tempo» e ci invita a riaccendere, attraverso la speranza del domani, le energie del passato «che credevamo ormai spente o che ignoravamo del tutto».
Ci sono tanti punti di Lorenzo in cui la comunicazione si fa più intima, quando lingua e sintassi si combinano in maniera tenerissima, con qualche tinta di nostalgia. Si entra piano piano nel testo, aiutati da una scrittura lieve, famigliare, sincera, che non smette mai di ricordarci però la sua concretezza “materica”:
«per un certo periodo di tempo ho creduto e affermato che ciò che è stato scritto ha la stessa realtà di una sedia, volendo indicare una sua rocciosa realtà indifferente all’autore e alle prevaricazioni del lettore. Sbagliavo, naturalmente, sull’opera letteraria e prima di tutto sulla sedia. […] Soffrivo il sogghigno di quella elegante riduzione al nulla di qualsiasi testo, sentivo in quella disinvolta vaporizzazione una ferita sanguinosa sul mio corpo. […] Così, per reazione e per debolezza di ira e studio mi sono aggrappato al pane duro e alla terra conosciuti accanto a mio padre, ascoltati nella voce di nonno. Per il troppo d’identificazione che allora non scorgevo, quasi a scartare da uno sguardo indegno, scagliavo quella sedia fuori della storia, come fosse una pietra o una pianta. […] Il rigetto sano della derealizzazione intellettualistica m’impediva di vedere che la materialità non obbliga all’immobilità».[2]
E poi ancora:
«Proprio perché parlare è per sua essenza atto sociale in cui respira, anche se non intera, ogni lato della vita, esso è esperienza di vita, con la magmaticità intransitiva del soggettivo e del corporeo, del terragno che nessuna codificazione grammaticale, nessuna formalizzazione algoritmica, nessuna moltiplicazione enunciativa potrà interamente illimpidire.»[3]
Nella prosa in questione l’aspetto più interessante è a mio avviso il trasformarsi e l’alternarsi di questo lessico intimo del contadino a quello tecnico e rigoroso dello studioso che approda alla filosofia del linguaggio. L’atto linguistico, che viene menzionato tante volte e che si pone al centro del racconto nella sua componente più tecnica, porta con sé la memoria della pragmatica, quindi notiamo che l’aspetto che qui ci si palesa non è mai solo speculativo ma anche concreto: la nozione di atto linguistico richiama l’idea che parlare è agire, esercitare un’attività, ed è cruciale nel dibattito sugli usi e sulle funzioni del linguaggio. L’introduzione del termine ‘atto linguistico’ è legata senz’altro alla filosofia analitica anglosassone ed in particolare alla filosofia del linguaggio ordinario, ossia del linguaggio d’uso comune, sviluppatasi a partire dagli anni Trenta nelle università di Cambridge e di Oxford grazie ai lavori di Ludwig Wittgenstein, poi di Ryle e di Austin.
Il primo concetto innovativo introdotto da Austin era stato quello di ‘enunciato performativo’, (dall’inglese to perform ovvero compiere un’azione) vale a dire quegli enunciati che hanno il potere di produrre degli stati di cose altrimenti non sussistenti: “vi dichiaro marito e moglie” pronunciato da un sacerdote o da un ufficiale civile, “con i poteri conferitemi la dichiaro dottore” pronunciato dal presidente di una commissione di laurea.
Austin aveva poi ampliato la sua teoria sostenendo che quando parliamo compiamo una serie di atti: proferiamo suoni, li utilizziamo con un certo significato, li impieghiamo per conseguire determinati effetti (es. promettere, avvertire ecc.). Ecco perché gli atti linguistici si situano sulla linea di confine tra il significare e l’operare, ossia tra quanto è determinato da regole linguistiche e quanto dalla situazione di interazione in cui l’enunciato viene prodotto, e dunque come si tratti di fenomeni al contempo semantici e pragmatici.
L’atto linguistico implicato da Abati è dunque un’unità essenzialmente comunicativa in cui rivestono un ruolo di primo piano la relazione tra parlante e ascoltatore, ossia i soggetti concreti coinvolti nello scambio comunicativo e il contesto, linguistico e non, intessuto di convenzioni e relazioni sociali[4].
Per questo l’autore quando ricorre alla nozione tecnica di “atto linguistico”, aggiunge: «sporco di terra, sangue, rapporti sociali» ritornando ad una verità sempre calata nella storia.
Insomma, alla fine di questa pindarica trattazione, rimane la sensazione di voler ancora parlare di tanto e di aver tralasciato troppo. È curioso come, all’inizio, l’individuazione di un testo che potesse essere il più centrato, che compendiasse tutto ciò che avevo intenzione di dire, mi abbia poi aperto a tutto il resto, notando la complementarità delle prose, i rimandi che rendono l’opera unitaria, bella e coesa proprio per la sua coerenza che oltretutto non è solo interna al libro, ma si rispecchia in tutta la produzione. In conclusione, dunque, ciò che vorrei aver trasmesso è una lettura dei testi, seppur frammentati, attraverso la centralità del problema comunicativo e riflessivo, delle domande che dobbiamo porci per stare con gli altri, per insegnare, per non chiuderci nelle nostre solitudini.
Negli scritti di Velio la componente biografica porta sempre a interrogarci su qualcosa che allarga lo sguardo che ci proietta diversi punti di vista o punti di fuga, prospettive che non rispondono ma problematizzano e ci lasciano con tanti punti interrogativi, in parte gli stessi che abbiamo ripercorso insieme, e in parte nuovi.
[1] Maria Candida Ghidini, Quando il romanzo si disintegra davanti alla vita, in «L’Indice dei libri del mese», settembre 2021, anno XXXVIII, n. 9, p.5.
[2] Velio Abati, Fughe, S. Cesario di Lecce, Manni, 2020, p. 63, corsivo mio.
[3] Ivi, p. 65.
[4] Francesca Bertozzi Iacoboni, Atti linguistici e comunicazione. La tradizione analitica, in Stefano Gensini (a cura di), Filosofie della comunicazione, Roma, Carocci 2012, pp. 103-105.
19 ottobre 2021
Lorenzo Pallini
Caro Velio,
[…] rivedendo i tuoi cortometraggi questa sera, sono tornato a riflettere sui solchi scavati dal tempo, sul fatto che si proceda solo apparentemente vicini e forse ci si accorga troppo tardi, con stupore reciproco, di essersi molto allontanati. Mi ha molto colpito la scelta che avete operato su Livia...quella alternanza di voci e pensieri, l'incontro tra generazioni diverse che si sfiorano, che procedono una accanto all'altra, senza avvedersene, se non per brevi momenti. Ci ho ritrovato molto di te, dello spirito che anima Fughe, fatto di dialoghi spesso muti che attraversano il tempo e lo spazio "a correnti alternate". Di tutti i rapporti che tornano ciclicamente come onde a investire il tuo essere, relazioni intorno alle quali non cessi di interrogarti, sempre con grande sensibilità, riuscendo a collegare particolari minimi, brevi attimi, sensazioni fuggevoli, a significati più profondi, duraturi, universali.
Anche Virtù mi ha parlato direttamente e ho trovato molto forte il richiamo a questioni che hanno una grande rilevanza e urgenza nelle nostre vite, accostate a immagini di natura che scorre (alcune così familiari da commuovermi) semplici e complesse allo stesso tempo. ENOS LASES IUVATE, l'iscrizione incisa nella terra sul vostro focolare domestico, invocazione ritrovata in Livia, ma che per quanto mi riguarda continua a risuonare potente anche in Virtù, venata però da una sensazione di irrimediabile perdita di speranza, forse "fuori tempo massimo".
8 ottobre 2021
Due Fughe in cortometraggio. Con Velio Abati e Lorenzo Scribani. Musiche Francesco Salvador. Montaggio e regia Lorenzo Scribani.
Ripropongo qui la recensione apparsa sulla rivista "L'ospite ingrato" on line , v.a 30 marzo 2021
Maria Vittoria De Filippis
Velio Abati, Fughe
L’ultima opera di Abati, Fughe, si divide in due sezioni: Voci e Discanto. Si tratta di prose composte in vari anni, in un arco di tempo in parte coincidente con la scrittura del romanzo Domani. Un libro, va detto subito, ricco di umanità ferita, ma non per questo priva di speranze. Il titolo, Fughe, potrebbe sorprendere, dal momento che Abati non rifugge certo dalle proprie responsabilità. Si possono, allora, azzardare due interpretazioni per tentare di spiegarlo. La prima rinvia ai ritratti inseriti in Voci, in cui persone realmente esistite si trasformano in personaggi, emblemi, controfigure, diventando appunto entità sfuggenti o quasi scomparse: «quelli che per un attimo avevamo pensato di raggiungere, spalla a spalla, erano d’un tratto sbalzati via, per sempre imprendibili» (p. 15). La seconda interpretazione, invece, si riallaccia al tema del passato, già affrontato nel romanzo, e in particolare in questa risposta data da Abati a un suo lettore:
"Conclusivamente mi ringrazi di aver dato vita, dici, a un passato di cui sentirsi orgogliosi. Come ho ampiamente affermato, non so pronunciarmi sul valore di quel passato, ossia di Domani, ma certo sono convinto che il mondo storico a cui esso rimanda non è affatto passato. Un’assai ampia dimensione del dominio e dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo di quel mondo vive e fruttifica fra noi. Un’altra vasta strutturazione storica, specifica questa della società italiana, è più che mai attiva nelle sofferenze odierne, nelle sue violente coartazioni. Un insieme di modi del vivere quotidiano, dei rapporti tra le persone travolti dall’industrializzazione novecentesca ritornano oggi non come schegge archeologiche, ma come potenzialità soppresse, enzimi vitali; ce lo dicono menti attente, giovani intraprendenti e non rassegnati. C’è infine tutta la dimensione del vivere con le stagioni, con le piante, con gli animali, che il prometeismo industriale supponeva d’aver cancellato e che invece torna nell’incubo delle nostre terre franose, dei disgeli oceanici. Voglio dire che dobbiamo sottrarci all’illusione o all’incubo che la storia sia solo un grande cimitero, che il passato sia solo un ricordo: non è la vita dell’individuo la misura del tempo, esattamente come la società umana non è una somma d’individui, per quanto il cinismo sprezzante del neoliberismo ce lo inculchi da quarant’anni. Si deve dunque sapere che il domani sperato nella nostra mente riaccende sempre dal passato energie che credevamo ormai spente o che ignoravamo del tutto.
Questa sorgente di forza è nostra".[1]
Sebbene, come dicevo, sia un libro di prose, è un testo davvero ricco di poesia, soprattutto nella prima parte, che ospita descrizioni sia di luoghi naturali, sia di persone conosciute a fondo o soltanto incontrate (Ruth, Gabrio, Raffaela). Parallelamente, viene sin da subito tracciata una certa filosofia della Storia: si allude ai tempi passati; si raccontano entusiasmi, sconfitte, separazioni, scissioni politiche; si scrive del «fervore dei giorni» e dell’«ansia di costruire il mondo» (Fantón, p. 9). In C’era una volta una piccola città, poi, si parla dell’oggi attraverso un testo surreale, fantastico, ambientato in una città abitata dagli Alti e dai Bassi.
E proprio al nostro presente è dedicata la seconda parte. In Discanto, infatti, emergono più chiaramente gli interessi, anzi le passioni di Velio Abati. La principale, che racchiude in sé tutte le altre, è la scuola: l’insegnamento, per lui, è un momento di confronto e di dialogo. Insegnare significa condividere dei saperi, ma anche trasmettere fiducia in un domani di cui, tuttavia, non è ancora dato scorgere i contorni, in modo che – come recita L’Internazionale di Fortini – «nelle scuole» non venga più insegnata «la morale di chi comanda»: «dov’era il no faremo il sì». Non stupisce, quindi, che l’autore abbia affidato la presentazione di Fughe ad alcuni suoi ex studenti. In tale occasione, svoltasi venerdì 27 novembre 2020 nell’ambito dei “Colloqui del Tonale”, egli ha scritto:
"Ci è sembrato utile affidare la presentazione a un gruppo di giovani, miei ex allievi di anni diversi, che liberamente leggeranno, commenteranno, dialogheranno con l’autore e con chi sarà in linea su una piattaforma messa a disposizione dalla casa editrice. Non ci sfugge, anzi è voluto il significato anche simbolico, augurante dell’occasione."[2]
Un modo per dire addio all’insegnamento, proseguendo la propria funzione pedagogica al di fuori dalle aule scolastiche.
Per precisare meglio i vari atteggiamenti dell’autore nei confronti della politica («Fuggita la politica come professione, coltivavo la politicità della vita comune», Attilio, p. 23), è utile tornare a soffermarci sulla prima parte del libro (oltre che sulla biografia di Abati). Lasciato alle spalle l’attivismo politico giovanile, nell’oggi l’engagement si è trasformato in impegno civile, culturale ed educativo, quindi in impegno politico in un senso più ampio. Particolarmente importante, perciò, è l’attenzione sempre rivolta ai propri interlocutori, si tratti di allievi oppure di lettori. Ecco, allora, cosa scrive Velio Abati a proposito dell’atto di lettura e della qualità dell’ascolto (Lorenzo, pp. 67-68):
"Come e più di chi ascolta in una conversazione, il lettore non è lo specchio del testo. Leggere non è premere il tasto di una registrazione: è una collaborazione, il suo frutto è il significato di volta in volta assunto dal testo […]. L’ascolto in una conversazione, o in quei veri e propri comizi che nell’odierna comunicazione sociale si mascherano da conversazioni, è facile solo in apparenza. Le difficoltà provengono dalla mancata chiarezza – per ignoranza, inganno o autoinganno – nella risposta alle due fondamentali domande preliminari: chi parla? chi ascolta? L’importanza negativa della non consapevolezza di sé nella collaborazione al senso non va sottovalutata, proprio per la rilevanza del sottaciuto e dell’indicibile nella produzione di significato. Il suo peso si rivela meglio se consideriamo l’azione dell’imbonimento demagogico".
E in un altro passo (Marusca, p. 105):
"I libri sono suolo fertile, gli organismi vi stratificano, nei decenni, nei millenni. Chi legge incontra, diceva un mio maestro con qualche enfasi, i chiodi di chi in precedenza ha scalato quella pagina. Ho detto «libri» con automatismo di casta, ma è l’opera dell’uomo, perché è lui che sempre vive in relazione e sempre la trasforma".
Velio non mostra rimpianti o nostalgia verso l’impegno giovanile, ma nemmeno rinnega la forza e gli entusiasmi di quel tempo, rievocandone episodi e momenti salienti. Le sue parole testimoniano della voglia di cambiare il mondo e della lotta per realizzazione questa aspirazione; allo stesso tempo, però, tracciano lucidamente il progressivo venir meno di una simile aspettativa. Non c’è astio o rancore verso le persone con le quali si è interrotto il percorso: il tono della narrazione è oggettivo. Eppure, la cura che oggi l’insegnante mette nel «formare alla speranza» (La cartella, p. 82), nel dare e trasferire fiducia, è la dimostrazione della sua persistente fede nella possibilità – nonostante tutto – di un futuro migliore (p.83):
"È in tale immobilità che germina la disperazione. Non c’è, in se stessi, nell’hic et nunc possibilità di lume. Questo è l’acheronte per chi si trovi oggi ad apprendere e a insegnare. Perché la speranza, se è una necessità primaria, non vive senza alimento. Il sapere di cui il padre parla alla figlia, nelle circostanze date, viene solo da fuori; meglio: dai tempi lunghi".
E ancora (p. 87):
"Sarà per la fiducia nella vocazione dell’uomo al bene, di cui parlava Brecht, o semplicemente per il necesse della speranza, che mi capita di ricordare l’insegnamento del saggio taoista a chi gli chiedeva come inventare l’oro: oggi comprendo che la cosa più difficile, ma quella decisiva, non è la meta, bensì la direzione. Oggi comprendo la conseguenza suprema dell’umana condizione: nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. So e scopro ad ogni passo e insegno e comprovo che il futuro è la nostra realtà, è la verità del nostro presente, il senso del nostro passato; che quel futuro è intimamente, appassionatamente di parte. Non qualunque parte. Solo quella degli sconfitti, solo la parte di noi debole e oppressa detiene la ragione e la forza del futuro comune. Più il tempo della mia vita scema, più insegno la passione, la fatica e la forza dei tempi lunghi".
Non si può parlare di questo libro, e più in generale dell’intera opera di Abati (dal romanzo fino ai versi più recenti), senza tornare sulla qualità della sua scrittura, evidente anzitutto nelle descrizioni paesaggistiche (Gabrio, p. 39; Attilio, p. 20):
"Verso sud est la sequenza delle colline si vela gradatamente fino al culmine, lontano, dell’Amiata. Poco più in alto, il sole si è appena levato. Senti intenso il maggio negli orti, esplode sui fiori di sangue del croco. L’assalto definitivo che lo squassa interminabile invade il terrazzo attonito, urla nell’aria vuota del piazzale. Controllo. La porta era stata chiusa.
Sulle panche, nel riparo dell’ombra breve del podere, arriva tenue la risacca del maestrale che più avanti, giungendo dalle nostre spalle, agita le foglie del pioppo e le cime spente degli olivi. Si attende qualche refrigerio dalle folate intermittenti, che soffiano sullo stridio assiduo delle cicale. I due amici si ritrovano a intervalli. Mangiano un gelato. Uno mi parla del Canada, della maggiore possibilità di lavoro, con parole che mi spingono lontano, oltre l’angoscia che ha inghiottito i giorni dopo gli studi".
Tale abilità emerge pure nei ritratti contenuti in Voci, dove l’autore può anche scegliere di giustapporre momenti diversi, episodi distanti nello spazio e nel tempo, garantendone l’unità proprio grazie al riferimento a un’unica persona. Tra i molti esempi che si potrebbero fare, ne scelgo uno particolarmente significativo per l’importanza della figura che vi è ricordata (Ruth, pp. 28-29):
"Fu così che conobbi Ruth.
Arrivando l’avevamo trovata che terminava di bagnare il tratto di pineta intorno casa, spostando un lungo tubo di gomma avvitato alla cannella. Ci era venuta incontro energica, ma affaticata, con un gran cappello di paglia. Aveva voluto darci dei libri scegliendoli dalle scaffalature. Poi eravamo andati con la macchina in un piccolo cimitero sperso nel verde. Il loculo era ancora senza pietra, con il nome inciso con mano incerta direttamente sul cemento grigio quand’era ancora fresco.
Avevamo ascoltato in silenzio dalla sua voce sobria gli strazi, la notizia fugace della terribile aggressione che anche il proprio fisico aveva subito, il rimpianto dei bagni di mare, le gioie delle amiche, le preoccupazioni e le fatiche della casa: il pino spezzato dal vento, la pulizia dei rami caduti, la minaccia del fuoco. Nell’indugio della partenza ci raccomandava la prudenza della guida per il non breve viaggio di ritorno, giù, lungo la strada parallela al mare. Poi d’improvviso ci disse d’attendere. La vedemmo ritornare con qualche pera colto dall’albero, recandocela in un piccolo cestino di vimini, ovale. «Per il viaggio si ha sempre bisogno di qualcosa».
Avevamo chiuso il portoncino e poi la porta interna con l’eco interiore d’affetto e trepidazione di tutte le volte che avevamo attraversato quella soglia. Davanti a noi la casa, che ricordavamo di nuda bellezza. Ora nelle assenze delle pareti e dei mobili, nelle scatole sui pavimenti, era assalita dallo strazio. Tenue l’odore acre di farmacia".
Per questa capacità di scrittura e di comunicazione, oltre che per le dense riflessioni sulla questione della temporalità (centrali, d’altronde, in tutto Abati), Fughe è senza dubbio un libro da leggere attentamente. Un libro da assaporare e meditare.
Note
[1] V. Abati, Sulle domande del lettore, pp. 164-165.
[2] G. Baneschi, F. Cipriani, M. Covitto, A. Franchi, B. Rosi, L. Scribani, S. Starnai, I. Verdi, Velio Abati, «Fughe», Colloqui del Tonale, 27 novembre 2020.
Celso Rosati
Affinamento dei sensi e sudore dell’intelletto nel tempo digitale
L’invito di Velio Abati, in apertura della sua opera Fughe, alla riflessione filosofica, può essere colto dalla prospettiva in cui lo stesso autore si pone. Quella di un orizzonte di senso del sé e del mondo. Sia la narrazione che l’argomentazione di Abati si immergono, nei momenti diversi di ogni fuga, nella ricerca di un’essenza che sappia riportare in primo piano una realtà vera, rischiarata dagli smarrimenti dell’oggi. Scrive Abati: “A che serve ciò che dico? Di fronte ai miei alunni so che, in forza del nome per cui parlo, posso tentare di svegliare in chi ascolta qualche domanda di senso su di sé e sul mondo che ci circonda” (Diari, 123).
Il senso come punto di fuga proietta l’opera su un piano filosofico. Il desiderio di andare oltre l’apparenza, non nell’attesa immobile dello svelamento della verità ma per la possibilità di crearne le condizioni, implica l’elemento del tempo.
Ed è proprio il continuo andare avanti e indietro nella linea del tempo storico, del nostro tempo, che porta Abati a non eludere la necessità della domanda. Anzi, diventa qui necessario evitare la rimozione ed essere sempre più consapevoli dell’urgenza di cercare insieme un orizzonte di senso. Scrive l’autore: “La posizione di chi legge rispetto a chi ascolta è simmetrica a chi scrive. La maggiore figuralità cui è costretto lo scrivente […] costringe a sua volta il lettore a un grado decisamente più alto di collaborazione nella produzione del senso” (Lorenzo, 66).
Nell’intera struttura del testo, così come nello scricchiolio sintattico, si sentono le diverse velocità del tempo. Dalla più dinamica a quella quasi ferma sul presente. L’autore, appunto, per parlare del presente si immagina scrittore del futuro, crea artificialmente una distanza per indicare il ritmo della raccolta. “Il presente occupa compattamente l’esperienza del tempo” sostiene. E ancora: “La saturazione del presente, più ancora che il nascondimento del passato, è la forclusione del futuro. Per questo il presente è diventato il tempo dell’ossessione” (Non ho tempo, 144).
Il non avere tempo dà spazio alla negatività, alla perdita del tempo incorporato, per dirla con Marcel Proust, di una memoria che coincide con la vita. Il tempo ridotto a pura perdita di tempo apre all’istantaneità. Tutto ciò che esiste deve essere sempre disponibile e presente. La vita senza narrazione porta con sé la possibilità di una vita senza senso, senza una meta.
Abati, tuttavia, non tenta di nascondere il vero problema che si trova nell’imposizione di un modello neoliberistico, dal quale emerge la concezione di una temporalità priva di una durata e, quindi, di una struttura di senso. È in questa cornice neoliberistica che la nostra società senza pensiero ci ruba l’esperienza mercificandola. Leggiamo in Fughe: “Il capitalismo, diceva un grande borghese che conosceva bene il proprio mondo, non si preoccupa del lungo periodo, perché nel medio saremo tutti morti. Il futuro, dunque, è nelle nostre mani […] È tempo d’invertire la rotta” (Se io oggi sono qui a parlarvi, 157).
Essere consapevoli dell’accelerazione del tempo empirico è per l’autore di fondamentale importanza, anche perché qui si gioca ciò che più caratterizza la differenza generazionale.
Già Shakespeare faceva dire ad Amleto che “il tempo è fuori dai cardini” (atto I, scena V).
Il tempo va fuori tempo perché non ha un ritmo che gli dà ordine. Osserva Abati che l’accelerazione nel ritmo della vita fa superare le barriere spaziali mentre “gli orizzonti temporali si accorciano al punto in cui il presente è tutto ciò che c’è” (Non ho tempo, 145).
Il rapido consumo delle cose nella nostra società accelera il tempo e l’accelerazione è una possibile spiegazione della scomparsa del senso, ma non è l’unica. Anche il rallentamento se prodotto dalla frammentazione temporale produce gli stessi effetti. Nel romanzo L’impiego del tempo lo scrittore Michel Butor, per esempio, sembra far derivare la crisi della narrazione proprio dal non saper distinguere gli eventi, dall’incapacità di selezionare, perdendo così il ritmo che ci permette di dare continuità al tempo. Detto altrimenti, la narrazione che perde il ritmo entra in una crisi temporale tanto da non permettere più uno scambio armonico di lentezza e accelerazione, che sono due fenomeni dello stesso processo.
Da questa prospettiva sembra, dunque, che sia proprio la discontinuità temporale a generare indifferentemente velocità o rallentamento del ritmo narrativo.
Vale la pena notare, infatti, che la lentezza derivante da un processo temporale frammentato, caotico e senza una meta non è la stessa che segue il tempo continuo e orientato, e per questo altrettanto responsabile quanto l’accelerazione, della mancanza di senso.
Osserva Zygmunt Bauman: “nella società dei consumi […] il tempo non è né ciclico né lineare […] esso è […] ‘puntillistico’, ossia frammentato in una moltitudine di particelle separate, ciascuna ridotta a un punto” (Vite di corsa, il Mulino, 2009, p. 56).
Il mondo digitale ha atomizzato il tempo, rotto l’equilibrio di lentezza e accelerazione e, di conseguenza, distrutto il senso. Privilegiare la lentezza rispetto alla velocità non elimina il rischio di un vuoto di senso se prima non sono stati ricostruiti una meta e un ordine temporale.
La concezione di una vita più lenta e di un rapporto armonico con il proprio tempo, attraverso pratiche del benessere propagandate dalla nostra società dei consumi (dallo sport, al pilates, allo slow food, alle pratiche tantriche, ecc.), non sono un antidoto e tantomeno una resistenza alla vita veloce e frenetica di oggi. La lentezza non si oppone alla velocità ma fa parte dello stesso processo.
Si potrebbe dire, a buon diritto, che tali pratiche non sono in grado di interrompere la logica del profitto e della crescita infinita e, quindi, anche l’esperienza di modificare la percezione del tempo entro una cornice neoliberistica non può essere altro che un fallimento.
Del resto la società dei consumi corrisponde al capitalismo neoliberistico ed è opinione diffusa che il capitalista consideri la massimizzazione del profitto una vocazione religiosa. E se, come sappiamo, il tempo è denaro, diventa quasi ovvia la considerazione che l’accelerazione del tempo aumenti anche il profitto.
Nel saggio Accelerazione e alienazione Hartmut Rosa, riflettendo sul fenomeno dell’accelerazione, proprio per la sua capacità di comprimere il tempo creando così disordine e caos, la considera proprio come un effetto della competizione capitalistica. E se poniamo l’attenzione anche sulle nuove forme di accumulazione di ricchezza che il capitalismo viene ad assumere nel mondo digitale, allora diventa evidente che in questa realtà a produrre valore economico è, soprattutto, il commercio dell’informazione e l’accumulazione di esperienze opportunamente trasformate in dati. Sul piano umano, infatti, l’accelerazione del tempo (causa dell’alienazione per Hartmut Rosa) sembra manifestarsi in una vera e propria filosofia vitalistica incentrata nell’accumulo sempre più compulsivo di esperienze che, nella società tecno-consumistica, corrispondono al capitale per le aziende.
Questo per dire che nuove logiche di accumulazione accompagnano oggi la realtà del capitalismo nella sua forma neoliberistica e per Abati tale questione è cruciale, tanto che è possibile rintracciare nel suo libro interessanti analisi sugli effetti davvero preoccupanti che il prevalere di questo modello ha sulla nostra società.
Ci si potrebbe chiedere allora:
- Come può l’uomo stare con sé stesso e nel sapere del tempo?
- Qual è il sé che oggi deve rimanere?
La saturazione del presente è anche l’ossessione di un futuro percepito sempre come passato infuturato, la constatazione di non essere più come eravamo, di essere altro. Ma l’autore sembra chiaro su questo punto: “il passato [non è] solo un ricordo […] il domani […] riaccende sempre dal passato energie che credevamo ormai spente o che ignoravamo de tutto" (Sulle domande del lettore, 165).
A me pare che da questa prospettiva Fughe presenti, innanzitutto, l’urgenza di una produzione di senso capace di coltivare la fatica del concetto nelle cose da fare. Fatica consapevole che rimane nel senso; non quella istintuale, ripetitiva e naturale.
L’uomo che deve rimanere è colui che sa rimettere il tempo nei suoi cardini.
La saturazione del presente sembra trovare la sua radice in una narrazione detemporalizzata e, quindi, viene sottolineato che “il presente è diventato il tempo dell’ossessione” (Non ho tempo, 144).
Conseguenza dello sviluppo tecnologico è una nuova percezione del tempo e dello spazio. Lo spazio fisico che conserva il passato viene schiacciato dal presente, dove tutto è sempre disponibile e senza alcun bisogno di futuro.
In questo contesto ogni forma di profondità viene meno e la stessa narrazione del passato diventa un processo molto faticoso, non più adeguato alla velocità del presente. Conta solo l’attualità, là dove solamente può realizzarsi il vissuto emozionale.
Con la nuda esperienza senza l’illuminazione del pensiero si rischia di avvalorare ciò che è tipico della rivoluzione digitale ovvero, estendere le facoltà sensibili sollecitando tutti i sensi del corpo. La stessa parola digitale, infatti, rimanda al dito, alla mano e non all’intelletto. Per dirla con Heidegger alla mano che agisce non alla mano che pensa.
Se il senso nel pre-digitale va cercato o costruito, oggi è presente in modo permanente e si manifesta attraverso l’immagine, la condivisione, la registrazione ecc.. In breve: non serve più l’esperienza del passato, oggi, parafrasando Manuel Castells, abbiamo a che fare con il tempo senza tempo, cioè con quell’esperienza che tende a comprimere il tempo rendendo confusa la sua successione cronologica.
Opportunamente Abati nota che “La nostra è divenuta una società senza pensiero” (Esercizi cinesi, 131). A me pare proprio questo il punto che ci permette di compiere il passaggio dall’esperienza a cui si rifà la rivoluzione digitale, all’esperienza che non può fare a meno del concetto. L’affinamento dei sensi passa attraverso il sudore dell’intelletto e viceversa; dell’esperienza “vive la fatica del concetto, non della spiegazione astratta” (La cartella, 83). E ancora: “Bisogna sudare la fatica del concetto. Per farlo, in questo tempo della miseria, occorre la sapienza cinese di partire dalla quotidiana ginnastica della mente, delle emozioni, della morale, del linguaggio, perché i nostri gesti siano meni distanti possibile dalle nostre parole” (Esercizi cinesi, 132).
Il libro di Abati condensa la riflessione sollecitata da tali problematiche a partire dall’uomo, dal suo fare e dalle sue facoltà sempre più esposte all’attacco dell’ideologia dominante.
Già nel pensiero filosofico antico e soprattutto con Aristotele sentire il mondo era un modo per interpretarlo: il tatto esiste per la nostra sopravvivenza, la vista ci permette di cogliere l’essenza, l’udito apre all’ascolto di sé e dell’altro.
In Fughe la pre-occupazione per la diffusa delegittimazione del silenzio, dell’ascolto, della lentezza si lega al problema della frammentazione del tempo e della sua durata.
A questo proposito quello che ci resta da fare è di affinare il silenzio che ci rende disponibile all’ascolto ma anche alla scelta delle parole, al ponderato colloquio poiché “le parole sono medium dei rapporti umani” (Parole, 147). E ancora: “Affinare lo sguardo e la voce, far maturare il silenzio: scusate se sono stato lungo, scrive il filosofo, ma non avevo tempo” (Ai sei lettori, anzi lettrici, 116).
Questa osservazione di Abati, che mette in bocca al filosofo le scuse per non avere tempo, presenta aspetti interessanti su cui vale la pena soffermarsi per porsi almeno una domanda.
- Perché il filosofo si scusa?
Forse qui Martin Heidegger ci può aiutare a ritrovare un punto prospettico. In Essere e Tempo il filosofo tedesco lega il tempo al sé intrecciandolo con la storia che, orientandolo, lo protegge dalla frammentazione. Proprio perché il tempo è in sé (durata), l’esistenza autentica non si perde e per questo ha sempre tempo. Scrive Heidegger: «Come l’esistere inautentico perde costantemente il suo tempo e quindi non ne ’ha’ mai, così il carattere distintivo della temporalità dell’esistenza autentica è quello di non perdere mai tempo, nella decisione, e quindi di ‘avere sempre tempo’» (Essere e Tempo, Longanesi, 2005, p. 481). La mancanza di tempo, che per Heidegger è un tempo che si svuota di senso, si ha sul piano dell’esistenza inautentica non su quella autentica che ha sempre tempo. Sembra, dunque, che la ricerca di senso possa rovesciare il non avere tempo in un avere sempre tempo.
Questo ragionamento potrebbe essere utile anche per comprendere meglio la strategia del filosofo chiamato in causa dallo stesso Abati che si scusa, in realtà, provocatoriamente, per la sua lungaggine nell’avere sempre tempo per la ricerca di senso.
Traspare nei diversi piani che si intrecciano in Fughe - dalla politica, alla società, all’educazione - la pre-occupazione per il “franamento della soggettività collettiva” che, in conclusione si riassume nella “necessità di forme politiche capaci di una visione complessiva e alternativa e di una corrispondente capacità di agire in modo coordinato all’altezza del disordine mondiale organizzato del capitale” (Virtù, 170). Nonostante la consapevolezza dell’attuale deserto politico, risuona, però, altrettanto forte la speranza (o la passione religiosa direbbe Spinoza) di smascherare nuovamente la storicità del capitalismo e delle sue nuove forme come inizio e condizione di apertura a sempre rinnovate vie di fuga.
29 marzo 2021

Unione degli universitari – DAS Pisa: FUGHE. Racconti e riflessioni su alcuni aspetti della contemporaneità. Incontro con l’autore. Martedì 16 marzo 2021.
Per vedere il filmato dell'incontro, clicca sul link qui sotto.
Nicoletta Franci
Le Parole per ‘ritrovarsi’
“Fughe”: partirei proprio da qui.
Il titolo reca con sé l’idea di movimento e comunque rimanda a partenze o ritorni.
Sembra privilegiato il percorso dei ritorni, in questo caso un viaggio a ritroso nella memoria e per noi lettori un po’ attempatelli – così come il nostro autore, ci perdoni - questa lettura ha il gusto dolce del ricordo, quello più amaro del rimpianto e per ultimo quello del conforto del vago rimestare nel fluire della nostra esistenza.
Tutte componenti essenziali del nostro stare al mondo.
Mi pare, tuttavia, che queste “fughe” all’indietro non abbiano solo la valenza del resoconto, del compiacimento e del recupero degli affetti consolatori, ma spingano, invece, in avanti, traccino una via da seguire all’autore e, al contempo, ai lettori.
Il recupero della propria storia si dimostra la bussola necessaria per tracciare, indicare a ciascuno un possibile futuro più rispondente e calzante, o meglio più coerente, con il proprio vissuto, in un’epoca di grande smarrimento e che sembra appartenere più ad altri che a noi.
Significa redarguire proprio quelli come noi affinché non perdano di vista se stessi, ammonirli di non ammainare la bandiera, di non cedere all’oltraggio vergognoso e ripetuto di seguire pedissequamente i tempi, questi tempi bui o al più indecifrabili, ovviamente con la consapevolezza che non basta alimentarsi solo di passato in nome di un presente e ancor più di un futuro che, per forza di cose, non potrà mai appartenerci del tutto, né ideologicamente tanto meno materialmente.
La questione è annosa, senza dubbio.
Le pressanti parole dell’oggi sono assai lontane dal variegato ventaglio a disposizione dell’autore: adattamento, flessibilità, apertura e incoraggiamento al nuovo… Non decliniamo, non ci è permesso. Certo bisogna tenerle a mente e, fin dove ci è possibile, farle diventare necessaria pratica quotidiana, ma non si può abdicare al vecchio per un nuovo che ancora non si intravede (il concetto non è mio).
Trovo, invece, nelle parole del nostro autore una forza dirompente, un’energia rinnovata e per niente anacronistica, perché in esse si cela una concretezza che ha plasmato non solo il mondo che fu dei padri ma anche il nostro e ce lo dimostra il fatto che è proprio quel mondo che riaffiora con forza ancora oggi, tra le pieghe di un tessuto sociale sfaldato, che si ciba di valori fittizi, e che va continuamente alla ricerca di solidità, proprio quell’antica solidità che sembra perduta.
In queste pagine trovo una ricchezza inaspettata. Molti di noi si riconoscono nei luoghi, nei tipi, nelle atmosfere ricreate con sapiente meticolosità e si rivive proprio la forza dei padri e il loro lascito, la caparbietà delle loro lotte rinvigorite dalle nostre, il sentirsi parte viva di una comunità che vedeva con chiarezza “un orizzonte di senso”.
Ecco perché queste “fughe”, come detto apparentemente volte all’indietro, ci sollecitano invece a guardare oltre, a sollevare lo sguardo su mondi non certo sospesi nella reminiscenza, ma radicati nelle nostre storie individuali e sociali.
Considerato il mio quotidiano lavoro di recupero delle parole ho incentrato la mia attenzione sul fascino che qui sprigionano, sul suono da loro prodotto, sul significato più profondo, sulla lentezza a cui ti invitano, costringendoti a scandirle una per una.
Sembra proprio che l’autore le ripeschi una per una nel calderone dell’abuso o del disuso e restituisca loro dignità, in quanto “le parole sono medium dei rapporti umani”. Molto vivo è il suo colloquio con le parole e sulle parole, che aprono, iniziano, lanciano “dialoghi”. E le parole tornano ad essere i soli strumenti privilegiati a seminare e poi a raccogliere i frutti delle nostre esperienze, “fughe” all’indietro nel tentativo del recupero e avanguardie nel loro rilanciarsi in avanti.
La parola come “medicamento”, come lenitivo agli smarrimenti della nostra anima e, per chiudere il cerchio, come “costruzione”.
Cosa cerchiamo quando ci apprestiamo a sfogliare pagina per pagina un libro? (il libro va sfogliato nella sua materialità – è l’oggetto privilegiato della lentezza, del ripensamento, dei “tempi lunghi”)
Diventiamo esploratori e al tempo stesso collaboratori nell’attribuzione di significati, visto che “l’opera costruisce e quindi sceglie il proprio lettore”.
Mi perdoni l’autore, l’amico,….ho seguito il frammentarsi della scrittura in modo suggestivo, ho catturato parole e le ho chiuse in uno scrigno.
Spero, più avanti, di poterle restituire a qualcuno che, a sua volta, le ceda o le condivida con altri.
19 marzo 2021
Ripropongo qui la recensione apparsa sulla rivista on line Azioni Parallele, v.a 5 febbraio 2021
Roberto Bongini
Variazioni fugate
“Ogni cosa ha mille lati, ogni lato ha cento rapporti, e a ciascuno di essi sono legati sentimenti diversi. La mente umana ha poi fortunatamente diviso le cose, ma le cose hanno diviso il cuore umano”, R. Musil, L’uomo senza qualità
Sembra che Fughe abbia raggiunto quell’ideale artistico che Musil definisce “saggismo”. Ideale che si condenserebbe nella famosa coppia “anima e esattezza”, ingredienti necessari per l’opera d’arte: la struttura impalpabile e rigorosa della forma e la leggerezza libera dell’invenzione.
Così l’opera d’arte ideale si realizzerebbe fondendo la soggettività dell’artista e l’oggettività dello scienziato. Ciò è mostrato da Velio con maestria rara, abolendo la distinzione tra la letteratura e la riflessione sulla letteratura.
In Voci, ciò si mostra nella galleria dei personaggi e delle loro storie attraverso le quali, con progressivi salti di livelli e variazioni di densità nel tessuto semantico, si preparano le riflessioni che in Discanto si svilupperanno dalla filosofia del linguaggio, alla teoria della comunicazione letteraria, che si intreccerà con quella della persuasione, fino a svelare le diverse forme in cui si attua la mercificazione della conoscenza nella società dominata dal capitalismo finanziario.
Mi sembra che la maggiore densità di rilevanza, o, ciò che in me è risuonato con più forza, è: “Il frutto è il significato” (Lorenzo, p.66). Qui viene mostrata ostilità verso la concezione del significato come un’essenza stabile travestita dalle parole, qualcosa di umbratile a cui esse alluderebbero come segni vuoti, atti soltanto alla loro capacità di richiamo.
Questo è il passaggio dallo sguardo eterno di dio sul mondo a quello umano della vita.
Sembra ricordare Wittgenstein: “...La parola gioco linguistico è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio è un'attività, o una forma di vita.” (Ricerche filosofiche § 23)[1]
Nella dialettica autore/lettore, il secondo è l’opera e insieme se stesso dopo il cambiamento che la lettura del testo ha generato nel suo campo di credenze.
Ciascun lettore getterà una luce nuova nell’opera.
L’incontro/scontro tra i vissuti più o meno coscienti del ricevente e quelli dell’emittente trasmessi dall’opera, generano il significato del messaggio, la sua costruzione semantica. L’emittente comunica al ricevente una costellazione di elementi il cui significato dipende, in parte, dalla loro pertinenza latente derivata dalle intenzioni dell’autore e dall'altra da quelle del ricevente, la cui azione cognitiva inconsapevole consiste nella costruzione della coerenza, sia relativamente al significato degli elementi che “risuonano” nel suo vissuto, sia da quello inferito dalle nuove possibili ricombinazioni.
Il segno esibito mostra qualcosa che è inferito dal ricevente attivando uno sviluppo progressivamente autogenerante sempre più ricco di direzioni e piani di senso.
Come l’immagine dello spettatore che, nel disegno Escher Galleria di stampe, irrompe nel quadro osservato grazie alla torsione della sua superficie inglobata nello spazio dell’osservatore, così il linguaggio della descrizione della “materialità” dei fatti e dei personaggi irrompe nello stesso processo di comunicazione, inglobando l’opera e il ricevente.
Il linguaggio della narrazione si torce nel linguaggio derivante dalla riflessione assorbendo quello che ha prodotto.
L’efficienza del linguaggio, come quello della geometria dilatata di Escher, rende possibile questa torsione poco prima del punto di rottura.
La grammatica è giunta al limite della sua potenzialità.
Come in una fuga a più voci i soggetti/personaggi si rincorrono, si intrecciano e da questi elementi iniziali germina l’intera materia che è insieme causa materiale e causa finale dei loro svolgimenti. Nuove armonie pronte a fluire nei loro possibili sviluppi, e negli “stretti”, talvolta dissonanti, le voci si avvicinano producendo tensioni che annullano i cliché banalmente scolastici e prevedibili dell’armonia.
Il tempo diacronico della lettura materiale del testo, che si confonde con quello delle riflessioni e degli eventi narrati, è, credo, ingannevole. Quel tempo non esiste. Esiste, tuttavia, una struttura sincronica senza la quale sarebbe impossibile individuare l’intreccio delle relazioni interne tra le parti dell’opera.
Non ci sono cose ma processi!
Vs. Proust:"…Un’opera che contenga la teoria è come un oggetto su cui si sia lasciato il cartellino del prezzo..." (Il tempo ritrovato, Einaudi, Torino 1973, p.219).
Tale asserzione, dal punto di vista logico, essendo contenuta nel capolavoro proustiano, è fatalmente e banalmente autocontraddittoria. Su un altro piano, la metafora vela l’ideologia borghese che, nell’epoca della sua espansione, aspira alla formalità rarefatta della comunicazione aristocratica (p.es. Swann e la signora Léonie), dalla quale sono esclusi riferimenti al denaro che allude alla fatica e al sudore, volgarità che infrangerebbe le regole tacitamente condivise della conversazione. Ma Lorenzo canta romanze nel silenzio della natura, trasformando i segni ciechi della scrittura in simboli che aprono varchi a spazi fino allora inaccessibili, e l'emancipazione che deriva dal lavoro che umanizza la natura trasformandola, lo riscatta dall’antica dipendenza dei semplici con quel legame arcaico che l’ebbe soggiogati e esclusi dall’accesso al sapere.
Qui l'eroe ha questa duplice funzione!
Sera
Ritorno dai campi
Il carro traballante
Trainato dai buoi
Il sapore aspro del frutto acerbo.
[1] Anche in Zettel § 173 ...Soltanto nel fluire del pensiero e della vita le parole hanno significato.
Sara Starnai
Fughe: una sinergia tra forma e contenuto.
Fughe di Velio Abati grida al cambiamento, tanto nella forma, quanto nel contenuto. Dal punto di vista del secondo, le articolate vicende dei personaggi volgono lo sguardo ad ampie tematiche, come in Čigoč, dove viene affrontato quello che sembra essere un po' il paradosso delle società moderne, secondo il quale, oggi si tende a mostrare meno interesse per ciò che ci è relativamente lontano, in un mondo in cui siamo però sempre più in contatto. È piuttosto ricorrente, inoltre, che Abati spinga il lettore a riflettere sullo stretto legame tra presente a passato e sulla crescita dell’individuo quale frutto di un contesto storico preciso, come accade sia in Čigoč, che in Esercizi cinesi.
A sottolineare lo stretto legame tra presente e passato è il fatto che, in più racconti, l’autore ricorra spesso al discorso indiretto libero, creando così intrecci di tempi e spazi. Nelle varie vicende narrate troviamo spesso una bipartizione tra narrazione e riflessione. Dal punto di vista formale, nelle narrazioni la sintassi alterna ora uno stile frammentato, con prevalenza ipotattica e periodi brevi, ora uno più articolato, con prevalenza paratattica e periodi dilatati, a riflettere, in linea generale, il pensiero di esperienze ora più dolorose e probabilmente meno recenti ed ora presumibilmente più accessibili all’autore. Bisogna, tuttavia, sottolineare che la sintassi riflette il mondo interiore dell’autore, che narra le sue esperienze adottando uno stile introspettivo, come se l’autore volesse “parlarne il meno possibile” e lo esprimesse, allora, con la sintassi. Così, la voce narrante a volte accenna soltanto ad alcuni aspetti referenziali di fatti e personaggi, soffermandosi invece, a partire da essi, su riflessioni e argomentazioni di carattere storico, filosofico.
Diverso è, però, il discorso per quel che riguarda lo stile dell’indiretto libero, presente quasi in ogni racconto. Tramite questa tecnica, l’autore si rivolge direttamente al lettore, sollecitandolo prima alla riflessione e, una volta compiuto questo passaggio fondamentale, esortandolo al cambiamento. Ed è qui che, a differenza del precedente stile impiegato per la narrazione, l’autore si rivolge direttamente al lettore, impiegando non solo modelli sintattici più piani, ma anche un lessico che possiamo definire appartenente alla teoria dei prototipi. Ci troviamo, pertanto, di fronte a un quadro complesso, in cui tuttavia un concetto rimane chiaro e costante: la spinta alla riflessione e poi all’azione.
Un esempio lo troviamo in Lorenzo, guidati prima ad una riflessione sull’odierna definizione di opera d’arte, nonché sull’importanza del leggere e scrivere, in quanto atto intrinseco dell’uomo. Per indicare la loro essenzialità per l’uomo, Abati impiega un linguaggio chiaro e trasparente al lettore: “Scrivere è solamente necessario, come il respiro, il pane e l’acqua, come un nome ed un tetto, una mano da stringere o un volto con cui guardarsi” (p.63). In questa frase, infatti, l’autore impiega termini, per usare un concetto della linguistica cognitiva, “prototipici” e così per funzioni vitali Velio nomina “il respiro”, per cibo il “pane” per bevanda “acqua”. Questo primo elenco, la cui enfasi viene accentuata dal polisindeto, paragona la scrittura ai bisogni materiali di cui ogni uomo necessita. Viene tuttavia seguito da un secondo elenco, anch’esso enfatizzato dalla medesima figura retorica, dove, per l’identità individuale, si richiamerà un “nome”, per quella familiare un “tetto” ed infine per quella sociale “una mano da stringere ed un volto con cui guardarsi”. Ovviamente la teoria dei prototipi non può che fare riferimenti a fattori extralinguistici, quali i socio-culturali, ed ecco che l’autore designa un certo tipo di lettore a cui si deve avvicinare, un lettore della società occidentale, che vive in un dato periodo storico e così via. Così, l’autore fa capire, tanto nella forma quanto nel contenuto, che il cambiamento viene da noi.
Se “due persone diverse che dicono la stessa cosa non dicono in realtà la stessa cosa” (Lorenzo, p.66), è anche vero che “la posizione di chi legge rispetto a chi ascolta è simmetrica a chi scrive” (Ibidem).
31 gennaio 2021
Margherita Lorenzoni
Parole per resistere
Spesso, nel leggere i tuoi racconti, mi sono trovata a chiedermi perché ti soffermi tanto sul nominare con precisione strumenti, attrezzi, piante, animali… Tutti elementi di un mondo che mi è vicino spazialmente, e che quindi forse dovrei conoscere, ma verso i quali devo ammettere di provare un’istintiva indifferenza, o forse sarebbe meglio chiamarla una specie di insensibilità. Non che non provi disagio nel riconoscere l’attitudine della mia mente a livellare strati di realtà così eterogenei: il passato, la natura, lo scorrere ciclico del tempo. In linea di massima riesco a darmi delle spiegazioni, penso per esempio che valga la lezione di Benjamin per cui, genericamente, «l’orientamento pratico è un tratto caratteristico di molti narratori nati» (forzando un po’ le sue parole); ma, nel caso specifico della tua narrativa, ho sempre pensato che la ricerca meticolosa sui termini e sulla funzione degli oggetti che essi indicano dovesse avere una qualche ragione particolare.
Da dove iniziare? Leggendo Fughe, ho avuto l’impressione di dover partire dal lontano, piuttosto che dal vicino.
In Ĉigoĉ si dice che è la vita della vecchia «a diventar carne con gli oggetti» perché lì «essa trova il proprio senso, si perpetua negli occhi e nell’animo degli altri che arrivano e che verranno». Molti di questi strumenti il visitatore li conosce, «qualcuno l’ho persino usato nella mia infanzia, a mille e mille chilometri di distanza» dice. Queste numerose “tecniche gemelle” rivelano la comune origine mediterranea, ma allo stesso tempo sono la traccia dell’”abisso di circostanze” che separa i personaggi, che non hanno ancora avuto il coraggio di riconoscere la medesima origine del dolore “covato” da quegli stessi oggetti.
Mi è capitato di leggere romanzi e racconti ambientati in Palestina e, scoprendo Yalla!, mi ha colpito riconoscere nel tuo indugio sui paesaggi o sulle costruzioni una tensione simile a quella di autori palestinesi, da cui ho sempre ricevuto l’impressione che le “cose” nominate non fossero solo sfondo delle vicende umane. Mi è sempre parso, in realtà, un potente strumento di resistenza: raccontare un territorio da cui si è stati strappati, o che in altri casi si è conosciuto solo dai racconti, rappresenta uno straordinario esercizio di opposizione allo sradicamento. La memoria è anche sollecitazione all’agire, è strategia per spronare le nuove generazioni a non abbandonare la lotta.
Estendere lo sguardo fino alla Palestina mi ha rivelato una possibile prospettiva interpretativa. Nella tua attenzione al mondo materiale, per così dire, non ci leggo solo una questione memoriale, di conservazione di tecniche o saperi tradizionali o del legame con le generazioni passate, ma una progettualità politica che può farsi strada attraverso la parola, la quale rivela la sua forza quanto più è capace di aderire con precisione al mondo che descrive. Conoscere la parola è conoscere il mondo e mettersi nella postura di poterlo trasformare.
28 gennaio 2021
Ripropongo qui la recensione apparsa sulla rivista on line Nazione Indiana, v.a 22 gennaio 2021
Massimo Parizzi
Fughe di Velio Abati
Velio Abati, nato nel 1953 a Roccalbegna, in Maremma, vive a Grosseto, dove nel 1993 diede vita alla Fondazione Luciano Bianciardi, che diresse, facendone un vivace centro di cultura, fino al 2006, quando ne venne estromesso da una manovra politica, di cui fu protagonista l’allora giunta di centrosinistra, definibile a buon diritto squallida.
È autore di saggi (fra cui Considerazioni inattuali di un viaggio in Cina, con introduzione di Franco Fortini, Quaderni toscani di Democrazia proletaria, 1985, e L’impossibilita della parola. Per una lettura materialistica della poesia di Andrea Zanzotto, Roma, Bagatto Libri, 1991), volumi di poesia (Desinenze, Grosseto, Il paese reale, 1978; Dialoghetti, Grosseto, Gruppo Poesia ARCI, 1984 e Questa notte. Canzoniere, San Cesario di Lecce, Manni, 2018), e ha curato Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. Nel 2013, inoltre, ha pubblicato un romanzo, Domani, San Cesario di Lecce, Manni, e nel 2020, sempre con Manni, una raccolta di prose, Fughe. È di quest’ultimo libro che cercherò qui di dire qualcosa, riprendendo in alcuni punti una lettera a Velio Abati pubblicata in “Odissea” .
Fughe raccoglie 36 brevi, non racconti, ma “prose”, come si legge in copertina. Vi si trovano infatti miscelati con coraggio narrativa e saggistica, sia nel senso che alcune prose sono narrative e altre saggistiche, sia nel senso che la stessa prosa, a volte, inizia narrativamente e prosegue nella forma di un saggio. Non c’è dubbio che Abati ricordi bene come un tempo, negli anni Settanta, che tanta parte hanno in questo libro, la separazione fra i generi letterari fosse parsa a molti, in nome dell’unità dell’essere umano, dubbia (com’era parsa dubbia a generazioni più antiche, ma in nome d’altro). Ora ovviamente quel dubbio, se qualcuno mai vi accennasse, verrebbe chiamato “ingenuità”. E tuttavia è esattamente il contrario: è la consapevolezza che, se la divisione in generi è comoda e ha una lunghissima storia, è anche ingannevole; presume e quindi crea o fortifica all’interno del lettore e all’interno della scrittura divisioni che, almeno nel profondo di entrambi, non ci sono.
Il libro si compone di due sezioni: la prima e più corposa (un centinaio di pagine su 160) è intitolata Voci, la seconda Discanto. Le voci sono per la maggior parte di persone conosciute o anche soltanto fuggevolmente incontrate nel corso della vita: con qualche eccezione, le prose di questa sezione ne portano come titolo i nomi. E sono testi per lo più dolenti, a riflettere la rovina portata nelle vite di quelle persone e di tutti noi dall’“ammassarsi della miseria” (p. 21) a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. E tuttavia, a fare da contrappunto e contrasto al duolo, il carattere di tutti i personaggi di questi racconti è positivo, o a renderlo positivo è l’amorevolezza con cui Abati ne parla, un’amorevolezza che, partendo da un senso di comunanza fra tutti gli esseri umani, giunge a volte come a dire: “Tu potresti essere me e io potrei essere te”, o meglio, “tu sei me e io sono te. Riferendosi in Ĉigoĉ (nome, questa volta, di un paese della Croazia), a una “vecchia, alta, pallida” che non incontrerà mai più, Abati osserva: “Una minuscola manciata di decenni addietro eravamo il medesimo bambino” (p. 16).
Ma personaggi a pieno titolo di tutte queste prose non sono soltanto persone; lo sono anche la natura e l’arte. La natura, che compare e ricompare, a volte portatrice di una forza di resistenza quasi spavalda (“il maggio negli orti, esplode sui fiori di sangue del croco”, p. 39), a volte di una promessa (“Il cuculo tornerà di nuovo la prossima primavera. Il verde si farà più tenero, il campo sarà soffice”, p. 12), a volte di un richiamo, quasi accennasse anch’essa, “come accade all’arte, […] a un bisogno antropologico che da qualche parte attende ancora di diventare realtà. Una spinta confusa ma caparbia che nemmeno la società barbarica assegnata in sorte al nostro vivere riesce a annichilire” (p. 121). Sono parole, queste, che Abati, insegnante per decenni in un liceo di Grosseto, rivolge al momento del Congedo (titolo della prosa) ai suoi studenti, con l’invito, quel “bisogno antropologico”, a ricordarlo “sempre, ragazzi, perché […] è quello il futuro dell’umanità”.
Ecco i “buoni” quindi: uomini e donne, natura, arte. E i cattivi? Non ci sono. Cioè: c’è, fin dalle prime pagine, chi “ha sempre più immiserito, arricchendosene, le nostre vite e i nostri pensieri” (p. 13), il capitalismo, insomma, nei vari nomi, forme ed effetti che lo individuano. Però non è un “personaggio”, è uno sfondo che, tuttavia, non sta in fondo, ma davanti, a sinistra, a destra, e soprattutto sopra i personaggi, a premerli, schiacciarli. Ma, loro, restano positivi: i buoni. Ecco perché fanno da contrappunto e contrasto al duolo.
Ma torniamo un momento a quel “bisogno antropologico”: è un punto fondamentale. Chi non lo prova o non l’ha mai provato, qualunque nome, o nessuno, gli dia, e soprattutto chi non vuole provarlo, difficilmente, forse, leggerà questo libro. Perché Fughe chiede molto al lettore, e prevede un lettore che a sua volta chiede molto a un libro. Come nel romanzo Domani, anche qui, benché in misura minore, Abati salta da un luogo all’altro, da un tempo all’altro, omettendo di esplicitare i passaggi. Omissioni che impongono al lettore la rinuncia alla pretesa “reazionaria” dell’“immediatezza” (p. 82) e alla “strumentalità immediata” (p. 136), certo, e anche di “piegare il piacere letterario alla funzione d’inciampo al già saputo” (p. 108). Ma soprattutto gli impongono un movimento omologo a quello necessario per individuare, e riconoscere, quel “bisogno antropologico”. Come se quelle “menomazioni” del testo, quello che nel testo “non c’è”, “ci sfugge”, “ci è sottratto”, addestrassero le stesse capacità dello spirito che occorre mobilitare per cercare «ciò che non c’è, che ci sfugge, che ci è sottratto” e che “si cerca perché è una nostra menomazione” (p. 161).
Con quest’ultima citazione siamo entrati nel pieno della seconda sezione del libro, Discanto, prose per lo più saggistiche, ricche di osservazioni acutissime sul presente, sulla scrittura, sulla lettura e altro. Già il titolo, Discanto, indica il carattere alto della scrittura in Fughe, inteso certamente a prendere nette distanze dalla “chiacchiera imbonitoria” (p. 123). Ma, soprattutto, il carattere della scrittura contribuisce a creare in tutto il libro quella che Abati definisce una “cadenza”, a proposito della quale (ma non certo parlando dei suoi scritti) osserva: “Basta accompagnare una cadenza, per sentirne il valore, ben prima di comprenderla. È proprio quella promessa, anzi caparra che chiede la fatica dell’ascolto, sempre” (p. 104). In altri punti parla della lettura come di un’“esperienza”. Ed è esattamente un’esperienza la lettura di questo libro, un’esperienza che fa bene e spinge, o almeno ha spinto me, alla rilettura di molte sue pagine, non tanto per capire meglio, ma per restare più a lungo nella buona compagnia della sua voce
Ripropongo qui la recensione apparsa sulla rivista on line Azioni Parallele, v.a 18 gennaio 2021
Walter Lorenzoni
Quelli che dovevano rivoltare il mondo
Nella lettura di Fughe, ciò che ha subito attirato la mia attenzione è la ricorrente riflessione dell’autore intorno alla parabola della sua generazione, quella che avrebbe dovuto cambiare il mondo («noi eravamo nati per rovesciarla, la storia», Attilio, 22): gli slanci e gli entusiasmi iniziali, la controffensiva capitalistica, i primi cedimenti, la sconfitta, le residue e tenui speranze.
Nel racconto di apertura si evidenzia la presa di consapevolezza di sé di una nuova generazione, mossa dall’«ansia di costruire il mondo», proiettata verso un futuro di progresso inciso nello svolgersi stesso della storia: «Ci era chiaro che non eravamo più i nostri padri e i nostri nonni, così tanto uguali tra loro, si diceva. Però eravamo caduti in una terra di mezzo, anzi di nessuno» (Fantón, 9). Le ultime parole lasciano intendere che la rottura si è prodotta senza che la nuova connotazione fosse ancora ben definita e forse questa è una prima spia della disgregazione successiva. Abati – e su questo tornerà più volte – non sembra credere alle fratture radicali e definitive tra le generazioni, o meglio, le ritiene apparenti, se messe di fronte ai tempi lunghi della storia e ai percorsi carsici dei tanti legami che, al suo interno, vengono a dipanarsi. È del tutto persuaso che l’ira generazionale è «figlia della sequela dei padri» (Fantón, 12) e che l’idea «di essere tutti nati la mattina precedente » (Gabrio, 39) è sì inebriante, ma al tempo stesso anche cieca.
In alcuni personaggi, che mi sembrano particolarmente emblematici, si assiste alla deriva di questa generazione, che è senza dubbio storica, ma anche esistenziale. Il primo di questi è Fantón. Dopo l’euforia iniziale per rovesciare il mondo, si è seccato «anche quel rigagnolo che teneva agganciato il nostro immanere con i mille altri che ci davano aria e forze…e le strade sono state inghiottite dal deserto» (Fantón, 13). È la presa d’atto della sconfitta storica, della separazione, delle scelte individuali. Quando Fantón ricompare sembra ancora lui, tanto che continua sempre, come in gioventù, a prendere appunti, ma ora spinge la penna sui fogli «come uno stecco storto» e la sua voce, un tempo pacata, «è diventata roca» (Fantón, 14). La sconfitta storica è divenuta esistenziale.
Attilio, invece, appartiene alla tipologia dei personaggi di quella generazione che si sono rapidamente convertiti alle ragioni dell’avversario, accompagnando la trasformazione con una buona dose di cinismo. Dopo l’impegno politico nell’estrema sinistra sono diventati socialdemocratici, dalla lettura dei Grundrisse sono passati a quella del “Corriere della sera” e, più tardi, non hanno più indossato i jeans ma il completo grigio. Attilio si mostra convinto della bontà delle proprie scelte e dice che «il tempo non passa solo per farci invecchiare» (Attilio, 24), facendo suo, in qualche modo, l’abusatissimo adagio, attribuito a Churchill, per cui “chi non è socialista a vent’anni è senza cuore, chi lo è a quaranta è senza cervello”. La conversione di Attilio, tuttavia, ha un che di inautentico e – nonostante rivendichi il suo esser diventato laico, avversando tutti i fanatismi e gli orrori del totalitarismo – il suo profilo di insegnante è lì a dimostrarlo: non è che uno dei tanti che ha tirato i remi in barca, rinunciando al lavoro pedagogico quotidiano e che, per non aver rogne, allo scrutinio finale porta «tutti alla sufficienza motu proprio» (Attilio, 26). Abati, prima di indugiare su questo comportamento, lo ha già moralmente condannato, come una sorta di tradimento delle ragioni più autentiche del comune impegno politico giovanile: «Proprio la nostra generazione sapeva, più di ogni altra, l’importanza della crescita culturale come strumento di emancipazione e di potere sociale» (Attilio, 25). Questo è il vero atto di accusa nei confronti di Attilio e, quindi, il suo dileguarsi finale, al momento della festa per il pensionamento, diviene il simbolo dell’evaporazione di una generazione, del tutto combaciante, pur nella diversità dei percorsi, con chi, prima di lui, era evaporato nell’eroina e nella lotta armata (la «distruzione chimica» e la «paranoia idiota delle armi», Attilio, 23).
Marcello, viceversa, non ha sposato le tesi dell’avversario, è rimasto nella propria parte, all’interno della forza politica istituzionale e maggioritaria che la rappresenta, assecondandone tutte le trasformazioni successive al 1989. Si è buttato nella svolta pieno di fervore e rinnovate energie, con l’obiettivo di costruirsi un nuovo percorso politico e di conquistare spazi di agibilità che fino ad allora gli erano stati preclusi (come si dirà più avanti, «nel nostro Paese il partito delle classi subalterne credette di rimediare alle proprie difficoltà abbandonando il nome, sciogliendo i ranghi e cercando altre forze. Drappelli di reduci fino ad allora tenuti ai margini e oramai portavoce di se stessi risposero alla chiamata», Dove sei?, 127). Il suo proposito, perseguito con la medesima «furia ortodossa» (Marcello, 59) del passato, prende corpo in una specie di massima che prescrive di “agire, andare avanti senza guardarsi indietro, sporcarsi le mani, stare nel mondo ed evitare ogni elitarismo”. Di conseguenza, facendo violenza al suo carattere ed al suo più profondo modo di essere, si abbona al campionato di baseball, sopportando di sottoporsi – lui che mai si era in alcun modo interessato di sport – all’apprendimento delle sue complicatissime regole, accetta di sposarsi in chiesa, con tanto di messa cantata in latino, inaugura, tra i primi, la nuova moda dei banchetti nuziali in agriturismo e, però, alla fine, non può che suicidarsi. Troppa ormai è la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato e nessuna razionalizzazione, più o meno posticcia, è stata in grado di accorciarla.
Anche Raffaela, come Attilio e Marcello, è una che si adegua al nuovo che avanza, ma questa sua caratteristica viene osservata nell’ambito specifico della scuola. Figlia della scolarizzazione di massa, come moltissimi della sua generazione, cresce e matura rapidamente nella breve stagione dei movimenti, impegnandosi con rigore e senza risparmio di energie. Quando ricompare come collega docente nel periodo in cui ormai il neoliberismo ha vinto e la scuola ha già subito i processi di privatizzazione e aziendalizzazione, sembra essersi dimenticata delle sue origini, del suo faticoso percorso di emancipazione e delle speranze condivise con chi, come lei e insieme a lei, preparava il futuro. Con la stessa severità di un tempo è ora diventata una zelante esecutrice del nuovo modello scolastico. Si tratta di una vera e propria rottura antropologica, secondo quanto già raccontato anche in un apologo precedente che alludeva a tutte le Raffaele che, ad un certo punto, sono via via venute alla luce («Alcuni storici asseriscono che insegnanti e personale migliore, quello che si era formato in quel certo periodo di crescita – migliore perché più motivato, più aperto alle trasformazioni, persino più competente – si erano buttati anima e corpo nel sostenere le ragioni della propria scuola e quindi della concorrenza. Lo facevano, scrivono, senza alcun sospetto, in completa innocenza», C’era una volta una piccola città, 35-36). Come già in Attilio – il loro itinerario di insegnanti è per molti versi agli antipodi, quasi a riprova della incoerente frantumazione di una generazione –, la condanna dell’autore, di fronte a quello che, senza ombra di dubbio, si configura come un tradimento della propria storia e di coloro che con lei l’hanno condivisa, è già stata preliminarmente pronunciata: «…mai lo scacco può annullare la verità che a una generazione sia capitato di additare» (Raffaela, 50).
L’altra figura esemplare di questo mio percorso, frequentata dall’autore in una fase più matura, è Giacinto, di cui ci viene lasciato intendere che, nelle organizzazioni tradizionali della sinistra, ha attraversato esperienze politiche e culturali che hanno accumulato in lui «rancore» e «ira repressa» (Giacinto, 76, 80). Mentre negli altri personaggi analizzati finora, il secondo tempo della loro vita sottolinea il venir meno delle ragioni di una volta e la loro sostanziale sconfitta esistenziale, in questo caso le cose stanno diversamente: non siamo di fronte ad un incontestabile fallimento, ma ad una sorta di dissonanza anacronistica, che spiazza il lettore, in quanto Giacinto sembra essere felice e senza particolari rimpianti. A sessant’anni passati si è trasferito in Estremo Oriente a cercare se stesso, compiendo un percorso che molti suoi coetanei hanno fatto più di quarant’anni prima. Sebbene l’autore guardi con occhio benevolo Giacinto e lasci credere anche di provare un pizzico d’invidia per la sua scelta coraggiosa, in realtà, fin dal momento dell’incontro, ci fa capire che questo esotismo fuori tempo massimo non riesce a convincerlo fino in fondo e provoca in lui un forte senso di spaesamento: l’austero individuo che ci è stato presentato in precedenza diventa un tipo con «una barbetta arsiccia, un cappelletto rotondo…di foggia…orientale» (Giacinto, 79) e, soprattutto, l’incontro con il relativo racconto della sua nuova vita nel lontano Oriente avviene nel contesto “esotico”, per forza di cose caricaturale, del palmizio situato in un breve tratto irregolare della pista ciclabile che scorre dentro la piccola città.
Che la responsabilità di tale débâcle generazionale debba essere imputata alla vittoria senza prigionieri del neoliberismo, alla «restaurazione capitalistica che è seguita dopo i Settanta e che oggi giunge al suo culmine» (La cartella, 86), Abati non ha dubbi. Certo, l’alienazione capitalistica c’era anche prima, ma solo oggi è possibile capire «che quello spossessamento non è immutabile, ma varia il suo grado da una generazione all’altra, da un luogo all’altro». E ora che più «potente si è fatta…la sua spinta» (Livia, 72) «il capitalismo è tornato a essere ciò che da sempre vuole apparire: un dato naturale» (Esercizi cinesi, 131). La sua vittoria, però, non è stata improvvisa, si è prima definita lentamente, camuffandosi e facendo abbassare le difese del nemico, per poi colpirlo alle spalle con rapidità, stordendolo e compromettendone le residue capacità di resistenza.
Pescando in modo molto libero tra i vari testi, è possibile quasi ricostruire il crescendo di questo autentico tsunami. Si comincia, innanzi tutto, ad avvertire che qualcosa sta mutando, ma senza rendersi bene conto di dove si stia andando a parare (le «rovine che già si annunciavano, anche se forse nessuno immaginava di durata e ampiezza oggi a tutti palese», Lorenzo, 63), poi la sconfitta comincia a delinearsi («Prendeva forma la rovina»), anche nelle sue possibili conseguenze («Cominciava a chiarirsi che ogni singola legnata non era momentanea», Raffaela, 51) e, infine, ancora frastornati, si capisce nitidamente ciò che è accaduto («Qualcosa di potente aveva preso energia, era cresciuto, nei corpi, nelle menti, nel tessuto minimo delle ore, talmente inavvertito che solo a fatto concluso hai potuto scorgere, sbigottito, con quanta velocità e quanto in profondo aveva slogato i legami, frantumato lo spazio, bruciato i giorni come attimi», Giacinto, 76-77). È allora, dice l’autore, che il vincitore può anche permettersi di irriderci, «pisciandoci addosso la sua risata violenta. Tutto, oggi lo vediamo, è stato sfigurato e aggredito alle radici, fieramente: di noi, dei nostri primi e di nostra parte» (Fantón, 13). I giochi, a questo punto, sono fatti e chiaro è il nuovo quadro che è venuto a definirsi: «Una lunga epoca si è conclusa, seppellita da una meccanica al momento inarrestabile: da una parte un capitale condotto dalla sua vittoria al compimento della propria follia, per la quale erge se stesso a unica ragione e diritto sotto cui tutto, e terra e acqua e aria e vita e sogni è materia inerte per il proprio profitto; dall’altro un pianeta offeso, consumato dei suoi equilibri che con brevi fiati sommerge uomini, animali, piante, profila, con accelerazione visibile, i continenti» (Dove sei?, 128).
Nel ripetuto ritornare dell’autore sulle sconfitte e i disastri degli ultimi decenni, si può leggere in controluce un rimprovero a se stesso e alla sua generazione: come è potuto succedere che – nonostante le eredità del passato e le esperienze accumulate nelle lotte, nei rapidi processi di emancipazione culturale, sociale e politica – tutto sia precipitato così velocemente e rovinosamente, senza che sia stato possibile approntare linee di difesa all’altezza della posta in gioco?
Per definire la forma odierna assunta dal capitalismo, quella neoliberista, nel libro si ricorre spesso alla categoria, elaborata da Luciano Gallino, di finanz-capitalismo. All’autore, tuttavia, non interessa tanto soffermarsi sui sistemi di funzionamento di questa macchina efficiente e quasi invincibile (anche se non mancano alcuni precisi riferimenti al riguardo), quanto sugli effetti che essa produce. Voglio dire, tanto per fare un esempio, che più che ragionare, magari, sulla differenza tra produzione di valore ed estrazione di valore (capitalismo industriale vs finanz-capitalismo), si preferisce osservare e mettere in rilievo le conseguenze che questa nuova forma di accumulazione della ricchezza determina a tutti i livelli della società. Una rapida carrellata dell’aggettivazione usata in Fughe per illustrare gli esiti di questa nuova fase capitalistica non lascia dubbi su quale sia il giudizio morale e politico di Abati: il mondo che si è venuto a realizzare risulta mercificato, misero, opaco, buio, oscuro, disordinato, sfigurato, rovinato, devastato, barbaro, folle, cinico, malvagio, osceno, decrepito, pestilenziale, marcio.
Sicuramente il finanz-capitalismo ci sta portando al disastro ambientale. L’offesa al pianeta, di cui si parlava nel brano già citato di Dove sei? (128), porterà l’umanità «al culmine di un precipizio che travolgerà noi, causa prima, e altra catena innumere di esseri» (Giacinto, 78). E ciò anche grazie ad un’opera sistematica di disinformazione e di educazione all’individualismo del «farsi i fatti propri», disinteressandosi degli effetti del «malmodello di sviluppo» («Molti semplicemente non riescono a comprendere che nessuno vive e muore solo per se stesso e che la misconosciuta distruzione di aria e acqua non è senza conseguenze, per cui corrono spensieratamente al danno e alla morte», Marusca, 108-109).
Un’altra perniciosa conseguenza del capitalismo contemporaneo, nel quale «il presente occupa compattamente l’esperienza del tempo» (Non ho tempo, 144), è la pervasività raggiunta dai dispositivi di alienazione che conducono al massimo grado di atomismo sociale e comunicativo. I legami sociali sono diventati “slogati”, come si dice in Giacinto (77), le possibilità di discussione si sono prosciugate («nella mia vita attuale, quali sono i luoghi fisici, quali le occasioni del giorno e del mese, quali le persone con cui avviene il mio confronto su di me e sul mondo?...Temo che la gran parte di voi giunga alla stessa risposta data a me stesso: pressoché nessun confronto», Esercizi cinesi, 130) e anche laddove il confronto sembra facilitato dai nuovi mezzi di comunicazione e da internet, spesso, si tratta di un bluff, di un ingannevole dialogo che è incline a virare subito verso il monologo nella forma dell’urlo e dell’affermazione egoica di se stessi. Alla fine la cosa più grave è «il fatto che là dove i subalterni possono e comunque credono di parlare con la propria testa sono umiliati alla coazione senza saperlo» (Sulle domande del lettore, 164), convinti di essere totalmente liberi, ma nella realtà completamente subordinati all’ideologia dominante.
Il capitalismo neoliberista è poi il massimo responsabile del «degrado dell’istruzione pubblica», esito conclusivo dell’«assalto alla forza emancipativa della scolarizzazione di massa dei trenta gloriosi» (il «breve tempo di cui ha beneficiato la mia generazione», dice l’autore, La cartella, 84) e della «precipitosa regressione» (Esercizi cinesi, 131) della stessa (analfabetismo di ritorno, abbandoni scolastici, ostacoli di ogni natura ad accedere ai gradi più alti dell’istruzione, ad esempio). In nome della razionalizzazione e del risparmio si sono favoriti i processi di privatizzazione, secondo i nuovi dettami della «globalizzazione neoliberista», aprendo la strada alla scuola dell’«addestramento» e non della «formazione», delle «competenze» piuttosto che del «sapere disciplinare» (Se io oggi sono qui a parlarvi, 154-157), in due parole, alla scuola dei clienti (Attilio) e delle tassonomie (Raffaela).
Cosa fare di fronte alla potenza di un apparato capitalistico apparentemente indistruttibile, tanto più in un contesto contrassegnato dalla «desertificazione di ogni progetto politico anticapitalistico?» (Franamenti, 133). L’autore, in apertura del volume, si impegna, pur nell’«oscurità dei tempi» presenti, a delineare «un orizzonte di senso» che dia una risposta «alla dispersione pulviscolare degli eventi dell’esistenza da cui le prose muovono» (Invito, 5), sebbene confessi di non poter essere certo della riuscita dell’impresa. Con queste parole iniziali si parte dalla presa d’atto, confermata in seguito nei testi proposti, che, a questo giro, quello della sua generazione, l’assalto al cielo è fallito. Il testimone passa ora alle nuove generazioni, ma una lettura oggettiva dell’attuale situazione non lascia spazio a facili entusiasmi. La scuola e l’insegnamento, ormai fagocitati dal sistema neoliberista, hanno quasi del tutto abdicato al loro ruolo di strumenti di crescita culturale, di sviluppo del pensiero critico e di emancipazione sociale. L’ideologia individualistica, poi, è diventata pervasiva in ogni ambito sociale e in ogni fascia d’età («Intere generazioni, condotte da una educazione al narcisismo all’acquiescenza del farsi i fatti propri piegano capo e gambe», Marusca, 108).
Nonostante queste difficoltà, sembra dirci Abati, bisogna continuare a seminare perché, marxianamente, «la verità è sempre storica» (Verità, 167) ed è assolutamente falso che il capitalismo sia un dato naturale, immodificabile e imperituro. Ci viene però mostrato anche che si tratta di un lavoro faticoso – tanto più oggi quando i «sentieri» sono «divenuti anfratti» (Giacinto, 78) – che richiede «la forza dei tempi lunghi» (La cartella, 87), quella stessa forza e pazienza che l’autore dice di ricevere dalle generazioni passate («dai millenni della mia gente della terra», Giacinto, 78). In questo contesto agire non è facile, ma una qualche via d’uscita, anche se minima, dev’essere trovata («La distanza tra ciò che è necessario e ciò che ciascuno di noi può è tale da atterrire le energie più agguerrite, le menti più lucide. Non si tratta di disperarsene ma di capirlo», (La cartella, 86). Pertanto, anche «nel tempo della povertà, conta l’essenziale; la pochezza non può essere alibi all’inerzia» (A una giovane, 113). Ma inerzia riguardo a che cosa? Non certo nei confronti di un obiettivo definito, il quale, anzi, appare incerto e sfocato, ma rispetto al percorso: «…oggi…la cosa più difficile, ma quella decisiva, non è la meta, bensì la direzione». La verità sta nel processo non nel risultato. Si tratta di una ragionevole speranza, in un senso vagamente kantiano, sul «futuro comune», sul “domani” comune di cui solo gli sconfitti detengono «la ragione e la forza» (La cartella, 87), perché, come si dice altrove, «è dei senza voce la forza lavica delle ere e infine la voce, la quale ogni volta si leva imprevedibile e nuova» (Dove sei?, 129). Proprio in ragione di tali legami profondi che attraversano le generazioni – già ampiamente indagati e plasticamente rappresentati nel romanzo Domani –, è bene ricordare «a chi se ne fosse dimenticato, che nessun’isola è data sulla terra» e «chi…è buttato da parte sa sempre portare con sé, anche senza saperlo, la parola di verità che altri, oramai morti, hanno saputo additare» (Cene, 120). Per tale motivo la speranza rimane viva e, sollecitandoci indirettamente ad andare nella stessa direzione, Abati dice che non è ancora il tempo di «appendere le scarpe al chiodo. Per questo sono ancora in cerca di nuovi compagni, contemporaneamente resistendo – da figlio di millenni contadini – all’entropia degli abbandoni di quanti della nostra parte abbiamo incontrato» (Franamenti, 134-135) – e qui il pensiero non può che andare immediatamente ai personaggi che ho esaminato all’inizio, anche se non soltanto a loro, ovviamente. Nelle ultime parole citate è indicato un doppio movimento, da svolgersi in parallelo: resistere e costruire un nuovo noi, «affinché i legami interrati che, benché battuti e umiliati, tuttavia sussistono, possano con pazienza fruttificare più in alto nel nostro domani» (Esercizi cinesi, 132).
Da una lettura trasversale dei testi presenti in Fughe, tuttavia, l’aspetto, che mi sembra a più riprese sottolineato riguarda proprio la difficoltà sia dell’azione di resistenza che di costruzione di un nuovo noi. Le forze in campo, infatti, risultano intrinsecamente deboli, esangui, insufficienti ad alimentare la speranza, a breve termine, di un nuovo assalto al cielo. Forse, è da questa constatazione che nasce quello scatto, che può apparire volontaristico, mediante cui l’autore conclude il volume con una sorta di appello «alla necessità di forme politiche capaci di una visione complessiva alternativa e di una corrispondente capacità di agire in modo coordinato all’altezza del disordine mondiale organizzato dal capitale» (Virtù, 170).
Il cerchio sembra chiudersi: le ultime parole del libro sulla necessità dell’organizzazione politica paiono voler rispondere, almeno in parte, a quelle iniziali sulla ricerca di «un orizzonte di senso» (Invito, 5) che riesca nuovamente ad aprire «al domani uno spiraglio diverso dal puro colpo di dadi» (Dove sei?, 125).
Luisa Gastaldo
La tua lingua si fa pietra d’inciampo
[…] Fughe è un’opera così densa che subito sollecita la rilettura. Mi interpella, mi incalza: è un libro che va “studiato”! Vi ritrovo l’esigenza dell’esatta nominazione, la lingua puntuale e puntuta che restituisce l’acutezza del pensiero e la precisione dell’argomentare. Nei racconti della prima sezione intitolata Voci, ogni narrazione prende le mosse da snodi di esistenza in cui la voce del narratore si innesta, confrontandosi con sedici figure che ritrae sunteggiandone la parabola. Attraverso il medium della memoria, esse sfumano l’una nell’altra e in forma di eco percorrono anche Discanto. Leggendo Voci si potrebbe percepire, per l’allusività di alcuni dati, una qualche astrazione temporale che tale non è. Anzi, le figure conficcate nel proprio tempo interpretano esperienze collettive e individuali per brevi segmenti sia per lunghe campate, fatto che ti consente di chiamare in causa Gramsci insieme a Velso e a Ettore.
La efficacia e la ricchezza di questa tua concentrata, vigorosa lingua, in Fughe non cessa di affascinarmi, benché tu non la estragga che in parte dal patrimonio con cui hai costruito – epicamente in ogni senso – l’edificio di Domani. È una lingua che coincide con la cosa detta e davvero, “nella notte in cui ci è dato di lavorare”, si fa “pietra d’inciampo”, esplicita con cruda precisione, diventa tagliente. Ma parla anche con accorata perentorietà, si espone con umiltà alle obiezioni, evita ogni reticenza.
Caro Velio, ti sono grata per la responsabilità che hai assunto prendendo parola, perché in quella parola mi riconosco e trovo materiale di costruzione di senso. Tu ricordi che “il primo grado di libero arbitrio è non aderire”: questa è anche la posizione di Luciano Morandini quando, intendendo sottrarsi “alla medusa del presente”, utilizza il pur usurato/usurpato “resistere”.
Nella necessità della elaborazione teorica che attinge all’origine del pensiero critico e nell’urgenza dell’interlocuzione avverto nelle tue pagine anche il segno dell’attitudine e dell’impegno pedagogici: così io pure, leggendoti, ho attinto al tuo magistero e ti ringrazio per aver additato, come scrive Tommaso Di Francesco, sommessamente ma anche con fermezza “la sorgente di forza”.
12 gennaio 2021
Ripropongo qui la recensione apparsa sulla rivista on line Odissea di Angelo Gaccione, v.a 11 gennaio 2021
Andrea Nuti
La messa a lavoro di una parola ardua
L’assenza di linearità, una “scrittura ispida, acuminata” (Marusca, p.106), unita alla forza delle immagini e soprattutto della parola sempre rigorosamente scelta, genera nel lettore motivato la voglia di costruire il senso del proprio discorso messo a lavoro da Velio. L’assenza genera movimento, l’ostacolo bisogno. “Occorre lo strappo d’un imprevisto, perché il profumo di una vigna o uno sfavillio di celeste irrompa” (Non ho tempo, p.144). Questa è per me l’azione di queste Fughe: mettere a lavoro il lettore, ‘imporre’ una fatica intellettuale, da cui sola può nascere consapevolezza sociale e coscienza collettiva. Da questo punto di vista la costruzione del testo, che avviene a posteriori da parte del lettore, è momento da affiancare alla condivisione successiva, “è la realtà storica, sociale e psicologica del lettore a fecondare un’altra volta il testo, producendo nuovo senso” (Lutero, p.142); i momenti d’incontro che ruotano intorno al romanzo sono parte integrante del romanzo stesso, fanno parte della costruzione dell’opera come azione. L’obiettivo che a me pare principale è proprio questo mettere a lavoro un collettivo. Velio lo fa nella consapevolezza lacaniana dell’impossibilità dell’insegnamento come proposta di un sapere rotondo e tutto pieno e, proprio in virtù di questa impossibilità, ciò che diventa indispensabile è l’apertura generata dai vuoti di comprensione immediata. Scrive Velio nell’Invito: “Alla dispersione pulviscolare degli eventi dell’esistenza da cui le prose muovono, tenta di contrapporsi la spinta a un orizzonte di senso che genera sull’insieme effetti d’eco” (p.5); trasformo, alla luce di quanto scritto sopra, che alla dispersione pulviscolare delle nostre singole esistenze, si tenta di contrapporre un orizzonte di senso che sembra un eco perché viene dal passato ma si diffonde nel presente, perché forse labile come una voce lontana ma anche sorprendente come il fascino di un suono che “riaccende […] energie che credevamo ormai spente” (Sulle domande del lettore, p.165). Colgo nel testo allo stesso tempo il desiderio dell’unità di senso che risponde alla frammentazione del presente e che emerge dal bisogno stesso di mettere insieme voci del personale passato, ma anche quello di generare inciampi necessari al lavoro intellettuale per la successiva costruzione di significato. In Lorenzo si legge: “Sempre, a un grado più o meno grande, in ogni atto linguistico soffia e preme la massa del taciuto […] e del non linguistico […], ognuno potentemente concorre al significato, tanto che è sorprendente quanto tutto sommato poco frequente sia prendere fischi per fiaschi” (pp.64-5) e ancora “come e più di chi ascolta in una conversazione, il lettore non è lo specchio del testo […] Leggere non è premere il tasto di una registrazione: è una collaborazione, il suo frutto è il significato di volta in volta assunto dal testo medesimo” (p. 67). Ecco perché l’autore ci invita agli esercizi cinesi sulla quotidiana ginnastica della mente, partendo proprio da una domanda su quali e quante siano le persone con cui avvenga il confronto su noi stessi e sul mondo e arrivando alla desolante risposta: “le conoscenze me le procuro in un modo non dissimile nella sostanza dalle mie escursioni al supermercato” (Esercizi cinesi, p.130). La collaborazione al testo è tanto più sollecitata dai titoli delle voci, appunto nomi a fianco dei quali potremmo trovare anche i nostri: l’autore ci chiama per nome e ci osserva con amorevole cura, ma non sempre la collaborazione riesce, l’insuccesso è esito possibile come nel caso dell’incontro con Ĉigoĉ, talvolta si genera lo scontro dialettico da cui si scappa come dalla vertigine delle parole di Marcello, ma tutto diventa vita. Nei ritratti della prima parte, l’autore ci regala passaggi di splendida poesia che intrecciano insieme il romanzo Domani e il canzoniere Questa notte. Non riesco ancora a staccarmi dalla morte di Gabrio “sembra alla deriva, in lotta inerte con le onde: una rondine infine vi s’apposa e la inabissa, lei volando via” (Gabrio, p.46).
E allora su cosa sono stato soggettivamente messo a lavoro? Gli stimoli sulla scuola e sul rapporto fra formazione critica e addestramento al lavoro sono quelli che maggiormente mi hanno colpito in quanto docente, sebbene i riferimenti ai temi ambientali e del mondo del lavoro non mi lascino indifferente. Delle pagine di Velio faccio mio l’impegno a non cedere sull’attenzione all’uso delle parole; gli acronimi imperanti nel mondo della scuola, la trasformazione semantica di alcuni termini in chiave aziendalistica e liberista, l’uso sempre più fastidioso dell’inglese nella pratica didattica devono mettere in guardia e stimolare in senso opposto. Parole si intitola uno dei capitoli della seconda parte del testo: in esso l’autore ci ricorda che viviamo “in una ragnatela dalla mirabile capacità di trasformare il più individuale e intimo gesto, la parola, nel più astratto e anonimo valore di scambio, dove nessuno parla più a nessuno” (p.147). L’impegno arduo dei docenti dovrebbe oggi essere di far emergere in ogni contesto possibile la parola come esperienza autentica, frutto di riflessione e meditazione e “se la parola che in questo modo esce è ardua, lo sarà solo per la promessa che indica necessaria. Perché ci fa toccar con mano la bellezza che ci si sottrae, ma che ci appartiene quale nostro bene più intimo” (Ai sei lettori, anzi lettrici, p.116). L’urgenza della cura e del valore delle parole emerge dalla sempre più diffusa incapacità dei nostri ragazzi di comprendere testi di media difficoltà e, in modo collegato, dall’afasia sul sé che rende la scena interiore come “notte deserta” (Politéia, p.149). Trasformare la parola in esperienza “è vivere le sfumature, i contrasti, le intermittenze […] per questo non chiedo compilazioni di schede, ma diari di lettura” (Lettere, p.138). Credo che oggi sia provocatoriamente interessante nelle sedi adeguate, come i collegi o i consigli di classe, modificare le parole o le strutture schematiche e preordinate degli strumenti didattici o burocratici che spesso vengono proposti in queste stesse sedi. Ribadire che lo strumento principale del lavoro docente è la passione della parola interna alla relazione umana, da anteporre ad ogni altro strumento tecnico e semplificante, è sicuramente necessario, ma in realtà assai difficile ed ostacolato.
La fotografia che l’autore scatta sulla scuola nata dalla riforma Berlinguer e all’Università successiva alla riforma Zecchino è impietosa: “tutti i rilievi statistici a disposizione segnalano la precipitosa regressione dalla scolarizzazione di massa, conquistata nel trentennio del secondo dopoguerra: abbandoni scolastici, analfabetismo funzionale, inutilità dei titoli ottenuti, ostacoli senza fine – disciplinari ed economici – per chi voglia percorrere alti studi. Tutti fenomeni troppo convergenti e massivi, perché siano dovuti al caso” (Esercizi cinesi, p.131). Il capitalismo finanziario ha costruito e affermato il proprio lessico anche internamente alla scuola e le sue parole d’ordine sono quelle espresse da Velio in Se io oggi sono qui a parlarvi: razionalizzazione, ovvero disinvestimento pubblico, autonomia ovvero frammentazione operata in nome di una lotta contro l’oppressione centralistica, l’individualizzazione dell’offerta formativa che si configura di fatto come sistema di classificazione e stratificazione e soprattutto lo smantellamento dell’orario dedicato all’insegnamento disciplinare in nome della centralità dell’addestramento per competenze.
“Non abbiamo più tempo” (Non ho tempo, p.145), scrive l’autore, sollecitato dalle parole di una studentessa dimentica di una breve certificazione. È giunto “il tempo d’invertire la rotta” perché “il futuro […] è nelle nostre mani” (Se io oggi sono qui a parlarvi, p.157), recuperando il meglio delle esperienze del passato, “una visione complessiva alternativa e una corrispondente capacità di agire in modo coordinato” (Virtù, p.170). A premessa di questo obiettivo serve praticare la centralità del dialogo come esperienza non solo individuale ma soprattutto sociale perché “sono convinto che uno dei modi più oppressivi – perché pervasivo, perché nasce dall’abbrutimento della mente e lo moltiplica – dell’odierna restaurazione antidemocratica è proprio la mancanza di dialogo” (Sulle domande del lettore, p.163). In questa ricerca di confronto un rischio è sempre dietro l’angolo: quello di cullarsi nel narcisistico piacere del cercare chi è come sé, nella trasformazione del cenacolo da luogo di produzione di idee e azioni a luogo di intrattenimento di fatto simmetrico alla minestra imbonitrice dello show business, oppure in recinti nei quali i soggetti “si convincono della verità per il fatto che risuonano della medesima asserzione” (Politéia, p.152).
Grazie all’autore perché in una scuola nella quale i giovani colleghi non hanno mai fatto esperienza della compattezza di un collegio o di un consiglio di classe, nella quale i soggetti, insegnanti o alunni, ‘imprenditori di se stessi’, spesso si muovono come monadi separate l’una dall’altra a causa di una profonda desertificazione e frammentazione del tessuto sociale, la narrazione e la presenza di intellettuali più esperti è come rugiada al mattino. Tenere insieme il completo grigio e l’andatura ieratica del Prof. Attilio, che purtroppo non si fa più trovare, con la forza attiva della giovane Rafaela: questo è l’impegno morale e insieme seducente che ci aspetta in questi prossimi anni.
Ripropongo qui la recensione apparsa sul numero di gennaio dell'Indice dei libri del mese, alla p.31, v.a., 8 gennaio 2021.
Donatello Santarone
La pazienza dei nomi
Le “fughe” in prosa di Velio Abati – scrittore, critico e per molti anni docente di lettere nella scuola superiore di Grosseto – si presentano con un andamento a fisarmonica, alternando e intrecciando ritratti di amicizie per lo più ormai lontane a riflessioni di carattere esistenziale, politico, educativo, letterario. Il titolo, Fughe, non deve trarre in inganno: non si tratta di una evasione dalla realtà verso inesistenti nirvana. Esso vuole alludere da una parte a uno scatto verso un futuro più giusto e vero, a una fuoriuscita dal “delirio d’immobilità” mortifero a cui il capitale costringe il genere umano; dall’altra richiama, attraverso il lessico musicale, la tensione ritmica della scrittura e la sua potente energia liberatoria e conoscitiva.
Alcune pagine di queste prose, tra le più intense, sembrano uscite dal poliedrico “romanzo storico” Domani che l’autore pubblicò nel 2013 (sempre da Manni) e a cui lavorò lunghi anni. Si presentano come lacerti cristallini di quell’epopea contadina e civile narrata nel lungo romanzo. Ci parlano con la bellezza ruvida di quel mondo, al quale l’autore sente orgogliosamente di aver appartenuto, rappresentato con una sintassi che nomina natura, lavoro, fatica. Lo fanno, ad esempio, rievocando la conquista felice e sofferta della scrittura, come nella “prosa” intitolata Lorenzo: “Il primo piacere è stato nello scrivere. Rivivo nitido – quale, maestro Ciso, fu il tuo innesco, in seconda elementare? – il godimento nel descrivere le lunghe ombre del tramonto sui campi dell’Aquilaia: giorni lenti e attoniti, densi dell’odore di quercia e di cacarelli di pecora, che il pomeriggio menavo al pascolo”.
Molto dense anche le pagine nate dall’esperienza dell’insegnamento, un lavoro da Abati svolto con rigore e impegno culturali e con profonda tensione civile. Un lavoro che egli vede trasformarsi con il tempo in un’attività sempre più soffocata da incombenze ipervalutative e burocratiche. Nella scuola – scrive in un racconto, Raffaela, dedicato a un’antica amicizia ritrovata solerte collega di lavoro – “si era distinto un piccolo gruppo di zelanti, sempre più agguerrito nelle maglie tecniche, sempre più indispensabile, sempre meno avvicinabile (…). Nel frattempo, il nostro lavoro smarriva il senso, costretti a dar conto a domande in una lingua che nessuno aveva voluto o conosciuto, sempre più affannati a riempir carte e moduli e prontuari che precedevano, accompagnavano, seguivano il lavoro che sapevamo nostro”.
A questa deriva tecnicista e utilitaristica dell’educazione, Abati oppone la “pazienza dei nomi”, lo scavo disteso su testi e concetti, l’ascolto degli studenti e il dialogo ininterrotto, la caparbia ricerca di senso nelle cose che facciamo. Come quando fa rivivere in classe la ricchezza linguistica e conoscitiva della Commedia, facendo “auscultare” ai giovani la parola di Dante come antidoto nel presente alla dissipazione verbale e al rumore di fondo: “da questa assenza d’ossigeno – leggiamo in La cartella – che grava nell’aula e nelle case, trova vita e scopo la potente lingua dantesca. Il piacere del testo è per il lettore la messa in esperienza dell’uscita da sé, quella che il pellegrino compie con lui. Il lettore, alunno-docente, passo dopo passo, impara a riconoscere con Dante che il male, con la paura che esso genera, non è assoluto, ma ha un’origine e ha una fine”.
Ripropongo qui la recensione di Ilaria Verdi, apparsa nella rivista on line Poliscritture di Ennio Abate del 5 gennaio 2021, v.a., 6 gennaio 2021.
Ilaria Verdi
La spinta eversiva di Fughe
Victa iacet pietas, et Virgo caede madentes,
ultima caelestum, terras Astraea reliquit.
(Ovidio, Metamorfosi, I, vv. 149-150).
Se nel mito di Astrea, l’avidità e i crimini caratterizzanti l’età del ferro, avevano causato la fuga degli Dei, nelle Fughe di Velio Abati la ritirata non è concepita: le "fughe” piuttosto si pongono come una spinta al cambiamento con lo scopo di combattere quella “ostinata immobilità che germina la disperazione” (La cartella, p.83).
Sono molti i problemi che vengono messi sul tavolo: i rapporti di dominio, il conflitto di classe, l’avvento del finanz-capitalismo, il disvalore delle cose, del lavoro e della fatica. Ciascuno di questi mali richiede una riflessione da parte del lettore così da comprenderne l’essenza e determinarne il suo superamento. Del resto, “la fruizione artistica è un’esperienza e il lettore collabora alla produzione del senso” (Lorenzo, pag.67).
Sono molte le cose che mi hanno colpito del testo a partire dalla sua strutturazione interna: una perfetta alternanza tra narrativa e saggistica, forza descrittiva e continuo interrogarsi. Questa spaccatura in due sezioni -l’una dedicata al racconto, l’altra alla riflessione- si mantiene anche sotto il profilo temporale tanto che il testo corre a due velocità diverse: dapprima (nella sezione Voci) c’è la dinamicità del reale, del racconto e in qualche modo della storia, in un secondo momento (nella sezione Discanto) il tempo rallenta e si ferma alla meditazione critica sul presente. Tuttavia la singolarità di questa struttura bipartita sta nel fatto che le sezioni seppur divise si cercano riconfermandosi da un punto di vista ideologico. Ad esempio, in molte prose Velio si scaglia contro l’ignavia: in A una giovane afferma che “nel tempo della povertà, conta l’essenziale; la pochezza non può essere alibi all’inerzia. [...] Ascoltare nella vicinanza il dolore muto perché diventi grimaldello, una luce che apra la parola, la conoscenza che sfondi lo ‘schermo nero’, spalanchi il futuro” (p.114) oppure in Ai sei lettori, anzi lettrici invita “ad affinare lo sguardo e a far maturare il silenzio [...] la sofferenza che allora ci stringe è la verità della nostra condizione, la spinta a ribaltarla nostra guarigione” (p. 116). Questa presa di posizione non rimane soltanto ideologica, pura riflessione intellettuale bensì la si ritrova viva nella figura di Marcello che ne restituisce una dimensione fisica e soprattutto storica. Alternando la voce corale ad una voce individuale, Velio ci rivela le crepe e le ottusità del presente tramite l’ampio sguardo da intellettuale organico gramsciano, in un’unica vera dimensione temporale che è quella del “presente” fortiniano, una dimensione d’insieme che ha in sé il passato e il futuro.
Come sostiene A. Gramsci in Quaderni dal Carcere non si può separare l’“homo faber” dall’“homo sapiens”, serve “un’intellettualità diffusa, un intellettuale di tipo nuovo non separato per mestiere e appartenenza di classe dal resto della società, ma proveniente da questa e legato alla classe lavoratrice dal compito di costruire attivamente la sua emancipazione” (A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 1975, vol. III, pp.1550-1551). Ed è questo che il nostro fa, “non appende le scarpe al chiodo” (Franamenti, p.134) anzi attualizza questa missione intellettuale tramite l’insegnamento: “Di fronte ai miei alunni so che, in forza del nome per cui parlo, posso tentare di risvegliare in chi ascolta qualche domanda di senso su di sé e sul mondo che ci circonda” (Diari, p.123).
Inoltre, emerge nel testo il valore pedagogico delle cose; Pasolini in Lettere Luterane scrive: “la prima lezione me l’ha data una tenda” (pp.567-569), una tenda che insieme ad altri oggetti rappresenta non solo la cosa in sé ma diventa un segno linguistico in grado di rievocare un mondo intero, nel suo caso quello dell’infanzia borghese. La condizione sociale si riconosce nella carne di un individuo, perché egli è stato fisicamente plasmato dall’educazione appunto fisica della materia di cui è fatto il suo mondo. La stessa concezione degli oggetti come segni linguistici, come simbolo di appartenenza ad una classe sociale l’ho ritrovata in Čigoč: Velio tramite gli attrezzi agricoli che l’anziana signora gli sta mostrando rievoca alcuni teneri attimi della sua infanzia.
Ecco, il significato di ritrovarsi. Io stessa, come tutta la mia generazione, se mi guardo indietro non riesco a farlo, non riesco ad afferrare con mano, a sentire la materialità di qualcosa di identitario: una realtà omologata che si dispiega indistinguibile e al tempo stesso irrefrenabilmente mutevole seppur in tempi brevi. Quelle varie culture particolari (sottoproletarie, operaie, contadine) che anche con il fascismo continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli, in quanto la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole, oggi non esistono più. Ormai l’adesione ai modelli culturali imposti dal Nuovo Potere è totale e incondizionata: “si può dunque affermare che la tolleranza della ideologia edonistica è la peggiore delle repressioni della storia umana” (Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975), un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.
In conclusione, riprendendo il mito di Astrea, possiamo dire di essere nell'età del ferro? Sicuramente sì, ma in modo diverso. Ci rimane la lotta, il valore e la forza della fatica, “questa è la notte in cui ci è dato di lavorare, in gran parte senza sapere e quasi scommettendo su qualche verità che ci sembra d’intravedere” (Franamenti, p.134) soprattutto perché come ci ricorda in maniera quasi paterna Velio, “con Dante si impara a riconoscere che il male, con la paura che esso genera, non è assoluto, ma ha un’origine e ha una fine” (La Cartella, p.83).
Ripropongo qui la recensione di Giulia Baneschi, apparsa nella rivista on line Poliscritture di Ennio Abate del 2 gennaio 2021, v.a., 3 gennaio 2021.
Giulia Baneschi
Il potere della parola
Per me leggere Fughe è stata una vera e propria esperienza. Mi verrebbe quasi da dire di aver compiuto come Dante un vero viaggio: alla fine di questa lettura necessariamente se ne esce diversi, ogni prosa ti permette di costruire un albero di riflessioni. Del resto leggere, scrivere e confrontarsi con altre “voci” è ciò che veramente permette ad ogni individuo e, nel nostro caso, a noi lettori, di testare la famosa “uscita dal sé” senza mai abbandonare un principio di realtà: “non si dà comprensione se non ci si abbandona all’opera, se non si diventa l’opera; d’altra parte non si è in grado di parlare , di riprendere la nostra voce se ad un certo punto non si mette alla porta l’opera” (Politéia, p.150). Ogni prosa di Fughe è scritta con un lessico ricercato, scelto: credo che, oltre alle tematiche trattate, sia proprio questo aspetto linguistico a renderlo un testo interessante, stimolante e di un certo livello. Tant’è che io stessa, durante la lettura, non nego di essere ricorsa all’utilizzo del dizionario. Ed è proprio in questo gesto di ricerca della parola che ho ritrovato la fatica del concetto: saper assegnare il giusto nome alle cose e imparare ad interpretare il mondo circostante senza cedere ad una seduzione di decodifica immediata, quasi sempre imposta dall’alto, è la base dell’acquisizione della capacità di comprensione. È Gramsci che ogni volta ci ricorda che “anche lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso-muscolare, oltre che intellettuale: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo e il dolore e la noia”[1]. I dati statistici ad oggi sembrano però proiettare una catastrofe, vista la regressione della scolarizzazione di massa. Il mondo scolastico, progressivamente abbandonato, non solo da chi dovrebbe governarlo, ma anche da chi dovrebbe frequentarlo, sembra guardare, seduto su una sponda, come uno stoico naufrago, l’incedere del mondo virtuale, ormai osannato. Questi dieci mesi di pandemia, ci hanno reso consapevoli di quanto il digitale sia utile, ma anche di quanto non necessariamente positivi siano gli usi che se ne fanno: basti pensare al dilagare delle fake news e alle loro conseguenze. Simone Weil, filosofa, scrittrice e attivista partigiana di origine francese sosteneva che è proprio il porre “le maiuscole a parole vuote di significato”[2] a generare catastrofi. La deriva, quasi naturale, alla quale sembra di approdare, è quella di una progressiva incapacità di lettura del reale, un credere senza verificare. Il fasullo status di iper-comunicabilità nel quale siamo immersi ci distoglie dal ruolo di corresponsabilità che tutti noi abbiamo nella distruzione della reale socialità: “mi colpisce l’auto-inibizione al dialogo tenacemente praticata nei nuovi mezzi, generati da internet, curvati al monologo” (Sulle domande del lettore, p.164). Diventa per questo sempre più fondamentale il bisogno del confronto e del dialogo critico, mai disgiunti, da una pratica costante di lettura e riflessione. Questo è uno dei più grandi insegnamenti che Velio ha trasmesso a noi studenti: il nostro compito è di continuare a praticarlo come un sapiente esercizio cinese. Come Velio è stato e continua ad essere di ispirazione per noi, Fortini lo è stato per lui in questo. Ricordato come amante della conversazione, per lui “non c’era un termine formale alla sua lezione, ad un certo punto si trasformava in altro […] Via via gli studenti si alzavano dalle sedie finché rimanevano i soliti quattro o cinque. Oramai parlava del suo mondo […] Una volta ci confidò perché non faceva precedere nessuna introduzione al suo corso. Solo la strada percorsa fino alla fine avrebbe potuto spiegare gl’inizi.” (Cartella, p.84).
È insomma continua la sollecitazione, in alcuni casi implicita in altri esplicita, che Velio muove esortando non a giocare ad avere un pensiero critico, ma a costruirlo davvero: è necessario ricordarsi sempre che quando ci si interroga su un’opera, su un autore, su un documento si sta compiendo un’operazione di produzione di senso complessa, che comporta simultaneamente un giudizio sull’oggetto e uno su se stessi. “La meta educativa più difficile è il ricorso consapevole sia alla pratica del lettore implicito che a quella del lettore storico” (Lettere, p. 138). Ciò che ho potuto apprendere durante il mio percorso universitario è che i due più grandi pericoli in cui penso possa incorrere ogni studioso sono il revisionismo e una visione teleologica della storia. È sempre molto facile giudicare dogmaticamente qualcosa che, andando indietro nel tempo, inizia ad avere contorni sfumati; come allo stesso tempo è facile giudicare qualcosa che ci sembra perfettamente chiaro senza avere uno sguardo lungimirante. Lo sforzo interpretativo nei riguardi di una parola, di un testo, di un evento, del passato in generale è da ritenersi autentico se e solo se tiene conto del codice di espressione e del contesto storico di produzione. È solo l’interpretazione storicizzante che in un certo senso può salvarci, l’unico antidoto contro il “mito dell’immediatezza”, che ci farebbe scontare la pena - la stessa dei dannati infernali - di essere costretti alla fissità, perché incapaci di aver trasceso l’immediato, allungando uno sguardo sul futuro. Sarà l’unica a salvarci, anche perché consapevole che il significato e il valore della parola “portano impresso il conio” di chi comanda (Parole p.147). Da qui ovviamente se ne deduce che non esiste una verità con la V maiuscola, esiste la verità storica che per emergere ha bisogno di conoscenza: “la verità non è, se non viene comunicata, se non la si scambia come il pane caldo di forno” (Giacinto, p.78). Del resto della fascinazione e mistificazione della realtà nella quale viviamo, responsabili sono certamente i meccanismi capitalistici, la prosa C’era una volta una piccola città è illuminante a tale riguardo. La critica dura rivolta verso la Repubblica che ha messo in vendita a prezzo modico l’istituto della democrazia, favorendo il libero mercato, la privatizzazione e il “farsi concorrenza tra i cosiddetti imprenditori di se stessi” è la dimostrazione di quanto la storia sia scritta dai vincitori. La risultante non è solo il disinvestimento nel settore pubblico, ma anche la “catastrofe della soggettività” (Franamenti, p.133), l’impoverimento linguistico unito a quello dell’animo. Soltanto il costante “ricordare a noi stessi che la conoscenza è un diritto fondamentale della persona […] non una merce […]” (Attilio, p.26) permetterà “la ripresa delle fila […] per provvedere alla liberazione umana” (C’era una volta una piccola città, p.38). Soltanto la presa di coscienza che anche l’attuale situazione in cui ci troviamo, ovvero una delle prime pandemie da globalizzazione, non sia un problema solo sanitario, ma anche ecologico e umano è la chiave. Potrebbe essere un’occasione importante di crescita se solo riuscissimo a guardare tutti un po' più in là della nostra intoccabile zona di comfort. Grazie di cuore Velio, Fughe, è un vero e proprio breviario: ad ogni rilettura si prova davvero il piacere di una nuova scoperta.
[1] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Gramsci_-_Quaderni_del_carcere,_Einaudi,_I.djvu/509.
[2] Simone Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, Farina Editore, Farina editore 2019, p.25.
Ripropongo qui la recensione di Mario Marchionne, apparsa nella rivista on line Poliscritture di Ennio Abate del 23 dicembre 2020, v.a., 24 dicembre 2020
Mario Marchionne
I sentieri di Velio
Ciò che più colpisce in questo testo così complesso è la densità del percorso linguistico, metaforico, materico. La scelta lessicale, precisa e senza sbavature, si addensa in una sua fisicità che rimanda non semplicemente ai movimenti, ai pensieri, ai vissuti più o meno drammatici delle persone, ma alla complessità del mondo in cui si divincolano: tutto si espande si contorce si frantuma in questa realtà che non è mai astratta, sembra di buttarcisi dentro, anche con fatica, ma sempre con questo nostro mondo che, fortunatamente, non ci consente di estraniarci.
E allora le storie, le “voci" della prima parte si dispiegano ora con la forza del coraggio e del dolore, ora con la ricerca di un senso che, per l'appunto, non è mai solipsistico, ma sempre incistato in un presente vivo, anche se si parla di suicidio. Un presente mai immobile, sempre proiettato faticosamente in un futuro che, col trascorrere delle pagine e delle vicende, sembra intorbidarsi fino a definirsi come una sconfitta quasi definitiva. “Quasi” perché in realtà, anche nella desolazione politica che si evidenzia, le metafore materiche di cui parlavo all'inizio, riconducono le vicende personali e collettive, in ogni caso, alla concretezza di vissuti mai scissi dal magma reale in cui si sviluppano. Mi ha colpito la capacità di utilizzare alcuni momenti espressionistici in funzione non straniante ma di un realismo pressoché assoluto.
Il finale di Gabrio riesce a rendere, secondo me, questi elementi in un rimbalzo continuo tra la durissima realtà rappresentata senza infingimenti e i singoli vissuti, fino allo splendido e commovente finale: “Sembra alla deriva, in lotta inerte con le onde: una rondine infine vi s'apposa e la inabissa, lei volando via”. Gli elementi della natura sono intrinseci all'esperienza di Velio, che riesce a farcene partecipi proprio perché non presentano nessuna giustapposizione ma sono lì, come il respiro o il sorso d'acqua nella gola assetata.
Con Attilio entriamo nel mondo di una scuola che sfugge sempre di più da quello che dovrebbe essere il dettato costituzionale, per ingolfarsi in un processo di aziendalizzazione che tradisce miseramente il senso di una libera interazione educativa, di una ricerca finalizzata sì alla trasmissione di conoscenze ma, soprattutto, allo svilupparsi di un pensiero critico in senso complessivo. Non mi risulta che le aziende, per loro intrinseca necessità, possano permettersi un lusso del genere e allora la figura di un Attilio sempre più sperso e che evapora nel momento dei festeggiamenti per la festa di pensionamento mi ricorda certi personaggi calviniani. È un personaggio struggente, come il sospiro strozzato in gola nell’atto del disvelamento.
C'era una volta una piccola città mi ha rimandato a certe cose di Ascanio Celestini, tra il surreale e il favolistico, da moderno cantastorie ben ficcato in questa realtà sempre più sfuggente ma di una concretezza quasi sfiancante.
Con “Discanto" abbandoniamo la fase più strettamente narrativa e Velio esprime la necessità di aggredire questi tempi presenti, li prende di petto con la consapevolezza di una dolorosa ma, al fondo, forse, soltanto momentanea sconfitta. E allora cerca di ricondurre a un senso lo sgretolamento e le macerie che ci circondano: “il capitalismo è tornato ad essere ciò che da sempre vuole apparire: un dato naturale.” Soltanto che il “dato naturale” di “Voci" con tutta la sua vitalità, le incongruenze, gli scarti esistenziali ed affettivi era quello che si diceva all'inizio, mentre ora l'analisi socio-politica o come ognuno vuole chiamarla, esprime sempre più profondamente la pesantezza della sconfitta.
Che, ripeto, non è assoluta, ancora non è rappresentata dal sale romano nei confronti della civiltà cartaginese. Finché ci saranno le storie e i personaggi così vividamente rappresentati in questo libro, probabilmente la rondine riprenderà a volare.
Beatrice Rosi
Noi non parliamo come lo fa una macchina
L’essere umano non è una macchina e di questo Velio Abati è certo. Non solo perché Fughe lo dice esplicitamente (“Noi non parliamo come lo fa una macchina “p. 64), ma anche perché la forza di voler contrastare lo spavento dello schermo oscuro si legge in ogni prosa. Per questo le parole pesano, se ne percepisce la lunga selezione e cura, si riesce quasi ad immaginare la pressione dell’inchiostro corvino sulla carta, anche nei piccoli tratti, nella punteggiatura. Le pause, i respiri ed i silenzi sono fondamentali: è un libro che richiede tempo, sia nella lettura che nella comprensione, in un periodo in cui il tempo fugge. Così i lettori sono costretti a fermarsi per leggere, per lasciar decantare, ad esempio, la sorpresa di un personaggio che proprio all’inizio di un racconto si toglie la vita: “Marcello una notte decise il suicidio.” (p. 57). Un punto che non permette di procedere senza una pausa, che costringe a mettersi di fronte all’atto della lettura. Leggere, quindi, diventa un’azione in cui l’autore descrive il suo passato e i suoi pensieri, ma è il lettore a dover far vivere le parole.
In questo modo si può passare da una sezione all’altra del libro, trattando diversi temi: le “piaghe” del capitalismo, la superiorità delle classi dominanti, il ruolo del lettore/autore, la forza di un ricordo, la volontà di formare alla speranza (e non solo), rimanendo con i piedi per terra e imparando dal passato. Insegnare, quindi, vuol dire prima di tutto essere stato e continuare ad essere uno “scolaro paziente”, intento a comprendere, annotare, imparare con ardore (p. 106), proprio perché “Tutto appare conosciuto, ma nulla lo è” (p. 105).
Nella Cartella della vita non può mancare un libro di storia per evitare di cadere nelle fughe già esperite, un giornale per non fuggire dal presente e un’opera che riesca a donare speranza senza precipitare in un’utopistica armonia (perché non proprio una fuga[1]?).
[1] «In musica, componimento in stile imitativo, nel quale un tema principale (soggetto) e uno o più temi secondarî (contrassoggetti) vengono dalle varie voci esposti e poi ripresi entro uno schema diviso generalmente in quattro parti (esposizione, dedicata specialmente al soggetto; sviluppo, in cui emergono gli altri temi; divertimento, su motivi dei varî temi; stretta, dove le entrate delle varie voci, nel soggetto, sono ravvicinate)» (Treccani, voce “fuga”)
21 dicembre 2020
Ripropongo qui la recensione di Tommaso Di Francesco, apparsa nel "Manifesto" del 17 dicembre 2020, a p. 11; v.a., 18 dicembre 2020
Tommaso Di Francesco
Le vite appartate come leva dei giorni
C’è un rimedio al linguaggio impoverito dei troppi automatismi che promettono una comunicazione e una felicità immediate? Un modo forse c’è, faticoso e inedito: misurarsi con le origini sconfitte, con la propria presa di parola per la prima volta, con gli ascolti mancati. E allora dedurne, dentro il vuoto acuminato nel quale siamo immersi da tempo, e certo non solo per effetto della pandemia «grandangolo del presente», le restanti possibilità di intervenire e trasformare la realtà data.
È quello che Velio Abati propone, sommesso e gentile, nel suo libro Fughe di racconti, paesaggi, metafore, appelli (Manni editori, pp. 171, euro 17) uscito in questi giorni. Non siamo fatti in serie, suggerisce l’autore, dunque solo un attraversamento che faccia della memoria il grimaldello al presente della nostra vita ci può salvare. La memoria delle singole vite, una per una, in primo luogo dei dimenticati, di quelli inavvertiti o solo incontrati per caso e per occasione, percepiti in un angolo nella loro indecisione a consistere. Così eguale alla nostra.
Ecco che allora emergono dall’ombra figure inconsapevoli di avere lasciato una traccia indelebile nella formazione degli altri. Il percorso trova i nomi nella prima parte del libro, quello delle Voci. Ecco allora che tutti i nomi evocati per ogni racconto corrispondono a scoperte vere e proprie, diventano fiaccule: come le parole perse di Fantòn, l’autorevolezza fuggita di Attilio, l’impossibile imitazione di Gabrio sospeso tra lo scherzo fraterno e la scelta di continuare l’eredità politica dei padri, Livia che voleva esserci il meno possibile, la leggerezza passeggera di Ruth, Marcello che una notte decise il suicidio per una morte che, a differenza della sua vita, arrivò in un baleno; e tra tutti Lorenzo probabilmente il «cuore» del libro -, il cantore autodidatta di romanze, che lascia un insegnamento decisivo: la scrittura nasce analfabeta e inventa la sua grammatica, non si alimenta solo di segni ma della passione di scoprire prima ancora di quella di comunicare e di avere ascolto istituzionale, quello apparecchiato per assicurare una volta per tutte «l’assenza di un destinatario in presenza»; «A chi cantava mio nonno – s’interroga nel racconto l’autore - le romanze che a un certo punto principiò a comporre, mentre badava le pecore e le capre dietro le siepi?». Appare dunque nella rivisitazione dei personaggi eletti, una litania di profili incerti che tornano a vivere e a popolare i luoghi di questa stagione arida di percorsi alternativi. Sia che si tratti di attraversare la geografia dei conflitti, come per la Palestina occupata e costretta nella sua ostinata e inascoltata resistenza o di attendere l’arrivo di cicogne che potrebbero non tornare più nella croata Čigoč, dove pure la guerra intestina nazionalista è passata e ha «vinto», cancellando anche le tracce del naturale internazionalismo degli uccelli.
Da dove fugge l’autore? Dalla manipolazione del presente che s’accompagna alla cancellazione del passato, a cominciare da quello più prossimo – ricorda il «padre» Fortini -, e dalla scrittura considerata come stanza chiusa delle meraviglie, che viene preservata privatamente come acquisita ed esclusiva bellezza e godimento. Noi però, non parliamo né scriviamo «come le macchine». Questa spia di coscienza introduce alla seconda parte di Fughe, al Discanto, che intreccia gli avvenimenti con i testi classici dati, distillando analisi e ricordi, aprendo al lascito di consapevolezza, perfino di nuova teoria. In un modo che meta-racconta denunciando il «compiacimento letterario». Perché non può esserci nemmeno la forma del compiacimento che per l’autore rischia di essere vissuto come impossibile isola assoluta sulla terra. Il tutto in una costante quanto vicina presenza della natura, avvertita e difesa nei suoi bagliori e profumi prima di essere stravolta. Il testo a questo punto si dipana non più attraverso i nomi delle persone conosciute in carne ed ossa, ma in una originale elaborazione di apparati critico-interpretativi su scritture e scrittori, a volte conosciuti anche loro «in carne ed ossa», oppure nell’esercizio, personale e didattico, della lettura. Partendo da sé.
Per chi di mestiere insegna a scuola, «lasciare di sé» è il compito più gravoso se preso al di fuori delle misure e dei limiti istituzionali. Perché la società nella quale viviamo è ormai «senza pensiero» e l’epoca residua è «senza tempo». In Non ho tempo Velio Abati, con Il Manifesto del 1848 alla mano, scrive: «…è l’inversione dei tempi tra produzione e distribuzione: il capitalista ha dovuto prima pagare i fattori della produzione e poi far produrre. È in quell’originario consumo di un frutto futuro il motore della presentificazione in figura dell’avvenire, inghiottito dalla dilatazione del presente. È da quella genesi permanente la progressione ossessiva che divora oggi ai nostri figli terra, acqua, ossigeno, che alimenta il buio delle nostre vite…». Così, come nella migliore letteratura che ha colto il passaggio delle epoche del mondo, quel che si rivela nelle Fughe, parola dopo parola, è il rumore del tempo. Così, con l’attrezzo di una scrittura da scavo per materiali terragni di risulta, che assomma lo spazio letterario dentro le opere dei giorni e si trasforma in diario, si rinnova il tentativo di rompere lo «schermo nero» che abbiamo davanti, «da tempo» ridotto alla forzatura, agli «obiettivi storici» del sistema delle merci nel quale a stento sopravviviamo. Ci resta un compito, suggerisce l’autore, necessario ma disarmato: ascoltare il dolore, anche quello più muto.
La seguente lettera di Massimo Parizzi è apparsa anche sulla rivista on line Odissea di Angelo Gaccione, v.a 21 dicembre 2020
Massimo Parizzi
"Leggere le tue Fughe mi ha fatto piacere, anzi, mi ha fatto bene"
Caro Velio,
leggere le tue Fughe, come ti ho già scritto, mi ha fatto piacere, anzi, mi ha fatto bene. Più di una volta, durante la lettura, mi sono ritrovato a dire a me stesso: finalmente! E ad avere l’impressione di respirare meglio. Può sembrare strano, considerata la parte importante che, in tutte le prose, anche se in misura maggiore o minore, svolge il duolo. Per lo stesso motivo può sembrare strano accorgersi, al termine della lettura, che i personaggi di questo “romanzo”, persone, natura, arte, sono tutti personaggi positivi, o che rende positivi l’amorevolezza con cui ne scrivi (amorevolezza che arriva all’identificazione, come dire “tu potresti essere me e io potrei essere te”, o meglio, “tu sei me e io sono te: “Una minuscola manciata di decenni addietro eravamo il medesimo bambino”, Ĉigoĉ). Ecco i “buoni”: uomini e donne, natura, arte. E i cattivi? Non ci sono. Cioè: c’è, fin dalle prime pagine, il capitalismo, nei vari nomi, forme ed effetti che lo individuano. Però non è un “personaggio”, è uno sfondo che, tuttavia, non sta in fondo, ma davanti, a sinistra, a destra, e soprattutto sopra i personaggi, a premerli, schiacciarli. Ma, loro, restano positivi: i buoni. Ecco cosa fa da contrappunto, e contrasto, al duolo.
Poi, ho ritrovato in questi pezzi un’amica/nemica con cui avevo già cercato di fare i conti leggendo Domani, la difficoltà della tua narrativa, che viene tutta da omissioni. Non c’è regola delle cinque W che non violi: who sono “quelli che per un attimo avevamo pensato di raggiungere, spalla a spalla” e che “erano d’un tratto sbalzati via, per sempre imprendibili”? Why la “consuetudine” del prendere appunti in un “minuscolo taccuino” è “a volte temibile”? What “chiudemmo in onore dell’ospite”? Ma perché in realtà io, come lettore, vorrei sapere queste cose, se tu non vuoi dirmele? È chiaro, per avere tutto sotto controllo, chiudere il libro, spegnere la luce e addormentarmi tranquillo. E tu non vuoi che m’addormenti tranquillo. Le omissioni più “gravi” riguardano però lo when e lo where. Come in Domani, anche se qui molto meno, salti allegramente (o dolentemente) da un luogo all’altro, da un tempo all’altro.
A me sembra che il tasso di omissioni potrebbe essere minore. Ma, comunque, che senso hanno? M’è parso di capirlo: è questo, mi sembra, un caso esemplare di testo che non “dice”, ma “fa”, com’è pregio di tutte le opere letterarie vere. Il lettore, leggendo, non si limita ad ascoltare, ma fa un’esperienza, quella che il testo gli impone (come d’altronde dici benissimo tu stesso in Lorenzo). E che cosa gli impongono quelle omissioni? Be’, la rinuncia alla pretesa “reazionaria” dell’“immediatezza” (di cui parli in La cartella) e alla “strumentalità immediata” (Lettere), certo, e anche di “piegare il piacere letterario alla funzione d’inciampo al già saputo” (Marusca). Ma soprattutto, secondo me, gli impongono un movimento omologo a quello necessario per individuare, e riconoscere, “un bisogno antropologico che da qualche parte attende ancora di diventare realtà” (Congedo). Come se quelle “menomazioni” del testo, quello che nel testo “non c’è”, “ci sfugge”, “ci è sottratto”, addestrassero le stesse capacità dello spirito che occorre mobilitare per cercare «ciò che non c’è, che ci sfugge, che ci è sottratto” e che “si cerca perché è una nostra menomazione” (Sulle domande del lettore). “Un bisogno antropologico”: sì.
Un altro punto: la tua scrittura. È alta, e qualche volta m’è sembrato che scivolasse nel “letterario”, non nel senso migliore del termine: quanti “stradelli”! E il gallo “sorvegliatico” (i potenti mezzi, Google insomma, mi dicono che condividi questa parola con Carlo Invernizzi, poeta milanese, e nessun altro), la tavola “imporrita”, i rami “trascorsi”… Ma, certo, in qualche modo è necessario prendere nette distanze dalla “chiacchiera imbonitoria” (Diari). E soprattutto è necessario creare una cadenza, perché, come scrivi con parole che corrispondono anche alla mia esperienza e condivido in pieno: “Basta accompagnare una cadenza, per sentirne il valore, ben prima di comprenderla. È proprio quella promessa, anzi caparra che chiede la fatica dell’ascolto, sempre” (Marusca). La tua scrittura la crea, una cadenza. Come t’ho scritto, ho riletto qualcuna delle prose, e credo che le rileggerò tutte, ma non soltanto per capire meglio: perché non ho voglia di separarmi troppo presto da quella voce, è una buona compagnia
Un altro carattere di Fughe che m’ha fatto pensare “finalmente!”, e respirare meglio, è il coraggio con cui miscela narrativo e saggistico: c’è stato un tempo, lo sai, in cui in nome dell’unità dell’essere umano anche la separazione fra i generi letterari è parsa dubbia (com’era parsa dubbia a generazioni più antiche, ma in nome d’altro). Ora ovviamente quel dubbio, se qualcuno mai vi accennasse, verrebbe chiamato “ingenuità”. E tuttavia è esattamente il contrario: è la consapevolezza che, se la divisione in generi è comoda e ha una lunghissima storia, è anche ingannevole; presume e quindi crea o fortifica all’interno del lettore e all’interno della scrittura divisioni che, almeno nel profondo di entrambi, non ci sono. Secondo me si può legittimamente (anche se un po’ provocatoriamente) considerare Kant un grande narratore e Proust un grande saggista: “In ogni atto di parola palpita la vita”.
Ma non voglio concludere queste minime osservazioni senza elencare, soltanto elencare, qualcun’altra delle tue parole che hanno suscitato in me un sentimento di adesione piena: certo, “mai lo scacco può annullare la verità che a una generazione sia capitato di additare”; “l’opera costruisce e quindi sceglie il proprio lettore”: è verissimo e fondamentale; “sempre, nella mia vita, mi ha accompagnato un istinto di lontananza da quello che i cristiani chiamano ‘mondo’”: questo potrei davvero scriverlo anch’io; “le classi subalterne sono tornate plebe”: sì, ahinoi; “la logica economico-sociale che ha svalutato l’istruzione… è la medesima che ha travolto la distinzione tra cultura alta e cultura bassa”, nonostante che non siano pochi i nostri “compagni” che, in nome di una democrazia a mio parere male intesa, plaudono alla fine di questa distinzione.
Infine, un aneddoto: la storia della quindicenne che, in Sismografi 2, sogna “i milioni” mi ha ricordato una mia esperienza. Non ho mai insegnato, ma da qualche anno collaboro da volontario a un doposcuola per bambini delle elementari, in stragrande maggioranza di famiglie non italiane. Sei anni fa “avevo” un gruppetto di bambini di quinta elementare e, alla fine dell’anno, congedandoli, ho detto: “Voglio farvi un augurio. Vi auguro di non diventare ricchi…”. Puoi immaginarti il putiferio (che d’altronde volevo): “Ah… che bell’augurio ci fai!”, “e i tuoi occhiali come li hai comprati?” eccetera eccetera.
Un abbraccio,
Massimo
15 dicembre 2020
Giuseppe Mainardi
Avvicinamenti a Fughe 2
In forma di lettera
Quarto avvicinamento.
I fondatori di discorsivitá costituiscono una categoria di autori di lingua scritta o parlata che hanno saputo delineare una corrente espressiva con caratteristiche linguistiche e tematiche. Quale fedele lettore di Foucoult mi piace parlare in questi termini specifici piuttosto che di generi letterari, attribuendo alla " discorsivitá" una categoria da esplorare. Partendo da questo presupposto, credo che tu abbia fornito un tuo contributo personale al racconto che hai proposto in Fughe. Contributo sul piano linguistico ricco di possibilità e espansioni. Nel contempo una scelta di campo sulla linea dialettale matura e consapevole, sulla stessa traccia di altri autori quali Pasolini, Buttitta, Loi e altri. Condivido questa scelta che considero una risposta a forme linguistiche attuali prive di identità e impoverite da vuoto morale e culturale. Riconosco nelle parole una voce e un pensiero, assieme a altri, da cui prendere spunto per soluzioni future. Un saluto
11 dicembre 2020
Ripropongo qui la lettera di Maria Jatosti, apparsa sulla rivista on line Odissea diretta da Angelo Gaccione, v.a. 29 novembre 2020.
Maria Jatosti
Una lettera su Fughe
Caro Velio,
in questo diffuso stato di attonita sospensione, in questo tempo strano sfuggente e insieme plumbeo, che tarpa il respiro toglie l’aria ai pensieri e ti cunnola in una torpida parodia di normalità poco più che animale, tra un inabissamento e una forzosa riemersione, mi dispongo finalmente a scriverti queste due righe spero non troppo stralunate.
Prima di tutto grazie. Ho dovuto/voluto aspettare un po’ per leggere il tuo libro. Ero sprofondata nella fascinazione di una grande storia raccontata in prima persona da una sorta di matto di paese, che matto non è per nulla, e il paese essendo un luogo che conosco e che mi è caro, bellissimo antico e arioso, prodigo di artisti e di poeti e soprattutto di amori e di amici dell’anima, di mattie belle di quelle che ti riportano alla felicità della vita. Un bel lavoro, un grande libro che mi ha immerso prepotentemente, con la forza di un’affabulazione allucinata ma trasparente, nel grande racconto della nostra storia di noi tutti di questa parte di mondo e di questa umanità così malconciata e derelitta che l’avidità di ingordi dominatori satrapi e sciacalli e il servilismo di biechi accattoni e loschi gazzettieri ha deprivato perfino dell’urlo della disperazione. Un’esperienza dello spirito densa, felice, stimolante e benedetta nel panorama di questi giorni oscuri e limacciosi.
Terminata la corposa lettura del “fiommista” Liborio[1] senza soluzione di continuità temporale e emotiva mi sono ritrovata in un altro incantamento, braccia nude, occhi e sensi spalancati a nuotare nelle acque mosse e rigeneratrici del tuo mare gonfio di ragionamenti riflessioni riferimenti dissertazioni filosofiche allusioni scotimenti chiamate alle armi propedeutici esami di coscienza, pungenti memorie di eroiche e sperperate stagioni di vita e di lotte, vittorie e batoste cocenti, epifanie e catastrofi bellezze e orrori di una storia pubblica e privata. È stato bellissimo. E dunque grazie caro Velio. Per la condivisione lucida e appassionata per la perfetta adesione allo spirito e spesso alla lettera che ho provato leggendoti. Ci sono momenti, passaggi, intere pagine in queste tue Fughe, che io, comunista senza classe e senza partito, con un po’ di spavalderia, una punta di egoismo e molto narcisismo, ostinatamente ancora “in cerca di nuovi compagni contemporaneamente resistendo […] all’entropia degli abbandoni di quanti della nostra parte abbiamo incontrato” - vedi in particolare là dove evochi la storia, la vita del partito, il fervore giovanile, le domande, le delusioni, le prese d’atto - ho sottolineato e sottoscritto con effusa commozione, complice probabilmente una strabordante emotività senile. Di tutto questo e altro ti dico grazie. L’altro è dove irrompono luminosi squarci di una nomenclatura cara e dolce e antica e spuntano struggenti malinconie di volti, presenze, personaggi, ritratti - bellissimo quello di Ruth - amori, primavere, ragazze meteore, sogni… E dove, caoticamente assemblati come in un quadro di Mirò, vagano immagini o singoli oggetti di memoria: un albero (era un noce o un leccio?) una casa di campagna un ragazzino gentile un salone una tavola imbandita il canto di una cincia lo starnazzare di un pollaio sul retro gli attrezzi della terra nella rimessa di babbo V. il suono di una fisarmonica una canzone Tutti ti dicon Mà…La nostra Maremma, la bicicletta di Maria Pia al mare dell’Uccellina, l’apparizione di un cervo sulla strada sterrata, il giardino intelligente dell’Alberese, la casa di Biancamaria Frabotta, e poi quella città, quella scuola, quelle strade, quella miniera, quelle chiacchierate, quei silenzi, quelle confidenze turbate, quei sorrisi, quelle complicità... Il sapore dolce dell’amicizia…
Grazie Velio.
[1] Remo Rapino, Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, Minimum fax, Roma 2020.
Roma, 26 novembre 2020, Anno I della Nuova Peste
Ripropongo qui l'intervento di L. La Porta, apparso sulla rivista on line Odissea diretta da Angelo Gaccione, v.a. 28 novembre 2020.
Lelio La Porta
Riflessioni su Fughe
“…aliquid quo non consuevimus uti, quod nos adventu possit temptare recenti (…qualcosa a cui non siamo avvezzi, che possa farci ammalare con l’improvvisa venuta”[1]: è la constatazione di un fatto, della pandemia della quale mai avremmo voluto sentir parlare e che, invece, piomba con la sua devastante espansività nel nostro quotidiano. Di certo Velio ha iniziato, come fa presente nell’Invito, a scrivere le sue riflessioni molto tempo fa, quando il morbo ancora non infuriava, anzi quando di esso neanche si poteva immaginare l’essere. Oggi quella situazione di partenza è superata dai fatti e le Fughe si presentano come una contrappuntistica meditazione su questo tempo e questo mondo. Pensavo al titolo mentre leggevo i racconti: nulla spartisce la fuga di Velio con quella suggerita quasi mezzo secolo fa da Henri Laborit. Nel francese quasi lo spavento di fronte alle cose del mondo, qui, nei racconti di Velio, lo sconcerto di fronte al mondo che non giunge alla ripulsa, al rifiuto, allo spaesamento bensì si colloca nel solido terreno di un disincanto quasi scellerato nell’ansia di ricercare, fra Voci di donne e uomini, come nella prima parte, oppure fra lo sterminato vocabolario del non canto della politica e di un’esperienza vissuta su più fronti, fra un ricordo di Fortini e una terzina di Dante, la solidità di un dire che è anche un fare, l’amara, seppur non definitiva, consapevolezza che “la merce … è libertà” (p. 139). Eccola la parola-chiave, anche se affidata ad uno dei racconti più brevi di tutto il volume (superato in brevità da Congedo nel quale l’amore per l’insegnamento si traduce nel recupero di un verso famoso dell’Internazionale nel quale si fa riferimento alla futura umanità); spesso è proprio la brevitas a dare il segno più tangibile di ciò che si vuole dire. Dunque, la libertà.
La vecchia nutrice di Fedra nella omonima tragedia senecana, in serrato dialogo con la sua padrona, a quest’ultima ricorda che qualunque cosa la sorte le serberà come conseguenza delle sue parole, nulla per lei avrà significato di gravità in quanto “fortem facit vicina libertas senem”. La sentenza della nutrice ha, di solito, due traduzioni: “Il coraggio dei vecchi è libertà che si avvicina” e “O vecchiaia, la libertà vicina ti fa forte”. In entrambi i casi il significato profondo della proposizione sembra abbastanza chiaro: chi si avvicina alla vecchiaia, o è già nella vecchiaia[2], sente la libertà, garantita da un tempo minimo ancora di vita, come un bene da poter coltivare con assoluto disincanto. In quel tempo chi è vecchio tutto si concede nel giudizio e nel ragionamento. D’altronde la certezza della fine che si approssima assicura a chi è vecchio una libertà di parola e di movimento che i più giovani non hanno, anche in virtù del calcolo delle occasioni che la vita può ancora offrire loro e che giudizi, tanto coraggiosi quanto imprudenti, potrebbero mettere in discussione. Quindi, nel ragionamento di un insegnante ormai lontano dal servizio per raggiunti limiti di età (stato che chi scrive condivide con Velio) non è la merce ad essere libertà, non il denaro e il suo uso rende liberi, non il consumo e le sue aberranti applicazioni rendono liberi, nell’ottica di “una società senza pensiero” (p. 131), ma la libertà è tale in quanto libertà pensata e agita.
Gli anziani (cerco di capire quanto scrive Velio a proposito del rapporto fra anziani, ossia insegnanti, nel caso specifico, e giovani, cioè studentesse e studenti), i quali godono, stando alle parole della nutrice di Fedra, di una condizione di compiuto disincanto, che sono stati i maestri, e poi i giovani, che hanno appreso da quegli anziani, non infuturino il loro apprendimento nelle forme del dominio bensì lo propongano come dirigenti al fine di non rendere insuperabili le crisi facendone un elemento consolidato. Non bisogna aspettare, come il Candido di Voltaire, che si manifestino terremoti, epidemie (cosa che è avvenuta nei modi terribili che ci ha proposto il Covid 19) e guerre per prendere atto che c’è in corso una crisi che va risolta senza demandare al futuro la sua soluzione. Questo non è il migliore dei mondi possibili; è quello che è. E il disincanto compiuto degli anziani, dei vecchi, può contribuire al raggiungimento della consapevolezza che la prima fase dell’acquisizione della libertà come cardine intorno al quale ruota intera la nostra vita passa attraverso l’acquisizione del fatto che noi siamo natura; il nostro essere natura nella natura non ci costringe né alle forme più deteriori di determinismo o di necessitarismo, né alla convinzione che la natura sia un semplice “altro da sé” superabile nella forma superiore dello spirito assoluto o dell’idea. Come “essere” nella natura, l’uomo libero a nulla aspira di più che alla “dilectio mundi” o, per dirla alla maniera di Spinoza: “Homo liber de nulla re minus, quam de morte cogitat, et eius sapientia non mortis, sed vitae meditatio est”[3]. Il vecchio coraggioso e totalmente libero, avendo meditato su come ha vissuto la vita piuttosto che su come debba affrontare la morte, lascia alle generazioni che verranno quest’ultima indicazione di metodo intorno a cosa sia da intendersi per libertà. Scrive Velio: “…chi incontrerà la mia parola, lo farà nelle intermittenze della chiacchiera imbonitoria, dello spettacolo triviale, degli assilli incomponibili del giorno, nelle solitudini affollate, nell’insensato travolgimento della vita” (pp. 122-3): questa è l’inautenticità del non essere se stessi, è il contrario della libertà. Se non si è questo, si è liberi e le parole, anche se pietre, giungono all’orecchio come ammonimenti lievi e facilmente accettabili. E con il richiamo alla libertà fa il paio l’insegnamento della speranza che “se è una necessità primaria, non vive senza alimento” (p. 83). Quindi la speranza non è un apriori astratto, è una necessità e, come tale, deve essere alimentata: quale l’alimento della speranza se non la cultura, la letteratura, l’amicizia, la filosofia? E non è forse speranza “l’eroismo del gracile gigante sardo, che dal buio del suo carcere scrive le pagine più straordinarie e lucide sulla storia nazionale italiana e sui compiti del proletariato” (p. 134) für ewig?
Mi colpisce, quasi mi inchioda, nella sua anche grafica peculiarità rispetto al tutto (ricorda il modo fortiniano di distinguere e mettere in evidenza alcuni versi specifici dal contesto con l’uso degli spazi bianchi), l’ultima riga del racconto Non ho tempo; suona nel modo seguente: “Non abbiamo tempo” (p. 145). Ritmo della vita accelerato, affanno della rincorsa alla soluzione di quotidiane ossessioni, il lento ma inesorabile consumarsi del presente nell’orgia della ricerca del benessere ci fanno dire che non abbiamo tempo. Il tempo, e lo spazio. Scriveva il “gracile gigante sardo” alla cognata Tatiana, il 1° luglio del 1929, mentre rifletteva su come un detenuto possa trascorrere il tempo: “… il carcerato si sdraia supino nella branda e passa il tempo a sputare contro il soffitto, sognando cose irrealizzabili …”[4]. Ma aggiungeva che questa per lui non sarebbe diventata consuetudine poiché era tutto preso dal processo naturale in base al quale la sua rosa si stava ravvivando[5] e ciò lo spingeva a prendere in considerazione “i fenomeni cosmici” al punto che “il ciclo delle stagioni, legato ai solstizii e agli equinozii, lo sento come carne della mia carne; la rosa è viva e fiorirà certamente … insomma il tempo mi appare come una cosa corpulenta, da quando lo spazio non esiste più per me”[6]. Nel chiuso della cella del carcere fascista lo spazio è evaporato ma il tempo è sempre più consistente, e il sostitutivo dello spazio è l’eterno ritornare delle stagioni, scandito dal ravvivarsi della rosa, che spinge all’esercizio del tendere verso, proprio come il passerotto posseduto in cella il quale, poiché “conquistava tutte le cime esistenti nella cella e quindi si assideva per qualche minuto ad assaporarne la sublime pace (…) credo che avesse uno spirito eminentemente goethiano, come ho letto in una biografia a proposito dell’uomo biografato. Ueber allen Gipfeln!”[7]. E questo passerotto, descritto con “osservazioni minute e curiose” (p. 115) da Gramsci, è nella mente di Velio.
La dimensione del tempo come uno scorrere incessante e continuo conduce Gramsci alla consapevolezza che non esistano datazioni in grado di porre un limite alle vicende umane; il passato è legato al presente che, a sua volta, è proiettato für ewig: “Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno. Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa (…) essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. (…) Perciò odio il capodanno. Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (…) Ogni ora della mia vita vorrei fosse nuova, pur riallacciandosi a quelle trascorse”[8].
Riferendomi al “gracile gigante sardo” mi ritorna improvvisamente in mente, e per concludere, Congedo (p. 121). Qui Velio fa riferimento alla reciprocità dell’insegnamento, allo scambio continuo fra docente e discente: “…il rapporto tra maestro e scolaro è un rapporto attivo, di relazioni reciproche e pertanto ogni maestro è sempre scolaro e ogni scolaro maestro”[9]. E ciò è ancora più valido nell’attuale scienza dell’educazione che non può arrendersi di fronte alla sfida del senso comune informatico e tecnologico, del quale può acquisire soltanto gli strumenti. Il resto è dura fatica del concetto (p. 83)[10] che si realizza in un lavoro duale (docente-discente) che deve proporre lo studio disinteressato e per sempre, cioè für ewig, come fine e come mezzo non dimenticando mai i due obiettivi principali: “ 1) Bisogna creare gente sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori orrori e non si esalti a ogni sciocchezza (…)[11]; 2) Occorre (…) violentemente attirare l’attenzione nel presente così come è, se si vuole trasformarlo (…)[12].
Insomma quanto di Gramsci c’è in questi racconti che, molto spesso, assumono il carattere aforistico senza mai cedere al tono della sentenza o della chiusura del discorso. Anzi in essi vivo il dubbio riassumibile nelle tre domande: “In nome di chi parlo? ...A chi parlo? ...A che serve ciò che dico?” (pp. 122-3). Domande indiscrete? Forse lo sono più le risposte, anche se soltanto intuite da chi legge poiché non dette, in quanto in esse c’è un fondo di amarezza ma c’è anche la speranza. Insomma, anche qui, il “gracile gigante sardo” ci viene incontro: “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”.
[1] Lucrezio, De rerum natura, VI, 1136-1137.
[2] A tal proposito va ricordata la sentenza di Publio Terenzio Afro nella commedia Phormio: “Senectus ipsa est morbus”.
[3] B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, prop. LXVII.
[4] A. Gramsci, Lettere dal carcere, a cura di F. Giasi, Einaudi, Torino, 2020, p. 385.
[5] Tatiania Schucht, cognata di Gramsci, ricorda che, nel corso di una visita al detenuto nella primavera del 1929, “Antonio mi chiese con insistenza una rosa rampicante, obiettai che non ritenevo opportuno che si facesse un pergolato in carcere, non volendo dovere goderlo [sic], e Antonio rispose che sapeva invece di dovere stabilire mentalmente la sua esistenza per lunghi anni a Turi quindi poteva bene desiderare di avere un rosaio che avrebbe fatto salire lungo il muro, sino alle celle” (T. Schucht, I colloqui che ho avuto, in A. Gramsci-T. Schucht, Lettere 1926-1935, a cura di A. Natoli e C. Daniele, Einaudi, Torino 1997, p. 1438).
[6] A.Gramsci, ivi, p. 386.
[7] A. Gramsci, ivi, p. 131.
[8] A. Gramsci, Capodanno in Avanti!, 1° gennaio 1916, ora in Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, Scritti (1910-1926), vol. I (1910-1916), a cura di G. Guida e Maria L. Righi, Treccani, Roma, 2019, p. 66.
[9] A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1975, 1331.
[10] “Pensieri veri e penetrazione scientifica si possono guadagnare solo nel lavoro del concetto. Soltanto esso può produrre l’universalità del sapere” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, traduzione di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze, 1974, vol. I, p. 59). Il termine “lavoro” traduce il tedesco “die Anstrengung”, che significa propriamente sforzo, fatica. Ma già Virgilio nelle Georgiche (I, 145-146) si era espresso nel modo seguente: “Labor omnia vicit improbus… (Il duro lavoro vince ogni difficoltà…)”.
[11] A. Gramsci, ivi, pp. 2331-2.
[12] A. Gramsci, ivi, p., 1131.
Ripropongo qui l'articolo uscito sulla "Nazione" del 27 novembre2020, in cronaca di Grosseto, p.24, v.a,

Le Fughe di Abati in un colloquio on line
L’ultima fatica letteraria di Velio Abati si chiama Fughe e lo scrittore ha deciso di presentarla attraverso la creazione di un "Colloquio" online, per conservare, seppur a distanza, la convivialità che ha da sempre caratterizzato i "Colloqui del Tonale", rassegna culturale organizzata dall’autore a partire dal 2012. L’evento si terrà oggi, a partire dalle 18 sulla piattaforma digitale di Manni editori e vedrà la partecipazione di alcuni ex alunni del professore Abati (Giulia Baneschi, Federica Cipriani, Martina Covitto, Alessandara Franchi, Beatrice Rosi, Lorenzo Scribani, Sara Starnai e Ilaria Verdi), che attraverso letture e interventi contribuiranno alla presentazione del testo, condividendo le proprie riflessioni e invitando anche i partecipanti ad un confronto vivace. E affidiamo alla penna di una di loro, Ilaria Verdi, la presentazione di questa nuova opera.
"“Fate quello che potete, rubate spazio all’impossibile”. Termina così Congedo, una delle prose contenute all’interno della terza pubblicazione di Velio Abati, prosa questa dedicata alla sua lunga e appassionata carriera di insegnante.
Dopo la forza del romanzo epico Domani (2013) e la carica lirica del Canzoniere Questa Notte (2018), si giunge così a Fughe, pubblicato ancora una volta da Manni Editori.
Quest’ultimo libro si presenta come una raccolta di prose eterogenee divisa in due sezioni Voci e Discanto: nella prima “parla” la collettività nella seconda c’è la durezza della riflessione intellettuale.
L’intera struttura è scandita dall’alternanza tra narrativa e saggistica, forza descrittiva e continuo interrogarsi. Attraverso le prose contenute in Voci, i cui titoli corrispondono ai nomi dei protagonisti messi in scena, l’autore descrive momenti della sua vita fatti di volti e memorie, impressi come “fotogrammi” di cui non si spiega molto; rimangono sospesi, tuttavia si intuisce che per qualche motivo hanno giocato un ruolo relativamente importante nella sua formazione di intellettuale e non solo.
E se il tempo sembra correre veloce in questa prima sezione del testo, nella seconda, che porta il titolo di Discanto, sembra fermarsi alla meditazione critica sul presente, così da rivelarne le “crepe” e le ottusità tramite l’ampio sguardo da intellettuale organico gramsciano. C’è insomma in Fughe – chiude così la sua riflessione Ilaria Verdi – un’unica vera dimensione temporale che è quella del “presente” fortiniano, una dimensione d’insieme che ha in sé il passato e il futuro".
Giuseppe Mainardi
Avvicinamenti a Fughe
In forma di lettera
Primo avvicinamento.
Penso che tu sia riuscito a evitare nei racconti la formula del bozzetto, creando figure credibili con una dimensione interiore molto chiara. Forse sono condizionato da letture del passato, in ogni caso avverto la singolarità del romanzo americano di ambiente rurale. La prosa ha una forte impronta poetica, sebbene talvolta assuma la curvatura argomentativa, che non offusca però il valore delle riflessioni.
Secondo avvicinamento.
I personaggi che hai delineato con sapienza linguistica hanno una efficacia che mi ha colpito. Fanton è a mio avviso il segno della tua esperienza umana nella fase aurea della adolescenza, quella del confronto e della contraddizione. A suo modo è un personaggio tragico, come altri impegnati fra la formazione cattolica e gli studi con Badaloni. In un ambiente in cui la vita non era facile. Sono belli e convincenti i tuoi personaggi come Giulio, Marcello e altri. La gente tua" campagnola" come dice Ungaretti, cui sei legato nella definizione iconica e soprattutto linguistica. Hai una attenzione per loro che nasce, credo, dalle tue radici che divengono in questo modo sempre più forti e reali, energia per l'essere. Le parole hanno la forza del legno e possono divenire oggetti, tu stesso lo dici. La seconda parte, Discanto, è il segno, la testimonianza che comunque trovo lucida, vigile. L'arco della tua testimonianza comprende il momento attuale, certamente difficile. Un buon libro di Magris include nel titolo stesso l'utopia e il disincanto, forse un passaggio doloroso ma il tempo attuale ne impone l'analisi. La poesia e la prosa poetica che adotti offrono comunque soluzioni. Lasciami ancora un po' di tempo perché altre riflessioni possano sedimentare.
Terzo avvicinamento.
Avverto da parte tua la vicinanza vera al dramma quotidiano dei palestinesi, simile a quello degli altri "abitanti" delle tue pagine. Il bisogno del poeta di capire e rimanere vicino ai volti offesi viene interrotto dal perentorio "Yalla" che spegne il contatto. Sorte simile a molti personaggi, la cui vita termina con una dissolvenza che non permette appelli. La morte è molto presente nei racconti, una realtà che si ripete impietosa e lascia senza respiro. Il dolore in Maruska assume forme e connotazioni molteplici, quasi un "rivo strozzato", un "cavallo stramazzato". Tu hai rivolto lo stesso sguardo consapevole e addolorato ai tuoi umili di campagna e alle famiglie dei territori palestinesi occupati. Anche io, nelle mie giornate africane, ho provato sentimenti simili per la gente con il volto scarno, ho provato rancore per il sussiego degli impiegati d' ambasciata, per alcuni almeno, arroganti quasi come i colonizzatori di non molti anni prima. Su ogni pagina del tuo libro si affaccia il poeta, nella sua forza compulsiva che trova espressione nella parola, anche nella lingua greca, quella antica. Soprattutto è presente nella incertezza voluta, nelle ambiguità che prende forza dalla suggestione simbolica e dalle metafore. Per adesso ti invio un saluto.
25 novembre 2020
Alberto Cioni
E ora che sul volto finalmente hai le rughe
e decidi di imbastire altre fughe,
sappi, tu autore e tua moglie Mariapia,
che per fuggire dal serale mortorio
tra breve ritiro una copia, la mia,
qui al vicino Auditorium:
allegria!
23 novembre 2020
Giorgio Luzzi
Solidità di prosa-pensiero
Un biglietto per Fughe
Sembra di tornare ai tempi, che la mia rispettabile età può affermare di aver vissuto, della grande prosa. Niente intrattenimento ma tuttavia intensa curiosità circa la direzione che l'autore sta dando all'orologio del mondo. Niente eleganze leziose e pur tecnicamente esperte ma solidità di prosa-pensiero, appunto tra saggistica e narrazione. Ci sono dentro al tuo libro le vicende, ma rimangono come sospese e indecise in senso esistenziale, indecise appunto se narrarsi o commentarsi. Narrare o commentare? Oserei dire che in questo tuo splendido libro noi siamo usati dal linguaggio, o per meglio dire ci prestiamo a fargli da controfigure. Non vado oltre perché temo di sfiorare il paradosso in maniera troppo didascalica, e questo per me non va. Complimenti dunque e soprattutto auspicii di buona e meritata fortuna alle Fughe, libro nel quale non soltanto la marchesa non esce alle cinque, ma semmai fa capolino in quegli interstizi grazie ai quali l'autore confligge con il reale, lasciando al lettore appassionato l'incarico non lieve di distinguere e classificare tra storia e invenzione. Ma anche in termini di storia del linguaggio, il che, per un narratore, mi sembra essere l'apice.
8 novembre 2020
Ripropongo qui il pezzo di Angelo Gaccione, che ringrazio, pubblicato sulla sua rivista on line Odissea.
5 novembre 2020, v.a.
Angelo Gaccione
Il nuovo libro di Abati
Fughe, di Velio Abati, è un libro composito. È diviso in due parti: Voci e Discanto. Voci, che è la sezione più corposa, raccoglie una serie di prose narrative; Discanto, invece, ha un taglio preminentemente saggistico e raccoglie testi che molto probabilmente sono stati in precedenza pubblicati su organi di stampa cartacei o in Rete, a giudicare dal taglio di alcuni di essi che dialogano con lettori e lettrici su questioni di bruciante attualità, anche se l’autore non ce ne indica la fonte. C’è in questo nuovo libro di Abati, il narratore (non si dimentichi che egli è anche autore di un romanzo), c’è la sensibilità del poeta (è autore di varie raccolte di versi) e in queste prose la poesia emerge evidente non solo in certe descrizioni del paesaggio e degli elementi naturali resi vividi e fortemente visivi, ma anche per come ce ne giungono gli echi, il sottofondo di una certa dolorosa nostalgia, il riscatto di un mondo fatto di cose minute, povere, ma rese straordinariamente umane. E poi le tracce di biografie, di volti, di memorie, di radicamenti ad un mondo, a dei luoghi, divenuti parte consustanziale del proprio vissuto e del proprio percorso, della propria coscienza e della propria consapevolezza. E c’è il saggista con la sua intelligenza riflessiva, con il suo interrogarsi, la sua capacità critica, il suo sguardo partigiano sulla realtà. Abati da questo punto di vista non bleffa: mette subito le carte in tavola e vi dice chiaramente come si è situato rispetto ai rapporti di dominio, rispetto alla fatica (che è molto di più del semplice lavoro), al conflitto di classe, all’empietà del finanz-capitalismo come efficacemente lo definisce, che ci sta scavando la fossa fra dissesto ambientale, armi di sterminio e mercificazione di un mondo che diviene sempre più invivibile. Abati, insomma, non dimentica mai che le idee dominanti sono in ogni tempo quelle delle classi dominanti.
La sezione narrativa è concentrata fondamentalmente su figure che la memoria dello scrittore ci restituisce e ce ne rivela, appunto, le “voci”; attraverso brandelli di vita, descrizioni fisiche, episodi non memorabili, ma che hanno un senso umano profondo. In prevalenza sono racconti descrittivi e in cui il dialogo è poco presente. I personaggi appartengono alla vita dello scrittore o hanno fatto parte del suo “sguardo”, a partire dall’infanzia, dalla scuola, dall’ambiente familiare, dal suo percorso politico-culturale, da una stagione di esaltante generosa utopia di cui tanti di noi sono stati parte attiva, fino al ripiegamento, alla delusione, alla deriva. I titoli si aprono con i nomi dei protagonisti messi in scena: Giacinto, Giulio, Livia, Marusca, Lorenzo, Marcello, Raffaela, Gabrio… con i loro piccoli lacerti di vita e dentro un paesaggio amato e poetico insieme. È una sezione in cui aspetti autobiografici ed elementi sociali, oggettivi, si mescolano. Ed è uno sguardo che si allarga ai luoghi del mondo dove l’ingiustizia, la guerra, la morte, i muri, sono di casa (si veda Yalla! con i suoi protagonisti). Perché tutto ciò che ci è offerto come narrativa, non è mai scevro da uno sguardo sociale o morale. Come quella sorta di favola moderna dal titolo C’era una volta una piccola città, e che vede contrapposti gli Alti e i Bassi. Racconto in cui non si fa sconto né al potere economico, né a quello amministrativo.
Ripeto, in queste narrazioni c’è la fatica, il lavoro, la fuga, la condivisione, il sacrificio per mutare la propria condizione e quella dei propri figli; c’è la fedeltà alla memoria come nelle pagine dedicate al poeta fiorentino Franco Fortini, nel testo dal titolo La cartella; e ci sono Dante, Gramsci, Brecht, come ci sono la scuola e la letteratura. Sono temi che la seconda parte del libro riprende e lega come in un filo continuo, anche se questa volta in maniera più riflessiva, filosofica, critica, perché non vi è cesura fra gli scorci di una natura colta poeticamente e una natura ferita, violata, saccheggiata. Il sentimento è lo stesso, sia che si tratti di adesione amorosa, sia che si tratti di indignazione civile per come l’abbiamo ridotta. Il grido d’allarme ha la medesima efficacia, si tratti di scrittura letteraria o di scrittura saggistica. La varietà dei temi affrontati e messi davanti alla riflessione è tale, che ognuno di essi merita un confronto, un approfondimento ulteriore. Cosa che, sono sicuro, il lettore attento non mancherà di fare.
